Premessa.
I poeti che scelgono di situarsi dietro le quinte del palco sociale della poesia obbligano il lettore critico ad assumere un’attitudine paradossale: da un lato, lo forzano a decodificare quel “porsi a margine”, come sintomo costitutivo di un’originalità; dall’altro lato e di conseguenza, in virtù di quella stessa originalità, lo inducono ad adottare la postura trepidante e timorosa del trovatore (maneggiatore) di un oggetto raro, prezioso, e perciò fragile. Il critico teme allora che la propria lettura possa graffiarlo, in qualche modo danneggiarlo, proprio perché prezioso – ne ignora le caratteristiche fisiche, non avendo a disposizione una gamma sufficientemente ampia di altri esemplari che possano fungere da termini di paragone. Eppure, allo stesso tempo, è consapevole della rarità dell’oggetto e del fatto che non può più sottrarsi dal contatto intimo con esso. In altre parole, un poeta che come Carlo Bordini «si impegnò sempre a portare l’autopromozione ai confini dell’autosabotaggio», palesando in questo modo una sostanziale allergia per la strada maestra dell’outing editoriale, dichiara già per questo di possedere la natura di uno scrittore letteralmente straordinario, fuori dalla griglia dell’ordinario. In questo ricorda altre figure a lui contemporanee, come quella di Giuliano Mesa, che al netto dell’automatica “gloria del post mortem”, non furono certo meno incisive, sebbene eccentriche in modo differente. C’è da dire, però, che sia una fortuna che questi poeti diventino a un certo punto istituzionali, come conferma l’uscita per la collana mondadoriana dello “Specchio” del libro Un vuoto d’aria di Carlo Bordini (cosa che non è ancora avvenuta per Giuliano Mesa), a cura di Francesca Santucci e con introduzione di Guido Mazzoni. Altrimenti, il rischio è quello di perderne completamente traccia. È infatti, il più delle volte, proprio il loro “istituzionalizzarsi” che porta, a ritroso, a cogliere l’importanza della situazione opposta, ovvero della precedente scelta di permanere nella fruizione di nicchia, nell’ombra, fino al momento di svolta.
Ma la “straordinarietà” di Bordini non si limita alle vicissitudini della sua storia editoriale, e nemmeno a quelle della sua vita, certamente avventurosa, rocambolesca, ricca di contraddizioni, o di “moltitudini”, ricordando W. Whitman. Probabilmente la sorgente più certa da cui tale straordinarietà si propaga è la personalità, per come nel suo caso si riesce a cogliere nell’esteriorità della scrittura poetica. Si ha infatti l’impressione che tra “l’indole scrivente” e le poesie di Un vuoto d’aria non sussistano troppi filtri – forse ciò accade per l’imprinting dello psicanalitico stream of consciousness già rilevato da Guido Mazzoni, reso del tutto peculiare dall’intonazione frequentemente ironica; o forse accade, nondimeno, per la scelta del lessico assolutamente piano, colloquiale, quasi da sussurrata, chiacchierata confessione, che si apprezza nel libro. Si tratta propriamente della pronuncia poetica che consente a Bordini di arpionare il nocciolo di “iperverità” (da intendere come quel nucleo soggiacente di verità profonda, che di primo acchito sfugge a una comprensione e che emerge nitidamente solo attraverso la scrittura poetica) che si dà, a suo avviso, quale nevralgico punto d’origine e di approdo di ogni arte che funzioni.
Eppure, come sottolinea ancora Mazzoni nel suo scritto introduttivo, quello di Bordini non è uno stile confessionale tout court. Il poeta, pertanto, non sembra affiliabile né alla confessional poetry americana, né al neoromanticismo italiano del secondo Novecento, e neppure alle tendenze nuovamente soggettiviste che si riscontrano nella nostra poesia negli anni Settanta. Non sembrano esserci dubbi, però, sul fatto che si tratti di un romantico, stando alle parole introduttive, qui condivise, di Guido Mazzoni. Se è vero che, come avverte il poeta stesso nella Nota al lettore che precede le poesie, ogni sua opera possiede una coloritura propria, una tonalità distintiva rispetto alle altre, allora certamente il tono di Un vuoto d’aria è il tono della vanità. Sembra infatti che la confessione di Bordini punti proprio, non tanto alla tessitura di un discorso amoroso, per dirla con R. Barthes, come potrebbe sembrare di primo acchito; e che nemmeno punti tanto a riempire un senso del vuoto – quanto a scavarlo, ancora di più: per sondarne, letteralmente, la capacità.
Nel suo libro dal titolo Vanità, il leopardista Mario Andrea Rigoni delucida sulla doppia faccia che la nozione posta a titolo, non sempre intuitivamente, possiede. Da un lato, la vanità va intesa come quell’horror vacui che affligge ogni creatura umana, una volta realizzata la propria impermanenza. Ma dall’altro lato, la vanità altro non è che quel bisogno, ancora tutto umano, di essere visti, quel narcisistico antropocentrismo che, a ben guardare, si origina dal medesimo senso di vuoto. «La storia della vanità è la storia del mondo», scrive Rigoni, motivando la vastità di quest’affermazione con l’accostamento apparentemente paradossale di due termini, il tragico e il frivolo. In altre parole, è «perché siamo nulla che veneriamo dei nonnulla».
Una multiforme duplicità.
Questa premessa potrebbe sembrare un’ekphrasis fuori tema, ma in realtà credo che Bordini, di cui si è detto che ha vissuto due vite, incarni esattamente tale duplicità. Una vita «fuori dal solco» e una vita «nel solco», è stato osservato. Vale a dire, un’esistenza anarchica prima, più conformista dopo. Sono convinta che la duplicità della vita vissuta da Bordini si possa imputare molto, da un lato, alla sua origine borghese, verso il cui versante si orienterebbe l’accezione di vanità come cifra del frivolo; dall’altro lato, invece, alla sua “origine scelta”, quella del poeta, dello scopritore del mondo attraverso il viaggio e la militanza politica – e quindi sì, deriva anarchica e apolide, ma soprattutto rinnegamento delle radici della propria classe sociale. Un conto in sospeso, in soldoni, una vanità da decifrare come solco di incommensurabile distanza tra la vita-vita (frivolo) e la vita-esistenza (tragico):
Quando la fantasia
scopre l’invenzione di se stessa
si stanca
di inventare la realtà
non esistono le ore, non esistono i giorni, l’esistenza e la vita si
confondono.
L’originalità di Bordini, per come essa emerge in Un vuoto d’aria, sta nella particolarissima veste di questa duplicità, che diviene spesso, appunto, una miscela dove non si distinguono più i due elementi (la vita, l’esistenza). Il filo rosso della vanità sembra accentuarsi cromaticamente proprio in prossimità di quei momenti in cui si avvera tale confusione. Vita/esistenza, “fuori dal solco”/“nel solco” (ovvero scelta anarchica/scelta conformista), ma anche serietà/ironia, diventano allora tutti double face di medaglie di analoga fattura. Si veda di seguito un esempio del particolare dialogare delle due facce, che assumono in questo caso il segno del serio, da un lato, e dell’ironico, dall’altro:
Ho baciato una ragazza davanti all’oceano pacifico
diceva che il mare era un grosso amante
un grande dio che ama le donne
diceva che sono un angelo cattivo
che non devo essere geloso del mare.
le finestre dell’albergo mandavano una luce strana
era una ragazza fragile
come può essere solo in un paese cattolico
aveva un cervello febbrile
abbiamo camminato per parchi
in una città con molti prati.
credo che questa poesia sia meglio senza il punto finale.
Si noti come l’ultimo verso imprima una brusca virata, una svolta meta-testuale inaspettata, che ha l’esito di strappare al lettore un sorriso, senza che se lo potesse prefigurare. È l’incursione dell’ironico nel tragico, o meglio, nel (melo)drammatico.
Inoltre, la poesia di Bordini è composita per l’edificarsi di numerosi strati, tra loro spesso in contraddizione. Essi la rendono molto spessa, nonostante la semplicità formale della lingua adottata. Il testo si dà infatti come il precipitato non solo di brame autoanalitiche o funzionali a una rivelazione psichica, ma anche di lezioni filosofico-letterarie che (seppure taciute dall’autore, per quella sua costitutiva ansia anti-istituzione) risuonano riconoscibilissime: Lucrezio, i fratelli Schlegel, Schopenhauer, Leopardi, Bergson. Così, quella «specie di nostalgia» con cui si apre il testo Assenza, ha il talento di riecheggiare, in uno stesso cortocircuito, la sehnsucht dei romantici tedeschi (tanto più che al verso 6 si menziona una dimensione infinita: «come se la presenza fosse infinita e non possa convertirsi in assenza»), la filosofia bergsoniana della durata e la teoria leopardiana dell’attesa del piacere. Anche Leopardi fu un malinconico e un nostalgico, nel suo rimpiangere quella condizione originaria di associazione, ovvero di felice congiunzione, in cui l’uomo fu omologoumènos tè fúsei, per dirla con le parole del Zenone stoico, ovvero «in armonia con la natura e col divino», congiunti «in un solo subbietto, formando una persona sola» (Zibaldone).
Il binomio oppositivo di associazione-dissociazione (cioè, di fatto, un ulteriore modo di pensare la multiforme duplicità suddetta), ha in primis un forte imprinting chimico-fisico e psichiatrico, ed è gestito in un modo che, alla fine, consente di attribuirgli almeno altre due valenze.
Una valenza gnoseologica: come se il meccanico alternarsi di unione e disunione si rivelasse una dinamica relazionale tutta conoscitiva, un ponte tra il soggetto e il mondo grazie al quale è possibile esplorare l’esistente e restarne impressionati, meravigliati:
La vita è associazione
la morte è dissociazione
separazione di sali minerali,
nella solitudine di un orto
separazione scissione scremazione
divisione chimica
[…]
Volevo vedere New York
invece ho guardato Le Città nel mondo
Città nel mondo
viaggiare viaggiare
Le oche che volano
è impressionante la foresta in mezzo ai grattacieli
[…]
questi meravigliosi ponti lunghissimi
ci sono anche i
tramonti
la roma del ventesimo
secolo
Una valenza straniante: in base a essa, la dissociazione diventa invece uno strumento retorico di tipo ironico, tramite il quale l’io poetico si “scolla” (di fatto, si dissocia) da sé, divenendo spettatore di se stesso:
Una ragazza abita in casa mia e dice di essere mia moglie
si comporta come una moglie mi abbraccia dice che mi ama
e assomiglia a una moglie.
[…]
in effetti io mi ricordo che una volta ci eravamo sposati
ma non sapevo che era una cosa che durava tutti i giorni.
Una volta penso un giorno o l’altro ci sposiamo poi scopro
che lo siamo già
La dissociazione, in Bordini, sembrerebbe scaturire da un precedente e totalizzante meccanismo associativo e ne sarebbe la conseguente spinta verso la deriva. Come se la piena immersione nel recipiente della vita, una volta riemersi fuori di esso, diventasse un ricordo insopportabile. Come se diventasse insopportabile sondare l’improvviso vuoto che conseguentemente si impone, tanto da indurre Bordini a teorizzare una “poetica dell’anti-memoria”:
il presente è assente quando [il maratoneta] arriverà [il presente] si distruggerà perché non è ricordo
Il nucleo eponimo del libro: Un vuoto d’aria.
Nella sua introduzione, Guido Mazzoni identifica tre ragioni alla base dell’originalità di Bordini rispetto al panorama dei suoi contemporanei. La seconda di esse (la prima sarebbe il particolare rapporto con avanguardie e modernismo, la terza l’ironia) riguarda il legame che si instaura tra la sua scrittura e la psicanalisi. Scrive Mazzoni, riprendendo una dichiarazione di Bordini («Amo la poesia perché quando scrivo so sempre da dove parto, e non so mai dove arrivo»):
Se si sostituisce il termine «analisi» al termine «poesia» ciò che Bordini scrive in questo passo resta vero alla lettera: anche nelle sedute si sa da dove si parte (la prima parola è del paziente) ma non si sa dove si arriva.
A ben guardare, tutta la sezione eponima del libro è caratterizzata da un andamento di impronta psicanalitica. Si muove verso un’origine. Se nella prima micro-sezione, Pizarnik M, prevale un registro tra il narrativo e quello della confessione di coscienza, nella seconda, Poesie molto ciniche, al di là dell’aggettivo del titolo, che sicuramente conferisce un tenore distinguibile ai testi lì racchiusi, si approda però, anche, a una confessione di coscienza più sincera. Come se il “paziente” in questione, si stesse pian piano lasciando andare. Tale disinibizione è evidente nel testo Quieto vivere e in X:
non ti lascio per quieto vivere
Perfino le cose per cui dovrei disprezzarti mi sono care
e sono troppo vecchio per trovarne un’altra
provo piacere a odiarti
e a dirti che ti amo, e ingannarti è la mia vendetta
*
Mi sto uccidendo. Tra qualche anno non avrò più soldi.
E questo perché mi dedico tranquillamente a una donna,
che tranquillamente senza sapere (meglio: poter) fare altro
mi svena. NO
Ma perché? Perché lo faccio?
Il titolo della quarta micro-sezione, Stasi, si potrebbe allora pensare, riprendendo in parallelo il modello del colloquio psicanalitico, come il momento in cui il paziente comincia a mettere a fuoco il vissuto condiviso, a fissare l’immagine. Non è un caso forse che in questa parte di Un vuoto d’aria compaia la schiera dei fantasmi familiari di Bordini, già anticipata nella micro-sezione precedente, Del dormire, dove è presente un testo dal titolo Questa è una poesia dedicata a mio nonno. In esso la figura del nonno di Bordini è assunta come modello esemplare sulla base, si presume, delle divergenze rispetto all’auto-percezione di chi scrive
Mio nonno non era mezzo
schizoide. Non ha avuto bisogno
di essere
recuperato da uno psicanalista.
I suoi erano errori semplici,
Andare in guerra, morire per la patria
Mio nonno
non era pazzo
e non era neanche
un pazzo mancato
Il secondo testo di Stasi, introduce invece la figura della madre. È interessante come questo testo sia presente nel libro due volte (la sua seconda occorrenza si colloca nell’ultima micro-sezione, Ancora A), ripetendosi identico, quasi all’insegna di un refrain dell’inconscio, che risuona da un lato come una convinta presa di posizione, dall’altro come una realtà insopportabile da accettare. La poesia non ha titolo:
Non ho mai amato mia madre, né
era possibile, dato che
lei non mi amava.
Vi chiederete se posso rimpiangere
la confidenza, la solidarietà,
l’alleanza tra la madre e
un figlio. O se l’ho desiderata.
No. Non l’ho mai desiderata
e, anche, non la rimpiango.
Non si può rimpiangere ciò
che non si conosce.
Non posso rimpiangere (quindi) ciò
che non conosco.
Forse:
che non si conosce. Non
posso rimpiangere (quindi) ciò
che non conosco.
La sezione successiva, La pietà, che consta di soli cinque testi, pare conseguentemente epurarsi dalle circonvoluzioni stilistiche che hanno segnato il libro fino a questo punto. I versi si assottigliano verso una maggiore verticalità e mettono a tema un amore, stavolta, scevro di ironia (dal primo esempio testuale: «forse perché era estate|e avevi un vestito bianco. |forse perché eravamo su- | bito nu- | di | basta che tu dici che non mi odi | uno sguardo distrugge»; da Dell’amare: «Sono abituato a innamorarmi | di donne sognate, | ma adesso | che amo una donna reale | le sogno come un rimpianto | e non so se è amore quello | che vivo o quello che sogno […]»).
Dopo l’intercapedine data dalla penultima micro-sezione, Poesie civili, dove emerge forte un nucleare senso di colpa e di paura, e predomina un tenore stilistico più assertivo, il sogno è recuperato nella micro-sezione di chiusura, Ancora A. Esso assume, in particolare, la veste del bisogno, quello di un contatto in extremis con l’altro, o quello di una trasposizione della propria dimensione finita in un’atopia dove si possa abbracciarne una infinita, e certa. «Ho sognato che ti telefonavo | con un telefono di fiori», scrive Bordini, apostrofando un tu in cui convergono forse la donna amata e la donna non amata (la madre), col quale si invoca un ultimo colloquio, un parlare “leggero”, la cui levità è sottolineata dal riferimento ai fiori e alla primavera («era come un vestito leggero | ornato di primavera»). Sdrammatizzare, abbassare il serio e il tragico diviene qui, allora, non il solito ricorso all’ironia, ma il salto nell’idealizzazione, ai limiti del surreale. Questa virata in mondi superiori e altri, iperuranici, si coglie benissimo negli ultimi due testi del volume. Il primo è esplicitamente dedicato alla donna che costituisce più evidentemente l’organizzatore macro-testuale del libro, Myra («brillante e fragile | come il cristallo», chiosa l’epigrafe del testo):
Ma sì, certo che avremo un figlio, e
questo figlio lo faremo in paradiso.
dici, e un figlio così tipi come noi
possono farlo solo in cielo, si sa, non
in questo mondo che tra l’altro
è moribondo, è un piccolo paradiso
lo possiamo vivere già in terra
e lo stiamo vivendo
Un paradiso piccolo che, nel testo con cui si compie Un vuoto d’aria, non tarda a tramutarsi geograficamente in un’isola felice e rara dello spirito. Nei quattro versi che compongono il conclusivo Mezzo acrostico si coglie, con chiusura anulare, il senso duplice della vanità che si è cercato di mettere in evidenza, che qui diviene un’invocazione capace di riunire in sé entrambe le proprie accezioni (il bisogno di avere una centralità e il senso di vuoto, per natura intrinseco all’uomo finito), stavolta, in armonia.
L’antidoto alla vanità sembrerebbe, in definitiva, l’opportunità di essere salvaguardati con occhio benevolo, sempre aperto (divino) da quello stesso stato dell’anima, seppure provvisorio, “insulare” – non tanto un lieto esistere, quanto il lieto vivere.
Isola
rara nella
mia vita,
guardami come il tuo dio che ti guarda.
Photo credit: Kengiro Azuma
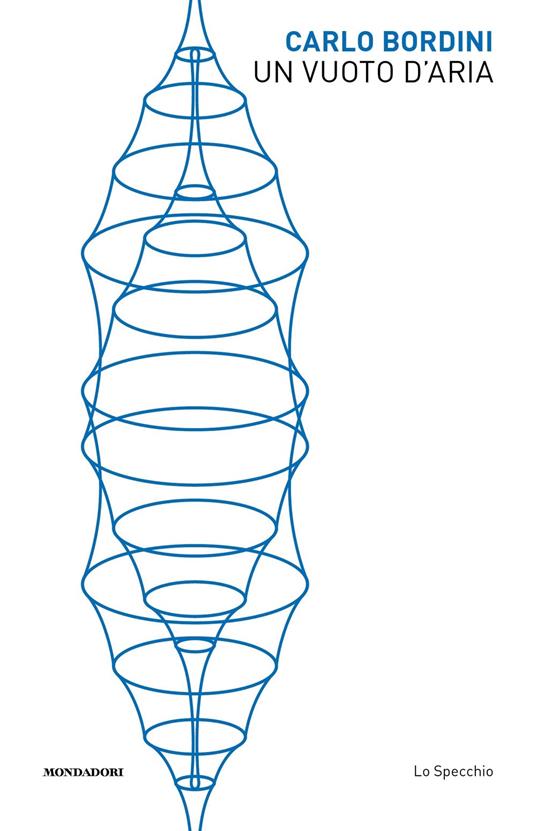
Carlo Bordini, Un vuoto d’aria, Mondadori, Milano 2021, pp. 192, €20,00.