Prosegue la serie di interviste ai finalisti del Premio Narrativa Bergamo 2020, che quest’anno si svolge interamente online. Dopo Ferruccio Parazzoli e Nadia Fusini, tocca a Tommaso Pincio presentare il suo romanzo, Il dono di saper vivere (Einaudi 2018) al pubblico: oggi, alle 18, in diretta Instagram con il profilo del Premio Bergamo. L’abbiamo raggiunto via mail e gli abbiamo rivolto qualche domanda per entrare nel cuore della sua scrittura e delle scelte che l’hanno portato a questo libro.
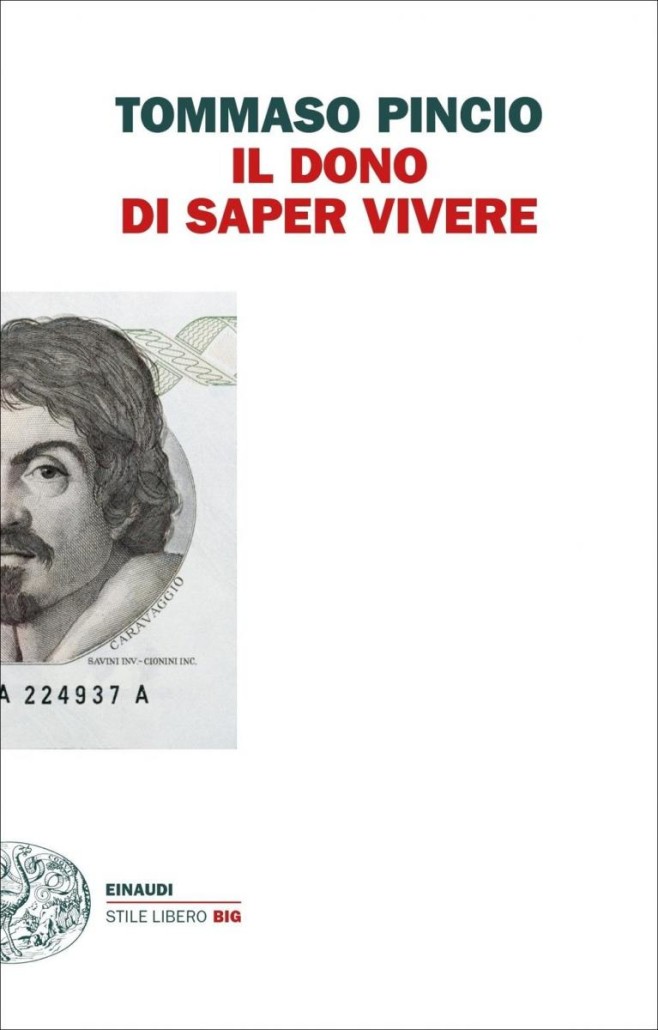
Il Dono di saper vivere mescola narrativa, saggistica, autobiografia, come molti dei tuoi libri recenti. Cosa ti ha spinto ad abbracciare una forma ibrida, e quali sono stati i tuoi modelli nell’andare in questa direzione?
La cosiddetta forma ibrida ha un’antica tradizione nella letteratura italiana. Nella sua Commedia, Dante non mescolava forse narrativa, saggistica e autobiografia? Sotto certi aspetti è proprio con l’affermarsi del romanzo che le diverse anime di un testo hanno cominciato a separarsi, diventando generi a sé. Se oggi tornano a convivere nell’opera di molti scrittori è perché il mondo si presenta nebuloso, difficilmente rappresentabile con i mezzi della narrativa convenzionale. Non sono convinto che sia davvero così. Il romanzo non è ancora un ferrovecchio, malgrado in tanti lo pensino. Credo che sia consolatorio pensarlo perché in questo modo si dirotta su una questione di forma un problema ben più sostanziale ovvero la progressiva marginalizzazione in cui versa la letteratura. Se proviamo a osservare la faccenda dall’esterno, i libri in genere, che siano romanzi tradizionali o narrazioni ibride, appaiano comunque un oggetto sempre meno rilevante in quel fondamentale processo che è la rappresentazione del mondo. Ci tengo a rimarcare che ho detto “appaiano”. Può darsi cioè che si tratti di una marginalità più percepita che reale, ma in un contesto di incertezza ciò che appare ha sempre un suo peso. La forma ibrida viene spesso presentata come una scrittura innovativa. Non è così. La forma ibrida recupera i modelli della civiltà della conversazione, dei salotti, dei cenacoli. È come se lo scrittore invitasse il lettore in casa propria per intrattenerlo più o meno amabilmente nel riparo di uno spazio domestico o comunque molto delimitato. Sotto questo aspetto, il romanzo era assai più moderno: non invitava nessuno, usciva in strada intenzionato a conquistare il mondo. Le forme ibride della scrittura contemporanea tradiscono un bisogno di autodifesa, di rinchiudersi, di trasformare la marginalità della letteratura in un nuovo elitarismo. Sto parlando ovviamente in generale, ma vale anche per me e i miei libri. E ci tengo a dire che autodifesa e chiusura non sono necessariamente atteggiamenti negativi. Semmai sono ambigui e ciò ha i suoi lati positivi: la vera letteratura non deve mai produrre certezze semmai il loro contrario ovvero seminare dubbi e inquietudine. Quanto ai modelli, ho cominciato a mescolare le carte nel 2008 con Cinacittà, che era ancora un romanzo di impianto tradizionale ma dove il piano autobiografico e quello dell’invenzione narrativa si intrecciavano in modi perversi. In quel frangente ha avuto molto importanza l’opera e la figura di George Orwell. Ovviamente non stato è il solo riferimento, ma volendo indicare un inizio, la molla che ha fatto scattare un processo, il suo nome è il primo che mi viene in mente.
Nell’ultima parte rifletti sul rapporto tra manierismo e pittura caravaggesca: “Se da un lato i ruderi ispiravano voglie e sentimenti di grandezza, dall’altro erano il promemoria costante del fatto che quella grandezza non esisteva più e si poteva soltanto provare ad emularla, a riviverla in forma di simulacro freddo e lontano dal presente, da una realtà ormai sintonizzata su altre lunghezze d’onda. La pittura di Caravaggio era appunto antitetica a questo. Era antimalinconica perché indifferente ai ruderi, perché era affondata nel presente”. La tua scrittura è molto malinconica, nel senso che la sua semplicità è solo apparente: la tua lingua deve molto ad autori del passato. Come mai dunque Caravaggio, antitetico per molti versi alla tua voce?
Per i motivi che spiego nel libro. Perché me lo sono trovato tra i piedi più volte nel corso della mia vita. Perché ho trascorso anni negli stessi luoghi che lui bazzicò secoli addietro. Perché è stato e rimane un artista frainteso. Lo era in passato quando veniva biasimato, ma per certi versi lo è pure adesso che è diventato un artista popolare amato da tutti, forse l’artista più amato in assoluto. Non lo definirei però antitetico alla mia voce. La sfrontatezza, l’insofferente sprezzatura con cui si esprime il mio alter ego nella prima parte del libro non è poi così distante dal carattere di Caravaggio, per come emerge nei racconti dei suoi contemporanei e nei verbali del processo per diffamazione che lo vide coinvolto. Il mio alter ego dice di odiarlo, ma non sempre si odia l’altro da sé. Spesso è vero il contrario che si odia qualcuno perché riconosciamo nella sua persona tratti che non vogliamo vedere nella nostra. Più che parlare di Caravaggio, il mio libro usa la sua opera, la sua vicenda biografica e il suo mito come uno specchio in cui far riflettere tante cose tra cui anche me stesso. Gli specchi non sono antitetici, al più inversi; riflettono soltanto ciò che siamo.
Colpisce il tuo lavoro sulle fonti, e in particolare l’episodio della riscrittura della biografia dei “Maestri del Colore”. Quanto, e come il fattore-riproduzione – penso ai dettagli nei cataloghi d’arte, ma anche alle cartoline e poster che chiunque aveva in casa, da piccolo – e la storia della sua ricezione (la lettura di Longhi è molto presente nel libro) hanno influito nel tuo modo di guardare Caravaggio?
Mi tocca tirare nuovamente in ballo la questione dello specchio. Come dicevo, il mio scopo non era quello di scrivere un libro su Caravaggio. Ero più interessato alla sua ricezione, al modo in cui Caravaggio è stato visto nei secoli e dunque sì, anche il modo in cui è stato riprodotto. E qui si profila un paradosso perché avendo avuto per anni le sue opere a un tiro di scoppio dai luoghi in cui passavo le mie giornate, Caravaggio è forse l’artista che ho più volte visto dal vero. Passavo ogni giorno davanti a San Luigi dei Francesi e Santa Maria del Popolo; mi bastava entrare in quelle chiese e fermarmi qualche minuto davanti ai suoi dipinti. Una sosta naturale e immediata come prendere un caffè in un bar. Un lusso, mi rendo conto. A ogni modo tra quei momenti di contemplazione privata e silenziosa – per quanto spesso turbati dal vociare dei turisti – e le riproduzioni dei cataloghi d’arte e i saggi degli studiosi vi è uno scarto analogo a quello che separa lo spettatore dall’attore, da chi osserva a chi va in scena. I due mondi non sono realmente separati e opposti come potrebbero esserlo il giorno e la notte; si riflettono piuttosto l’uno nell’altro al punto che uno non esisterebbe senza l’altro. Ciò che mi interessa è il processo di continua trasformazione, se non di deformazione, che una simile relazione comporta. Le fonti non sono sempre attendibili. A volte sono autorevoli e bene intenzionate come i saggi di Roberto Longhi, altre volte però, come la biografia che di Caravaggio scrisse Baglione, sono mosse dal risentimento e possono rivelarsi diffamatorie. In mezzo a questi due estremi, fioriscono infinite altre possibilità che rendono la verità inattingibile e forse perfino inutile. La vitalità di Caravaggio risiede anche nel fatto che è stato spesso frainteso ed era con questa nebbia feconda che volevo confrontarmi e non certo con la sfida di sgombrare una volta per tutte il campo dagli equivoci. A tratti il mio libro può forse dare questa impressione, ma è una posa che spero non venga presa alla lettera, anche se mi rendo conto che uno scrittore non può avere alcuna autorità sul modo in cui viene letto.
Nel Dono i quadri caravaggeschi fungono da specchio, hanno una funzione rivelatrice; ci troviamo sempre, senza eccezioni, davanti a ecfrasi di quadri reali. Ti è mai venuta voglia, scrivendo, di inventare o mescolare diversi riferimenti pittorici?
Malgrado la proposta sia suggestiva devo rispondere con un no secco. Un libro in cui l’io romanzesco viene di colpo sostituito dalla voce dello scrittore è fin troppo disorientante di per sé. All’apparenza la divisione del Dono di saper vivere è chiara: nella prima parte l’autore finge, nella seconda si rivela per quel che davvero è. Separare tanto pacificamente queste due dimensioni non è mai così facile, però. Spesso la menzogna rivela verità più profonde del vero, se la si screma per bene. Per contro, nessuna confessione è mai totalmente veridica. Se a una simile irrisolvibile ambiguità avessi aggiunto fonti o quadri inventati, il libro si sarebbe trasformato in un labirinto fino a sé stesso, un mero divertissement. Tutto quel che riguarda Caravaggio o che appartiene al mondo reale, il mondo esterno alla pagina, può essere verificato. Perfino la foto del libro gettato nel cestino della spazzatura è recuperabile su Instagram. Il lettore non è costretto ad accettare passivamente ogni mia affermazione. Può accertare di persona se dico il vero o no, e quando può farlo scoprirà immancabilmente che dico il vero. Ma come deve prendere il resto, le informazioni cui non accesso, a cominciare dalla mia privata? Deve prendere per vere anche quelle, visto che non può dimostrare il contrario, o ha facoltà di dubitare?
Nel libro scrivi che un racconto «implica anche un intento vendicativo di qualche tipo o almeno risarcitorio»; è stato così anche in questo caso? Il dono di saper vivere mi è parsa soprattutto un’autentica ri-vendicazione del diritto a perdersi, intraprendere magari strade non del tutto congeniali per poi riconoscersi.
Si narra sempre per vendetta, quando la materia del racconto ci coinvolge in qualche modo e a meno di non narrare per puro mestiere, con la sola pretesa di intrattenere gli altri. Sotto certi aspetti questo intento vendicativo è la molla iniziale di ogni vero romanzo. Gli eventi si succedono spesso in maniera caotica o immotivata, almeno ai nostri occhi. Raccontando ci vendichiamo del disordine, dando un filo e un senso alle cose, fosse solo temporale, individuando un prima e un dopo. Che ciò implichi anche e automaticamente un diritto a perdersi è altra faccenda. Non ne sono così convinto, malgrado la sensazione sia spesso quella. Se però raccontare può davvero servire a qualcosa, collocherei questa possibilità più nell’ambito della riconciliazione che non della rivendicazione. Se al termine di un racconto non ci si è riconciliati o almeno rassegnati all’insensatezza apparente del mondo, narrare è stato inutile. E va bene anche l’inutilità, sia chiaro: chi l’ha detto che la letteratura deve per forza servire a qualcosa? Non si può però vivere solo e sempre di vendetta.