La nuova edizione di Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, da qualche mese in libreria per Adelphi – che porta avanti così la pubblicazione delle opere dello scrittore pescarese – mi ha permesso di rileggere questo romanzo del 1947 a dieci anni di distanza dalla prima volta, quando mi accingevo a scriverci sopra la mia tesi di laurea in lettere. Dieci anni non sono tanti, soprattutto quando si tratta della lettura di un libro che, tra tante virgolette – che in queste righe vorrei provare a motivare –, è considerato ormai un classico. Ma se i dieci anni in questione rappresentano per chi scrive quelli durante i quali si è compiuta una sorta di emancipazione, da lettore curioso ma ancora ingenuo a studioso avveduto, se non proprio esperto, del fatto letterario, allora la questione cambia, e può valere la pena ragionare intorno a come sia cambiato il punto di vista su questo romanzo.
Innanzitutto, però, qualche accenno sulla trama. Tempo di uccidere racconta la storia di un’ossessione, quella che nasce nella mente di un tenente arruolato nell’esercito d’occupazione in Etiopia, durante la campagna coloniale italiana degli anni Trenta. Al centro di tutto è l’incontro con una ragazza indigena, durante un’escursione solitaria dell’uomo che, trovatosi inaspettatamente di fronte a una bellezza apparentemente pura e disponibile, sente riaffiorare un desiderio represso per i lunghi mesi della permanenza in Africa, lontano dalla donna che lo attende a casa, e trascorre con lei una notte di esotico piacere. Che volge tuttavia a un esito tanto tragico quanto fortuito. Un’ombra che si muove nel buio della boscaglia, un colpo di pistola sparato maldestramente, una ferita impossibile da sanare. L’uccisione della ragazza, che il tenente scoprirà chiamarsi Mariam, sembra inizialmente un episodio accidentale e tragico, ma agilmente rubricabile tra gli incerti che possono capitare all’uomo bianco in terra straniera. Non c’è stata volontà, quindi neanche responsabilità, soprattutto nei confronti di chi, in quanto occupato, è esposto quotidianamente ai rischi della guerra in casa. Il senso di colpa però comincia a rodere come un tarlo la coscienza del tenente, agevolato dalla tediosa vita da campo che offre alla memoria continue occasioni per tornare sui propri passi. E quando un altro incontro notturno, con due donne di fronte alla chiesa di A., impone all’attenzione dell’uomo l’immagine delle piaghe della lebbra, diffusa tra la popolazione locale, si fa largo il terrore che il malessere che da qualche giorno lo accompagna, insieme a una ferita alla mano che tarda a rimarginarsi, siano il segno di un contagio che non può avere altro esito che la morte, la «trascurata eredità» di quell’incontro fatale. Da qui in poi il racconto si snoda in una concatenazione di coincidenze che appaiono tanto più evidenti e necessarie, quanto meno il protagonista e narratore riesce ad assumere la distanza che servirebbe per fare chiarezza sulla sua condizione. In linea con una tradizione romanzesca più ottocentesca che modernista, però, il finale concede al lettore l’appagamento di una soluzione che chiude definitivamente ogni ipotesi aperta lungo il percorso. O almeno così si convince chi racconta.
Quella di Tempo di uccidere è una storia dagli evidenti significati allegorici – resi ancor più palesi dai titoli inizialmente ipotizzati da Flaiano, Il dente, La scorciatoia, Il coccodrillo, rimandi scoperti ai momenti topici del racconto, alle coincidenze decisive che orientano la vicenda del protagonista. La storia si dipana tra simboli dall’immediata riconoscibilità: un orologio che «ha un confuso concetto del Tempo» e smette di funzionare nei momenti meno indicati; un malessere fisico apparentemente senza causa, che fiacca lo spirito prima ancora che il corpo; un fetore dolciastro che immancabilmente si presenta negli snodi del racconto e soprattutto nel finale, quando tutto sembra esser stato spiegato; una donna lontana («Lei») che a casa attende il tenente, rievocata ogni qual volta la coscienza deve fare i conti con le proprie responsabilità, come se fosse la personificazione di un clemente tribunale interiore; infine uno scenario naturale più volte definito «di cartapesta», a ribadire il carattere di messa in scena della vicenda.
Tempo di uccidere è il racconto di un’impresa coloniale che corrompe l’animo di chiunque vi prenda parte; anche di chi, come il protagonista, si dichiara per niente convinto e anzi disgustato dai retorici proclami del regime. La colonizzazione si trasforma in una malattia che, al di là di ogni rassicurazione medica e nonostante la quarantena scontata dal tenente in mezzo al deserto insieme all’indigeno Johannes (altro episodio dal significato simbolico, che si connette con il sostrato religioso a cui rimanda il titolo del romanzo), non andrà mai via e tornerà, di tanto in tanto, a mostrarsi sulla pelle, a suscitare, con il proprio fetore, un’indesiderata intermittenza del cuore.
La storia di Tempo di uccidere è quella tipica del libro incompreso, come ricorda Anna Longoni nella Nota al testo di questa nuova edizione, riprendendo il topos del “successo malinteso”. Fin dalla vittoria nella prima edizione del Premio Strega, che gli attirò gli strali di certa critica che lo riconobbe come l’espressione della destra liberale (per via del ruolo decisivo che ebbe l’intuito di Leo Longanesi nella sua pubblicazione), questo romanzo ha sofferto di un problema di contestualizzazione che possiamo riconoscere su due distinti piani. Da un lato, con la sua trama “africana”, all’altezza del 1947 si mostrava estraneo alla dominante corrente del neorealismo – come se la riscrittura del passato recente dalla parte dei vinti dovesse necessariamente escludere quanto capitato lontano dai confini nazionali. Dall’altro, la scelta del romanzo – e per di più a sfondo storico – si pone come un’eccezione nel corpus letterario di Flaiano, che da lì in poi si sarebbe dedicato ad altre e più fulminanti forme espressive (racconti, apologhi, aforismi: i «lucidi mircorganismi del pensiero», come li definì Maria Corti), per tacere delle tante e fortunate sceneggiature cinematografiche (con Fellini e non solo). Anche per questo, nel tentativo di dare ragione di questa doppia eccentricità, la critica ha sempre spiegato Tempo di uccidere connettendolo genealogicamente alla tradizione del romanzo della crisi (Dostoevskij, Camus, Conrad e Buzzati), per la capacità di sondare attraverso le ampie campate della rappresentazione allegorica un’esemplare manifestazione della “malattia del secolo”, e motivandone la presenza nel curriculum di Flaiano come necessario tributo all’esperienza personale di sottotenente nella guerra d’Abissinia tra il 1935 e il 1936 – oggi restituita dalle pagine del taccuino Aethiopia. Appunti per una canzonetta, proposto in appendice al romanzo (dopo una prima uscita in digitale nella collana «Microgrammi»).
Su una bibliografia orientata in questo senso – e molto spesso datata – dieci anni fa, avevo cominciato il mio studio di Tempo di uccidere, rivolgendomi progressivamente a una lettura psicanalitica di quel viluppo di omicidi, atti mancati, sensi di colpa e reazioni irrazionali che è la vicenda del protagonista. Il concetto freudiano di “disagio della civiltà” mi sembrava perfetto per inquadrare l’incontro con l’alterità rappresentata da Mariam, che turba e sconvolge le categorie cognitive dell’uomo bianco, obbligandolo, dopo che aveva pensato di liquidare l’incontro carnale con la donna – forse uno stupro – e il suo tragico esito alla luce del confronto eterno e universale tra Natura e Cultura, a fare i conti con un’umanità antropologicamente incommensurabile. È questo che determina la crisi identitaria dell’uomo. Una crisi che si riflette metanarrativamente sulla stessa messa in intreccio del racconto: il romanzo adotta infatti la struttura del poliziesco (l’indagine del tenente per trovare le risposte alle domande che, sempre più numerose, si affollano nella sua coscienza alterata), ma per eludere ogni momento potenzialmente di svolta (dagli omicidi falliti, che ricordano gli atti mancati del Michele degli Indifferenti, agli incontri, mai risolutivi). Lo stesso finale, con il dubbio che proprio in exitu arriva a rimettere in discussione tutte le fragili sicurezze costruite nell’ultimo colloquio tra il protagonista e un commilitone diventato confidente, sancisce il fallimento della logica consequenziale che dovrebbe presiedere ogni tentativo di comprendere l’esperienza dandole forma di narrazione.
Da studente distratto e poco aggiornato non avevo fatto in tempo ad accorgermi di un’incombente nuova ondata di interesse nei confronti di Tempo di uccidere, propiziata dalla vague degli studi culturali che nel romanzo trovava una testimonianza molto significativa – perché maschile e perché molto a ridosso dei fatti narrati – dell’esperienza coloniale italiana. In questa direzione si sarebbe orientata la ricerca accademica degli anni dieci – rendendo peraltro la mia timida ipotesi psicanalitica, se non datata, quantomeno polverosa. Agli occhi delle riletture in chiave postcoloniale (penso in particolare ad alcuni bei contributi di Ugo Fracassa e Giuliana Benvenuti, facilmente reperibili anche in rete) Tempo di uccidere si presenta come chiara parodia del romanzo coloniale promosso dal Ministero della propaganda fascista, di cui pure riproponeva intatti alcuni topoi (le donne africane che sono «semplici come colombe, dolci, disinteressate, incluse nella natura»; l’inaffidabilità degli indigeni; la superiorità culturale e morale dei colonizzatori), ma soprattutto come manifestazione – forse non del tutto consapevole – di una crisi, che è del colonizzatore, ma anche del maschio bianco. Emblematica, in questo senso, la vicenda della quarantena trascorsa dal tenente nel deserto insieme al vecchio Johannes: all’acuirsi della malattia e della convinzione di avvicinarsi alla propria fine da parte dell’italiano risponde la conquista di una statura autonoma e, soprattutto, di agency da parte del nativo. Ecco il sintomo di un primo superamento dello “sguardo cieco” coloniale da parte di Flaiano, che nel confronto tra uomo bianco e uomo nero più di una volta fa pendere la bilancia dalla parte del secondo.
Motivi di una legittima renaissance per questo romanzo, che si presenta oggi al lettore carico di spunti d’interesse. Al netto dell’apparente estraneità dal Flaiano più noto, in Tempo di uccidere si trova già maturo un umorismo cinico e spietato che qui l’autore rivolge innanzitutto contro il proprio alter ego, un ufficiale estraneo a tutti, ai propri commilitoni così come agli indigeni, ai quali più di una volta guarda con malcelata invidia. Questo umorismo sporadicamente trova espressione nella formula icastica e fulminante che distinguerà la scrittura del Flaiano aforista (e che si ritrova in parte tra i frammenti del diario etiope: «A poter spaccare la terra in due ci si troverebbe dentro uno di quei foglietti che si trovano nei cioccolatini con un proverbio incitante alla rassegnazione»), mentre dimostra di necessitare ancora di una certa decantazione nei tempi lunghi del romanzo, ricorrendo all’intero armamentario narratologico per produrre lo straniamento necessario. In questo senso, appare auspicabile che nei futuri studi sul primissimo Flaiano, la componente “culturologica” si affianchi sempre a una sapiente indagine morfologica del racconto, dal momento che per Flaiano la forma è la prima espressione del “contenuto” della crisi.
Riconoscibile è invece quel moralismo intransigente che permetterà a Flaiano di farsi contemporaneamente fustigatore dei costumi degli italiani e reo confesso per la propria collusione con i propri simili. È questo moralismo che gli consente di smascherare la falsità di ogni retorica sull’Africa, di quella che pretende di dimostrare la superiorità dell’uomo bianco («ma guardi dunque questa gente. Le sembra civile?») come di quella che pelosamente si volge a riconoscere la purezza originaria degli indigeni («Risposi che avevano delle qualità che nei paesi civili si vanno perdendo»).
È in fondo così che Flaiano dimostrava – e ha sempre dimostrato – il proprio impegno intellettuale: rinunciando preventivamente a qualsiasi esemplarità che faccia del suo racconto uno strumento di emancipazione collettiva («Pretendere da uno scrittore che egli si interessi più ai problemi di tutti che a quelli di uno solo è chiedergli di cominciare dalla fine», ha scritto una volta), concentra il proprio discorso sull’io, smascherandone ogni finzione, dileggiando ogni tentativo ipocrita di giustificarsi o spiegarsi, scavando nella coscienza fino ad arrivare a quel “cuore di tenebra” le cui coordinate non corrispondono a quelle di un’Africa di cartapesta, ma localizzano il disagio nel cuore della nostra presunta civiltà.
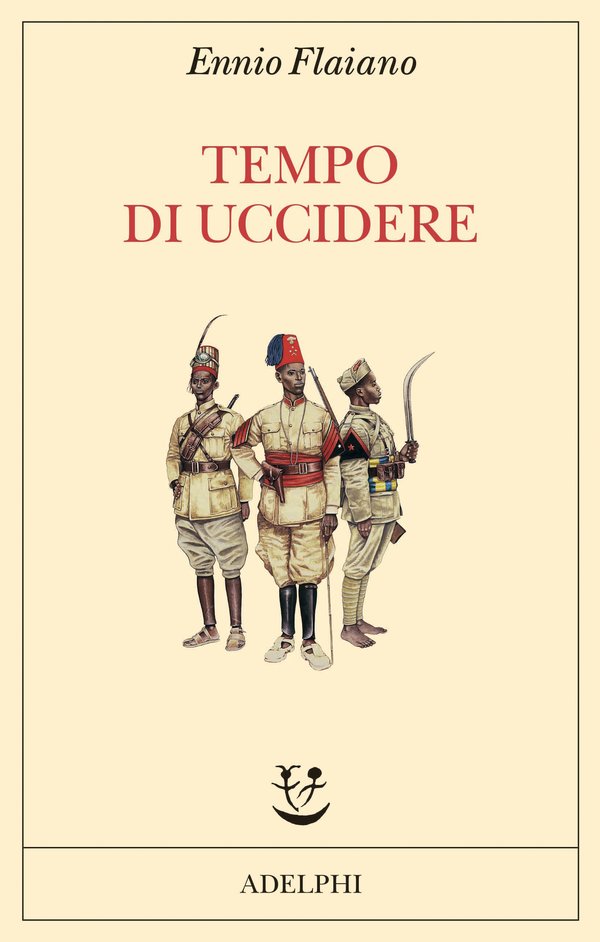
Ennio Flaiano, Tempo di uccidere, a cura di A. Longoni, Adelphi, Milano 2020, 329 pp. 19,00€