Sapessero
che disarmato è il cuore
dove più la corazza è alta,
tutta borchie e lastre, e come sotto
è tenero l’istrice.
Nelo Risi
Nel 2017 usciva per NEM il libro d’esordio di Simone Burratti Progetto per S., corredato di una importante prefazione di Stefano Dal Bianco. Quando mi trovai a parlarne con Burratti, lui – non privo di un perdonabile moto d’orgoglio – mi rivelò che fortuna e sfortuna del libro risiedevano proprio nel raro dono di una prefazione addirittura migliore dell’opera («le prefazioni si fanno per difendere i poeti veri», ammette lo stesso prefatore). Dopo la disamina del libro, nella parte finale del testo Dal Bianco lamentava con schiettezza il venir meno dell’inermità del poeta esordiente di fronte al lettore. Si riferiva nella fattispecie alla “fasciatura” intellettuale con cui Burratti aveva deliberatamente occultato certe cicatrici antinovecentiste (Sbarbaro, Saba) della propria poesia. L’accusa bonaria a Burratti e alla sua generazione era quella di aggirare il tragico ed evitare la confessione sincera facendo appello al «male occulto» di un’intelligenza formalistica dai tratti maudit, mentre in soffitta marcivano la sana «idiozia» e «l’intelletto del cuore» (sic!).
La discussione sul tema dell’inermità nei poeti delle nuove generazioni appare molto feconda, come dimostra anche questo scambio tra Davide Castiglione e Marco Malvestio a proposito della presunta maschera erudita e (post-)modernista che il secondo avrebbe indossato ne Il sogno di Pasifae (nell’opera collettiva Hula Apocalisse, Prufrock spa 2018). Da poeta non più esordiente, pur approvando il richiamo di Dal Bianco, mi trovo a comprendere perfettamente le istanze di Burratti e Malvestio; sia pure in forma diversa, non fatico a riconoscermi macchiato degli stessi peccati. Del resto perché il poeta dovrebbe deporre le proprie armi di fronte al lettore quando il lettore non è inerme? In effetti, troppo spesso il lettore di poesia non è un semplice o anche attrezzato e onesto lettore (si tratterebbe in questo caso di un lettore ideale che quindi nemmeno esiste), ma un poeta-lettore armato fino ai denti e animato dalle peggiori intenzioni. Come si può pensare di uscire disarmati in un’epoca nella quale i migliori tentativi letterari si perdono nel caos degli scontri tra fazioni e nel fetore delle shitstorm sui social? Penso a certe agguerrite dichiarazioni consortili di poetica (recentemente sono emersi “Gli Imperdonabili” di Brullo), ai dubbi (più o meno leciti) sui criteri di scelta delle antologie degli ultimi anni, e alle polemiche (più o meno oziose) tra poeti tradizionalisti e poeti di ricerca sui dualismi “poesia assertiva-non assertiva” o “scrittura-oralità”, per dirne solo un paio. A questo si aggiunge la drammatica insufficienza non sempre incolpevole di critici e addetti ai lavori che – sommersi dalla valanga di pubblicazioni annuali – rischiano di perdere di vista il libro di valore. Tale pericolo è elevato all’ennesima potenza dal complesso malessere che affligge l’editoria di poesia: un’incontrollabile ipertrofia produttiva – non certo giustificata da dati di vendita stellari o da un improvviso fiorire di eccellenze poetiche – e certi discutibili criteri editoriali (crowdfunding, editoria a pagamento, ecc.) contribuiscono in modo decisivo allo smarrimento.
Insomma: oggi, pur aspirando al ruolo di eroe di guerra, il poeta alle prime armi (del resto si dice così, no?) deve principalmente imparare a difendersi. I sacchi di sabbia dietro cui si rifugia sono quelli di una poetica acerba per forza di cose, eppure allo stesso tempo già adulta e strutturata, irrimediabilmente postuma e citazionista. Apparendo come sintomi di una resa, l’apertura e la sincerità sono sempre condizionate dal timore che la pubblica esposizione sia un segno di debolezza, e quindi vengono travestite (si veda Francesco Vasarri su SuccedeOggi, ma soprattutto lo si legga nel suo Don Giovanni all’ossario, Anterem 2016, dove – per vanitas – funeree «gonne» e «crinoline» tradiscono il desiderio di un «disarmo definitivo»), glassate, complicate con ogni possibile tecnologia bellica. Altro che onore delle armi: dal fondo della trincea, nell’incapacità di attaccare diversamente, il poeta (e qui allargo il discorso anche ai non esordienti) si vede costretto a piazzare strategicamente nel territorio di guerra quelle poche mine che coinvolgano nell’esplosione solo chi si avvicina troppo all’area di azione. Così facendo, crede di minimizzare i danni potenziali (soprattutto verso se stesso), mentre allo stesso tempo confida segretamente nella possibilità che l’onda d’urto nel campo della critica e del pubblico abbia un raggio d’azione molto più ampio del previsto. Illudendosi insomma che chi deve capire capirà. Eppure, mentre il fisico del combattente – costretto nella sua armatura di medietas – è debole e frustrato per il corpo a corpo con i paradigmi dell’ufficio poetico, l’ideale che anima il lavoro poetico è invincibile, così come lo spirito. Scrive Paolo Maccari: «Giunsi a un (speravo) segreto avamposto. | Non c’erano più armi. Era deserto. | Dopo due ore, ridendo, mi dissero di uscire» (Fuoco amico, Passigli 2009, poi I ferri corti, Lietocolle 2019). È il poeta l’unico a conoscere il prezzo della propria libertà di espressione, il grado di volontà richiesto per saltare fuori dalla trincea, con o senza armi.
Alla luce di tutto ciò, Dal Bianco sa bene che i nuovi poeti per sopravvivere devono tenere ben affilate le proprie armi e rifornite le cartuccere, prevedendo una lunga resistenza in trincea. Infatti, tornando alla prefazione, il poeta di Ritorno a Planaval esortava Burratti e i suoi contemporanei sì all’inermità, ma a un’«inermità perduta, […] auspicata»; e infine, quasi facendo un passo indietro, riconosceva «la desolazione, la pena e l’abbattimento» come «condizioni ideali […] e necessarie per un esordio. Chi non ha attraversato il nulla non va da nessuna parte». In virtù di questa generosa concessione, Burratti veniva – direi ragionevolmente – assolto, perché riconosciuto capace di affrontare direttamente la questione senza ignorarla o accettarla passivamente come dato di fatto.
Ecco, pur a distanza di quasi tre anni, occorre secondo me problematizzare l’interessante esortazione di Dal Bianco: senza banalizzarla né assolutizzarla, assorbirne le parti più nutrienti per liberarla dal rischio che appaia come un richiamo paternalistico, astratto o, peggio ancora, un’implicita dichiarazione generazionale di superiorità morale. Attingendo a una parte delle mie letture degli ultimi anni – quindi senza pretese di esaustività – cercherò quindi di individuare alcuni esempi di come tale inermità si verifichi nella poesia contemporanea, e in quale modo. Tuttavia il punto di partenza di questa mia panoramica vorrebbe essere, più che un semplice esempio, un omaggio a colui che, per la mia esperienza di lettore, è ed è stato un “campione di inermità”: Mario Benedetti. Ciò non ha una valenza solo simbolica, ma de facto: già in molti (anche Maria Borio su queste pagine) hanno sottolineato come la grandezza del poeta risiedesse nell’uso vertiginoso di una lingua piana e nella capacità di forzare improvvisamente la fragile sintassi del verso con tagli esatti quanto le ferite e i trasalimenti di un essere umano nel mondo. Da parte mia, ho assistito a una sua lettura di Tersa morte (Mondadori 2013) pochi mesi prima dell’infarto che lo costrinse per molti anni in un misterioso silenzio. Benedetti mormorava con voce fioca le poesie che, raccontando la morte di un’altra persona, ne avevano già seminato in lui l’evidenza. Troppo facile pensare che l’inermità di Benedetti si sia manifestata nello stato fisico degli ultimi anni: quella era solo infermità. L’inermità stava nella totale aderenza tra il poeta e l’uomo, tra le poesie e la vita. Ha scritto il suo amico Antonio Riccardi: «Vedersi al centro della battaglia | come vedendosi da fuori | e volere solo quel solo centro.» (Tormenti della cattività, Garzanti 2018). Benedetti non può essere assolutamente definito un lirico in senso stretto, ma ci offre l’occasione di individuare una tendenza che non è difficile riscontrare in certa tradizione letteraria, ovvero l’inermità come attitudine al soggettivismo lirico, declinatasi nel contemporaneo in varie «tipologie poetiche» (cf. Mazzoni): dal lirismo classico delle esperienze poetiche conservatorie a quello “geneticamente modificato” (cf. Andrea Inglese) di certe scritture di avanguardia (Bortolotti, Broggi, Policastro e lo stesso Inglese, «armato delle sue difese» in Commiato da Andromeda, Valigie Rosse 2011).
Ma si può dire che l’inermità sia una prerogativa della poesia lirico-confessionale, come potrebbe suggerire la menzione di Saba e Sbarbaro quali modelli “censurati” da Burratti? Non è un’ipotesi da escludere, soprattutto se non ci si limita a modelli di lirismo romantico e crepuscolare. Ad esempio, può essere utile interrogarsi sulle modalità in cui l’esperienza genitoriale ha agito come elemento amalgamante sugli orizzonti della poesia di Vincenzo Ostuni, Gabriel del Sarto e dello stesso Dal Bianco, autori molti diversi per premesse, prassi e finalità della scrittura. Nei loro ultimi libri (rispettivamente Il libro di G., Il Saggiatore 2019, Il grande innocente, Nino Aragno 2017 e Prove di Libertà, Mondadori 2012) questi scrittori hanno voluto svelare più o meno estemporaneamente la vulnerabilità che viene dall’essere padri, scardinando dall’interno le proprie scritture affinché si intravvedesse il riflesso di una nuova purezza, chiamata a gettare una luce diversa sul significato sia della tregua che delle armi («È suo figlio. Si può barare in un puzzle?», si chiedeva Sauro Albisani ne La valle delle visioni, Passigli 2012). Di seguito, un testo di Ostuni, poeta di ricerca: se si tiene ben presente la parte finale del suo intervento su «La lettura» (2012) in risposta a Carlo Carabba, non apparirà un paradosso citarlo quando si parla di soggettivismo lirico:
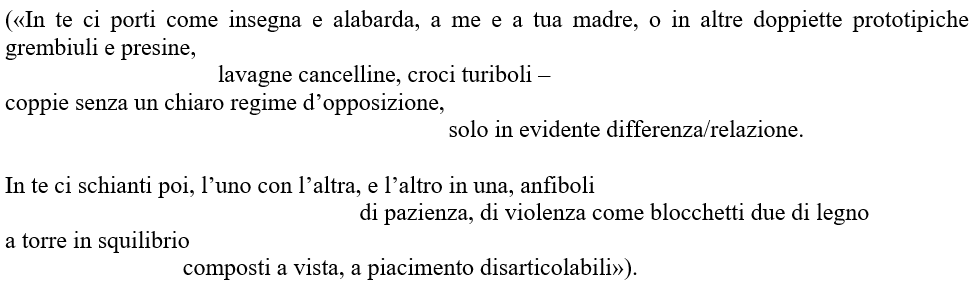
Se il tema della genitorialità appare in grado di accomunare esperienze poetiche così diverse tra loro, senz’altro più tradizionale è il concetto di poesia come occasione di scavo autobiografico, spazio mnestico ed elaborazione del lutto. Insieme a molte altre, le opere di Cristiano Poletti (Temporali, Marcos y Marcos 2019), Daniele Mencarelli (Tempo circolare, Pequod 2019), Paolo Fabrizio Iacuzzi (Folla delle vene, Corsiero 2018), Giulio Maffii (Giusto un tarlo sulla trave, Marco Saya 2016) e Filippo Davoli (La luce a volte, Liberilibri 2016) giocano la partita sul campo estremamente delicato del soggetto alle prese con l’esercizio della memoria. Questi poeti si differenziano per stile, lessico, registro e utilizzo della metrica, ma condividono un’urgenza retrospettiva verso la propria vicenda privata, finalizzata a comprendere nel tempo presente la ricorsività del proprio dramma personale e oggettivarlo in esperienza comune. Affinché la poesia diventi autentico luogo di memoria conoscitiva, è necessario un abbassamento delle difese personali. Occorre però eludere il patetico e il sentimentale, specialmente nel campo minato della poesia amorosa, di cui si trovano esempi virtuosi ne I destini minori di Isacco Turina (Il ponte del sale 2018). È tuttavia la trattativa con la morte – già indagata recentemente da Milo de Angelis nella splendida sezione “Guerra di trincea” (Incontri e agguati, Mondadori 2015) – che più di tutto offre la possibilità di vedere in atto una forma molto concreta di inermità, come dimostra questo testo di Claudio Pasi (Nomi propri, Amos 2018):
Ma che cos’è morire, com’è il brivido
dell’ultimo respiro, quale luce
si spegne all’improvviso nell’istante
che scompare dal monitor la linea
sinuosa del tracciato, in che maniera
si attenua l’eco viva delle cose
e a poco a poco si dissolve, quanto
tempo rimane caldo il letto,
come nell’ «ora del decesso» ha attraversato
quale parete, e per andare dove
e ritornare ancora a non esistere?
Il lessico, l’isometria e la sintassi elegante conferiscono una certa cantabilità alla riflessione di Pasi, ma non è certo questa l’unica strada formale percorribile. Tra i tanti, Francesco Terzago, esordiente già maturo, in Caratteri (Vydia 2018) ricorre ad una solida corazza poematico-discorsiva per descrivere la realtà nel modo più distaccato ed empirico possibile (cf. Castiglione): l’autore mira a dire il nudo “esserci” in modo indolente, partecipa al presente asciugando ogni sentimento senza censurarlo. Per farlo, deve fingersi fotografo, applicando un filtro assolutamente riconoscibile, una pellicola artificiale non priva di una solida e cordiale ideologia senza la quale la poesia diventerebbe narrazione inerte e didascalica. Per Simone Di Biasio la maschera è invece quella della sagacia. Nel libro corale Panasonica (Il ponte del sale 2020) il poeta laziale ha trascritto e riscritto un gran numero di scene di vita, preghiere, motti e dialoghi rubati, al fine di redigere una sorta di manuale di lingua della comunicazione poetica chiamato ad illuminare affettivamente il proprio vissuto. Simile è il procedimento di Alessandro de Santis che in Mura amiche (Transeuropa 2020) trafuga, sottrae dalle case degli altri il materiale utile a tratteggiare la propria umanità e quella di chi le abita: sottrazione come metodo conoscitivo e prassi della scrittura.
Queste diverse modalità ci rivelano un soggetto poetico intento a percorrere alcune vie della tradizione per recuperare e mettere sulla pagina l’identità più o meno franta del soggetto. Ma se è vero che l’inermità appare come una caratteristica congenita del canone tradizionale, d’altra parte possiamo osservare come essa si manifesti sotto forme più o meno coerenti anche in esperienze poetiche radicalmente diverse, come quelle che, per esempio, prendono atto di una disgregazione dell’io. In Non essere (Vydia 2019), Alberto Cellotto investiga il senso degli eventi e l’essenza delle cose, rilevando la loro insistente tendenza a trasparire nel reale. Come dice a proposito Laura Di Corcia, «‘Non essere’ significa soprattutto essere»: tanto più l’io poetico svanisce, quanto più preme per esserci, per esistere in una pulsione di conoscenza del mondo. I ferri del mestiere (Mondadori 2011) sono invece i dispositivi che Andrea Ponso ha utilizzato contro di sé: l’annullamento dell’io poetico avviene tramite un nascondimento, una reductio del soggetto a oggetto fonico e ritmico. Facendo un uso maniacale ed estremamente consapevole degli strumenti a sua disposizione, Ponso ribadisce il primato assoluto del significante fino alla sparizione dell’io, o al suo assorbimento. L’oggetto della scrittura non mira ad un approdo che sia al di fuori dalla scrittura, non tende a un significato giustapponibile, non aspira a raggiungere alcun risultato. Al contrario, vuole regredire meditando in modo speculativo su sé stessa, diventare quindi puro suono, pura materia: ontologicamente, questo somiglia al gravido nulla a cui alludeva Dal Bianco, tanto più che Ponso ha affermato di non voler più pubblicare le poesie che scrive.
Io mi nascondo qui, a pochi passi
dalla selva di ortiche recise
dove si sente odore di fresco, di
fossi: ci separano
gli orti, i cumuli fragranti di fieno,
le botti scure, i tralci.
Si viene a vedere
ciò che dura nell’arsura.
Nel suo ultimo libro, Umberto Fiori ha invece lavorato per aggregazione: abbandonando la zona franca dell’impianto lirico anticonvenzionale che caratterizzava le prove precedenti, il poeta ha architettato una robusta organizzazione poematica, operando una riqualificazione inedita del proprio efficiente arsenale di temi e figure. Il Conoscente (Marcos y Marcos 2019) si presenta come un metamorfico racconto in versi o, per meglio dire, un poema epico-onirico capace di raccontare con ironia paradossale e lisergica il farsi e il disfarsi della coscienza di un poeta prigioniero di isterie, contraddizioni, ideologie e luoghi comuni del mondo della poesia. Un romanzo di (tras)formazione che restituisce al poeta la propria umanità. Anche Antonio Lanza ha scelto con Etnapolis (Interlinea 2019) la via del romanzo in versi, sradicando però dalla scena l’io poetico, ridotto a narratore onnisciente delle vicende di terzi. Il fantasma del poeta si aggira in un centro commerciale siciliano armato di mirino a infrarossi, pronto a cogliere nel caos una traccia irriducibile dell’umano (come già aveva fatto con i suoi ottonari Fabiano Alborghetti in Registro dei Fragili, Casagrande 2009). Emblematica è l’inspiegabile epifania di un cervo nei pressi del centro commerciale: un cortocircuito di stupore che mette in crisi le assurde difese immunitarie (vedi la soluzione tipografica del barrato) nei confronti della realtà di un individuo immerso nella società capitalistica:
Come se non era di questo mondo, dico, e allo stesso tempo come se di questo mondo voleva che vedessimo qualcosa, qualcosa d’altro, attraverso di lui. E mentre si allontanava seguendo la linea degli ulivi ricordo di aver pensato, no, ma questa è una sciocchezza, non la dico.
Più vicino al cervo che ad Etnapolis – situato sul versante (post-)orfico-ermetico-creaturale ma allergico alle definizioni – c’è Alessandro Ceni. Combattimento ininterrotto (Effigie 2015) è il diario di una lotta armata nel vortice degli eventi gestita principalmente su due fronti: il magma del subconscio e la superficie materica del linguaggio. Il testo poetico è il corpo luminoso del reale spogliato e crivellato di colpi: i nessi oscuri e impossibili rivelati da Ceni disturbano, hanno la capacità di svelare l’umano nel disumano, e viceversa. Partecipando al caos dialettico del mondo, il (super-)io poetico è tale, si verifica ed esiste solo in quanto è il più ingombrante di quei nessi. Libro dopo libro, Ceni alimenta la «muta fornace» di un’armeria bigongiariana dura a morire – e infatti, rinunciando alla misura dell’intelligenza e al buon senso del “poetese”, Ceni ha fatto il vuoto intorno a sé, vivendo in un silenzio incredibilmente fecondo, a suo modo pacificante. In questa terra di mezzo scevra di ironia che coniuga visione e materia in una prospettiva veritativa, è possibile anche intercettare il lavoro radicale di Francesco Iannone (Le belve erranti, Nervi 2019) ed Emanuele Franceschetti, nonché dei poeti di Ultima (Giuseppe Nibali, Fabrizio Sinisi, Damiano Scaramella, Tommaso di Dio), interessante progetto che inventa poesia postrema e visioni multimediali.
Autori come Roberto Amato, Luigi Socci (Prevenzioni del tempo, Valigie Rosse 2017, poi in Regie senza films, Elliot 2020) e Carmen Gallo (Appartamenti o stanze, D’if 2016) creano con la poesia un universo parallelo che «ci riporta a sentire il mondo che è, esattamente così come non è», come scrive Tommaso di Dio su Francesco Maria Tipaldi. Il fantastico, il grottesco, il surreale e il favolistico sono le cornici stranianti entro le quali i poeti privano della loro letalità le armi più pericolose, trasformando invece i dialoghi, gli oggetti e le circostanze più innocue in insospettabili nuclei di senso o enigmi fatali. È questo un cinismo incantato che sovverte le regole della guerra, creando un caos benigno denso di rivelazioni.
Ce n’è un po’ in ogni cosa: il panorama
che è possibile
vedere solo sporgendosi, le dita
annidate nel palmo della mano
un attimo prima di cominciare
timidamente ad irradiarsi.
(ce n’è per tutti, uomini e fantocci:
gente che lascia su letti sfatti
calchi di corpi
in cui fatica a identificarsi)
(Luigi Socci)
Se già non fosse chiaro, è ora possibile sgombrare il campo da un equivoco: inermità non significa per forza effusione lirico-confessionale, non è per assioma un improvviso abbassamento di temperatura della scrittura o una sterzata stilistica al ribasso. È più complicato di così: la ricerca di un frammento di autenticità non è appannaggio di poetiche crepuscolari o platealmente egoriferite, ma può passare anche da esperienze antiliriche che rifiutano queste soluzioni, o che le estremizzano in direzioni divergenti. A questo proposito, l’area neometrico-performativa annovera alcuni poeti armati fino ai denti (il che, a sentire Nelo Risi in epigrafe, significa che hanno qualcosa di prezioso da difendere). Penso ai plastici componimenti barocchi di Giacomo Trinci, poeta tragicomico e civile che – armato di mitragliatore automatico-metrico – difende il magro crepuscolo di un’umanità lesa dal tragico contemporaneo, alla bulimia linguistica delle abrasive confessioni-fiume di Rosaria Lo Russo (Anatema sit, in pubblicazione), alla grazia arrendevole dei pugnaci endecasillabi di Giulia Martini (Coppie minime, Interno Poesia 2018) e Marco Simonelli (Le buone maniere, Valigie Rosse 2018) e al ritmo ossessivo e ipnotico di Nicolas Cunial (Black in/Black out, Interno Poesia 2019) che con sincerità impietosa e corrosiva riferisce i traumi delle patologie psichiche per mezzo di monolitci ipersonetti di ispirazione zanzottiana.
Per chiudere il cerchio, dopo Burratti ecco altri tre agguerriti esordienti da assolvere per mancanza di prove. Inizio con Eugenia Galli, ancora inedita in volume ma attiva nel campo della spoken music. I monologhi elettronici dell’ep Monosportiva Galli Dal Pan (Zoopalco 2019) ribadiscono in modo consapevole la necessità dell’elemento ritmico-fonico del verso: la musica non ha qui funzione ancillare, non è un accompagnamento ma uno strumento che, insieme alla vocalità e al testo, dà forma allo spazio performativo della parola poetica. La resa orale non è opzionale: non si tratta qui di leggere più o meno bene un testo poetico, ma di costruirne il senso e l’efficienza fabbricandogli un corpo; o meglio, scoprendone la corporeità. Le poesie di Galli dicono la coscienza del corpo, la sua modellazione/trasformazione/contraffazione nel passaggio all’età adulta all’interno della società dell’immagine. Tra ironia e spietato disincanto, lasciano spazio a confessioni di commovente dolcezza. Il tema della musicalità del verso interessa anche il giovane Dimitri Milleri, seppur in modo ideologicamente differente. Il suo Sistemi (Interno Poesia 2020) è un notevolissimo quasi-esordio che si presenta come un coriaceo libro-armatura a chiusura ermetica. Eccezion fatta per alcuni episodi in cui il dettato è sorprendentemente disteso e confidenziale, appare chiaro come per l’autore la poesia sia chiamata a sviscerare fatti complessi più o meno privati restituendoli poeticamente in modo altrettanto complesso. Milleri è uno scrittore consapevole: da musicista qual è tratta il verso come una battuta, costruisce i versi metricamente e con gli stessi mezzi è in grado di dissolverne gli effetti, come manipolando un pensiero. Ma quando la poesia è chiamata a dire «il panico, lo sgomento», ecco che per Milleri «nulla può essere pensato né agito»: i processi meccanici mostrano il loro limite e diventano grovigli inestricabili di significati, spalancando l’abisso della condizione umana, mettendo a nudo la vulnerabilità del poeta.
Corrispondenze? Certo, come ieri:
dall’aula quattro si sentiva esatta
l’intonazione in limonaia del fagotto
con l’eco di una sega circolare.
Però la nostra è una vita che approssima
nel più dei giorni
come i rastrellamenti.
E quando accade, quando
l’aspettativa prende posto nel reale,
è sempre un terzo, vedi, a rivelarlo,
restando escluso dal miracolo non meno
di chi lo vive senza nominarlo.
Il terzo esordiente è Demetrio Marra, che ha suscitato l’attenzione della critica con l’interessante opera prima Riproduzioni in scala (Interno Poesia 2019). La poesia è qui intesa come colto e debordante esercizio satirico di autocoscienza nel segno dell’inadeguatezza esistenziale. Senza alcuna indulgenza, sulla scia di Cattaneo il giovanissimo Marra sottopone sé stesso e la società in cui vive ad un corrosivo screening in versi, il cui obiettivo è rilevare con disincanto materialistico (cf. Castiglione) compromessi e falle nella dialettica tra io e mondo, ricordando per certi versi, l‘«elastico» (cf. Di Tommaso), furioso “parlare di traverso” e per accumulazioni, tipico di un altro interessantissimo esordiente, Pasquale del Giudice (Piste ulteriori per oggetti dirottati, Ensemble 2019). Al solito: più profondo e faticoso è lo scavo, maggiore è la probabilità di rinvenire residui di ironico e insospettabile candore.
Tirando le fila del discorso, mi chiedo: è auspicabile l’inermità per un poeta? Non esiste una risposta univoca a questa domanda, perché è evidente come tale inermità non si dia in purezza: finora non abbiamo fatto altro che metterne in risalto la duplicità in chiave contrastiva, quella natura contraddittoria che la rende feconda e stimolante – direi vitale. Scrive Fabio Donalisio a margine del suo bellissimo Ambienti saturi (Amos 2017): «Per quanto ognuno si accanisca […] a rimuoverlo, negarlo o ribadirlo (con identico effetto), siamo in guerra». A me pare irragionevole pensare a una radicale obiezione di coscienza o sperare che si dissolvano le inevitabili concrezioni del Novecento sugli schermi della poesia d’oggi. Non credo proprio che Dal Bianco desideri questo, tantomeno una resa o un’acritica diserzione: probabilmente ciò che si augura è una tensione all’inermità come espressione di lealtà verso di sé e nei confronti del lettore, senza indulgenze, castrazioni o oziosi intellettualismi. Se visto nella giusta prospettiva, il suo rimprovero non è scolastico né paternalistico: mi pare più un serio appello sì a deporre le armi, ma a patto che questo non comporti la lobotomia dell’oggetto poetico, la sua trasformazione in tiepida formula pronta a risolvere i mali del mondo o ad annacquarli con vuoti ammiccamenti pop, decaloghi buonisti e nichilisti, avanguardie fuori tempo massimo, quadretti familiari e bucolici in poetese, barzellette in giambi, speculazioni politiche ed ebeti derive fanciullesche. L’inermità è perduta non solo perché il linguaggio poetico è naturaliter complesso, ma anche perché chi si pone come unico obiettivo di conseguirla spesso opera un pericoloso smantellamento degli strumenti poetici in favore di una falsa accessibilità, di una familiarità poète-lecteur solo illusoria. Non avviene una deposizione delle armi perché semplicemente mancano le armi, sacrificate in nome dei buoni sentimenti di un pacifismo che non ha niente a che vedere con la letteratura. Ma non è questa la sede per portare esempi negativi, il quali peraltro non faticano a imporsi da soli ai disonori della cronaca poetica. Insomma, seguiamo le parole di Dal Bianco: restiamo idioti senza sfociare nella demenza.