Massimo Rizzante, riunendo finalmente Lettere, dialoghi, saggi e una nota azzurra sull’opera di Italo Calvino e di Gianni Celati usciti in tempi e sedi diverse, presenta una nuova edizione del suo Il geografo e il viaggiatore (Metauro 1993), e l’evento, per il calibro dei nomi convocati sulla copertina del libro stampato dalla pavese Effigie, merita di essere felicitato: se su Calvino, disegnatore di possibilia solcati da rette e parallele, in continuo scarto dallo sguardo pietrificante di Medusa, evidentemente non ci si stanca di scrivere e riflettere, le più fresche fortune di Celati, tra la consacrazione del Meridiano e la ripubblicazione di prose e interventi dimenticati (recentissima quella di Animazioni e incantamenti, a cura di Nunzia Palmieri, L’Orma 2017), trovano nella riproposta di questa storica monografia, ampliata per l’occasione, un affettuoso corollario critico, da confrontare magari con le carte edite nel frattempo, ormai vent’anni fa, da Mario Barenghi e Marco Belpoliti in «Alì Babà». Progetto di una rivista 1968-1972 (Marcos y Marcos 1998), che delle riflessioni della raccolta di Rizzante è per più aspetti l’antefatto documentario.
La voce di Rizzante (poeta, traduttore, saggista), che fin dall’epigrafe non occulta i riferimenti a Montaigne, si incarica di accompagnare il lettore lungo le quattordici brevi stazioni di cui si compone il libro, anticipando, nell’indiretto scambio epistolare con Celati che sigilla l’incipit Dell’amicizia, la natura fondamentalmente simpatetica delle pagine a seguire.
In questione, e le due digressioni sulla curiositas ne sono testimonianza, non sono soltanto le differenti posizioni intellettuali di Calvino e Celati, le rispettive risposte a problemi condivisi e spesso discussi assieme (a cominciare dalla coscienza di una Storia ormai in rovina), quanto prima ancora la diversa postura nel rapporto tra fantasia e conoscenza, sensi e intelletto, apparire ed essere. Del resto era lo stesso Celati, in un simposio dell’86 in ricordo dell’amico scomparso l’anno prima, a marcare il proprio distacco dal «delirio di consapevolezza» in cui l’ultimo Calvino si affannerebbe, nemico acuminato del caos, dell’informe, dell’ovvietà quotidiana: da qui può intendersi il rapporto quasi speculare che lega il tragicomico agone cartesiano di Palomar e i vagabondaggi diaristici di Verso la foce, la loro disarmata flânerie attraverso la desolazione padana (e “facile” sarebbe retrodatare il confronto all’iper-romanzo calviniano da una parte, il minimalismo anonimo delle novelle di Narratori delle pianure dall’altra).
Questione di ascendenti, parrebbe: così, l’«immaginazione sperimentale» di Calvino, che interpreta lo spettacolo del mondo attraverso il galileiano “Libro della natura” diffidando delle apparenze ingannevoli, trova un contraltare nella disposizione apuleiana di Celati all’errore, dove l’ignoranza asinina non è il portato di una condizione ferina da superare, bensì il requisito per accedere alla contemplazione dei fenomeni e della loro serena essenza, per captare le voci provenienti da quell’al di là che è il mondo esterno:
È come se un geografo – scrive Rizzante –, improvvisamente stanco di disegnare le sue carte, si fosse deciso a non calcolare più gli intervalli tra un luogo e un altro e avesse cominciato a misurare secondo il suo passo e il suo respiro tutta la difficoltà e tutta la bellezza di inoltrarsi in una terra incognita, quale in effetti l’esistente è una volta dimenticati meridiani e paralleli;
come se – scriveva Lino Gabellone, altro frequentatore della grotta di «Alì Babà» – quello che sta fermo si fosse finalmente messo sulle tracce di quello che cammina, esponendosi all’incanto sensuale del paesaggio e al tempo che passa.
L’ironia, il dubbio razionalista dietro cui il Calvino combinatorio si trincera; la qualsiasità e il sentito dire ai quali Celati stuporosamente si abbandona: non si tarda a capire per quale delle due forme propenda l’autore – indicativo l’elogio della nostalgia dell’analfabetismo di José Bergamin, nella Prima postilla –, sensibile all’idea di una narrazione umorale ed eternamente spaesata, alla fantasticazione per «l’aperto mondo sotto l’aperto cielo» dell’esperienza, per dirla con un bel motto del dialogo Sulla fantasia.
Eppure, viene da pensare, Calvino è anche altro: il suo lascito letterario non può ridursi al disperato geometrismo computazionale, al labirinto solipsistico, e la tentazione di eleggere la fatale hybris del signor Palomar, su cui Il geografo e il viaggiatore si apre, a premonizione della morte del suo creatore rischia di consegnare al millennio che questi non fece in tempo a vedere (purtroppo per chi resta) una metafora desolante.
Illuminate abbondantemente le differenze tra i due autori e, tramite alcune sezioni della loro poetica, tra le stagioni culturali cui appartengono, si può finalmente cominciare a indagare la fibra dei rispettivi stili, che è ciò di cui in ultima analisi la letteratura è fatta, e confrontarli tra loro con qualche sorpresa.
Così, alla memoria del Calvino scripturalist che pratica «la scrittura come una specie di disegno a mano libera» – il più grande elogio tributato da Celati all’amico, nel già citato Sulla fantasia –, e in omaggio al «controtempo» rizzantino cui il saggista deve accordare il proprio pensiero in levare, «mentre intorno a lui tutti si accaniscono a pestare sui tempi forti, in battere», mi limiterò a una sola ipotesi.
Confida Celati, ricordando il suo scopritore:
Senza di lui non mi sarei mai messo a scrivere. È stato lui a scoprire su una rivista i primi brani di quello che sarebbe diventato Comiche; è stato lui a propormi di farne un libro per una collana di Einaudi; è stato lui a sollecitarmi a scrivere.
È noto, nella vicenda redazionale dell’esordio celatiano, il ruolo di primo piano giocato dall’editor Calvino, che, patrocinandone la pubblicazione, avrebbe poi suggerito all’autore la soppressione precauzionale di alcune scene audaci (avviando così, all’indomani della stampa e quasi per ripicca, un intenso esercizio di riscrittura); altrettanto nota è la replica di Celati al «quadretto» d’accompagnamento steso dall’amico, con i suoi riferimenti al «disegno infantile» e al geometrismo di Klee: una schermaglia epistolare decisamente istruttiva cui si dovrà la postfazione “a due voci” che sigilla la prima edizione di Comiche (1971), accolta nella collana neo-sperimentale «La ricerca letteraria».
Ma la vera griffe di Calvino mi pare essere altrove, nell’ultima pagina dell’opera.
Comiche si chiude con la rocambolesca fuga del protagonista Otero Aloysio a bordo di una motoretta volante, librata sul «mondo dove tutti giocano a correggerti» in un turbine liberatorio di vestiti sporchi e scartafacci:
Però io li lasciavo volare perché tanto ora volavo anch’io in alto in cielo tenendomi il cappello ben stretto in testa ascendendo ascendendo su questo ciclomotore e nessuno si vede nei paraggi persone note né sconosciute nell’aria che possano fare rilievi sgraditi dunque non m’importa adesso che quei panni sporchi non lavati per una intiera villeggiatura appaiano sparsi nel vento come i fogli del mio quaderno pure usciti o dall’alto gettati ormai inutili nell’ascesa anch’essi sporchi né meno anzi di più pieni di macchie cancellature grossi errori indecenze sentite e riportate certo non da mostrare a qualcuno. Volano e fine.
Conclusione che, per vie morfologiche, attiva la memoria di un celebre explicit calviniano; non quello del Cavaliere inesistente (dei primi romanzi di Calvino, l’unico dichiaratamente apprezzato da Celati), con Bradamente che, strappatasi «la cuffia, le bende claustrali, la sottana di saio», parte al galoppo verso il futuro, e con lei la propria penna che «corre spinta dallo stesso piacere che ti fa correre le strade». Penso piuttosto a un passaggio non meno “ariostesco”, nella cui pensosa levità scorre la linfa immaginativa (l’etimo spirituale, direbbe qualcuno) della nostra coppia:
Ombrosa non c’è più. Guardando il cielo sgombro, mi domando se davvero è esistita. Quel frastaglio di rami e foglie, biforcazioni, lobi, spiumii, minuto e senza fine, e il cielo solo a sprazzi irregolari e ritagli, forse c’era solo perché ci passasse mio fratello col suo leggero passo di codibugnolo, era un ricamo fatto sul nulla che assomiglia a questo filo d’inchiostro, come l’ho lasciato correre per pagine e pagine, zeppo di cancellature, di rimandi, di sgorbi nervosi, di macchie, di lacune, che a momenti si sgrana in grossi acini chiari, a momenti si infittisce in segni minuscoli come semi puntiformi, ora si ritorce su se stesso, ora si biforca, ora collega grumi di frasi con contorni di foglie o di nuvole, e poi s’intoppa, e poi ripiglia a attorcigliarsi, e corre e corre e si sdipana e avvolge un ultimo grappolo insensato di parole idee sogni ed è finito.
Teatro dell’ossessione persecutoria come in Comiche, o, nella breccia su cui il Barone rampante si conclude, melanconico «ricamo fatto sul nulla», la scrittura si rivela un cerimoniale strappato alla fuga del tempo, un sortilegio di parole nel cui incanto, inseguendo i ghirigori tracciati dalla voce narrante, dimenticarsi di sé e aprirsi all’ebbrezza del racconto.
«La scrittura – ricordava Celati a proposito delle fiabe di Imbriani – comincia con gli scarabocchi quando siamo bambini, ed è per forza destinata a concludersi in uno scarabocchio».
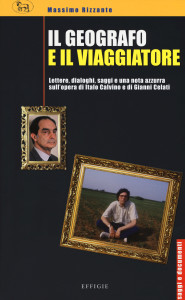 Massimo Rizzante, Il geografo e il viaggiatore. Lettere, dialoghi, saggi e una nota azzurra sulla prosa di Italo Calvino e Gianni Celati, Effigie, Pavia 2017, 134pp. 15€
Massimo Rizzante, Il geografo e il viaggiatore. Lettere, dialoghi, saggi e una nota azzurra sulla prosa di Italo Calvino e Gianni Celati, Effigie, Pavia 2017, 134pp. 15€