Visto che L’altro limite (Lietocolle, 2017) è una plaquette dichiaratamente provvisoria, “il primo momento di un lavoro più ampio suddiviso in tre tempi” (p. 67) che uscirà verosimilmente il prossimo anno, questa che ho scritto non vorrebbe essere una recensione del libro (in parte già edito nel XII Quaderno italiano di poesia contemporanea di Marcos y Marcos), ma piuttosto una nota sulla poesia di Maria Borio.
Con la sua lingua perennemente in bilico tra l’estasi e la presa in giro, William T. Vollmann suggerisce che la letteratura possa modificare la realtà, che le lettere che compongono le pagine che leggiamo possano scappare dal libro e mettersi a correre sui muri e tramutarsi in angeli – e se possono farlo loro, si chiede, perché non anche noi? Non è una riflessione incongrua, davanti ai versi di Maria Borio, perché si ha l’impressione di trovarsi davanti non solo a una poesia che accade («a way of happening, a mouth»), ma anche a una poesia che può far(ci) accadere qualcosa.
Ci sono due parole che, meditando su queste poesie, mi sembrano più eloquenti per capirle: visione ed esperienza. Entrambe richiedono un approfondimento e, in parte, una risemantizzazione.
Visione: non una poesia fatta di visioni, ma che crea una visione. Non versi in cui vengono fatte detonare immagini esorbitanti (e per fortuna: una piccola cascata, un rivolo d’acqua fa più chiasso dell’oceano sterminato), ma che ciononostante costruiscono una visione grazie al continuo accumulo di dati, al succedersi velocissimo di elementi nuovi e apparentemente irrelati, all’interminabile fluire, in forza di enjambement, di immagini discrete ma disturbanti, anche linguisticamente, grazie a continue, piccole forzature della sintassi.
Esperienza: non è, naturalmente, quella che viene riversata nelle poesie (perché se c’è una poesia che non può essere accusata di contenutismo, dove l’io e il tu sono entità fantasmatiche, è proprio questa), bensì quella che questa visione ci offre. Noi non dovremmo cercare (non dovrebbe esserci richiesto di cercare) in poesia idee, sentenze, prese di posizione esplicite: bensì una forma di esperienza, non tematizzata ma espressa, che ci porti a vedere il mondo diversamente.
E quale esperienza ci offre la visione che costruisce Maria Borio? Allo stesso tempo, ci viene mostrato l’amalgama inscindibile che unisce uomini e animali e cose, e gli interstizi tra di essi («l’intercapedine/ che non ci isola», p. 14), dove questi elementi acquistano significato – la loro unicità e insieme la loro indifferenza:
La forma è lo schermo come una casa azzurra,
stilistica e figure, un ritmo che lega gli uomini
nella mia mente. La forma è, non è ciò che volete
io dia. È, non è il divenire. È disfarsi, a volte (p. 18).
Anche se quella di Maria Borio non è evidentemente una poesia influenzata dal pensiero orientale, non ho potuto fare a meno di riflettere che una visione simile richiama da vicino i frutti di alcune speculazioni buddiste che mirano a fare cadere la distinzione intellettualistica tra Nirvana e Samsara, tra il condizionato e l’incondizionato, tra il mondo e la fine del mondo, che non vanno concepiti come binomi, ma come coincidenze. Dice il Sutra del cuore che la forma è vacuità e la vacuità è forma, che la vacuità è costitutiva della forma come la forma lo è della vacuità. Se il Nirvana si pone oltre le nozioni di essere e non essere, è superiore allora tanto all’essere del Samsara, quanto al non essere del Nirvana se concepito in opposizione al Samsara: e solo alla luce di questa comprensione si può vivere ed esperire il mondo. Questo pensiero, implicitamente, mi si è manifestato:
E se le cose prendono nome
all’improvviso la linfa esiste platano,
l’arenaria condominio, il lino ritorto è la giacca,
le gocce enormi che macchiano il catrame
arrivano prima di un temporale forte ma breve (p. 37).
Passi come questo ci danno la misura di quanto, a mio avviso, la poesia di Maria Borio non si limiti a tematizzare questi argomenti, bensì a farli accadere. Il verso, quasi sempre ben oltre la misura dell’endecasillabo, scandisce, grazie all’affollarsi di enjambement, un ritmo lento e ponderoso e tortuoso come un fiume, tanto che quasi non si nota lo scivolamento nelle poche prose del libro, Del male/Del bene e Il cielo (e d’altra parte la poesia che apre il volume, con la sua leggera cantabilità quasi di aria d’opera, testimonia senza difficoltà che quest’esondazione non avviene per imperizia, ma per necessità). Questo fiume trasporta immagini spesso semplici ma di difficile decifrazione, oppure immediate, ma la cui relazione complessiva rimane quasi incomprensibile – ma proprio nell’indecifrabilità e nell’incomprensibilità si nasconde il senso dei versi: «la linfa esiste platano» è un nonsense, dal punto di vista razionale e grammaticale, ma nei sostantivi, nel loro accostarsi anche al netto di un verbo così marcato, è già contenuta la forza di quella che non è (che non viene presentata come) una trasformazione, ma una coincidenza, impossibile e pertanto verissima. Una poesia come La linea dell’orizzonte sembrava il confine del mondo mette in sequenza una quantità di «immagini di incoerenza» che «rincorrono un punto | di fuga interiore»: il mare, le mani, Piero della Francesca, «la lama aguzza del Freccia Rossa», e così via. Il loro assieparsi, tuttavia, è reso sensato dalla nervosa pace della sintassi, dalla solenne calma del versificare, fino a che il significato dei versi non appare chiaro – benché mai davvero esplicitabile. Alla fine, il succedersi di immagini si spalanca su «i poli | antipodi e uniti del pianeta [che] strappano l’orizzonte l’uno all’altro»: «Esseri fragili hanno occhi che si toccano» (p. 27).
Come durante una meditazione, si affollano i pensieri, ma il loro presentarsi e svanire va accettato senza fastidio e senza attaccamento, mentre la mente torna a concentrarsi sul respiro – sul senso inesplicabile del respiro, su ciò che il respiro comporta. Non è una metafora impropria, questa della meditazione: perché, come la meditazione, la poesia di Maria Borio ha un vasto portato intellettuale, ma è lontana da qualsiasi tentazione di verbosità intellettualistica, di programmaticità sterile, e per trasmettersi richiede concentrazione emotiva prima che intelligenza razionale. La visione che crea questa poesia, in altre parole, non è frutto di un collage a freddo di elementi irrelati, ma la resa del loro legame intimo vero, la visione della struttura che permette di legarli:
Nulla si rigenera, ma è prolungato, infinito
nella linea che separa gli oggetti e fa cose
per pensare, per abitare: un grande uovo, ad esempio,
si spacca senza perdere liquido e bianchissimo invade
gli angoli del soffitto, apre un arco, una porta
tra i continenti.
[…]
La vita è ovunque, in una linea curva
ognuno abita come pensare.
Le api ora lasciano la bocca perché le penso.
Rivolgere il pensiero alle ragioni razionali o al funzionamento pratico della meditazione vanifica lo scopo della meditazione; pensare le api le fa volare via dalla bocca. Ogni forma di comprensione che non sia quella che solo l’esperienza emotiva permette è destinata a fallire nel tentativo di cogliere la verità. Per capire, chi guarda deve azzerarsi, farsi muto: «Il contatto della notte è indistinzione | il contatto del giorno è indistinzione, | le nostre maschere portano lettere identiche. | Come madre e padre lo sguardo è una cosa infinita, | una linea senza giudizio» (p. 21).
Quando si parla di testi nei quali si ritrova, in forma concreta, qualcosa di cui si è convinti (qualcosa che si era certi di sapere, che forse si era certi di poter fare: ma con una certezza imprecisa, nebulosa), il rischio inevitabile è di finire per parlare di sé e delle proprie idee, e non dei testi. Quando, circa un anno fa, ho partecipato a una rubrica su Nuovi Argomenti con un breve intervento a proposito di una figura retorica a mia discrezione, ho scelto l’iperbato, perché, «più di tutte le altre figure di sintassi, marca la differenza tra lingua della poesia e lingua parlata, rendendo controintuitivo e di difficile scioglimento il significato dei versi». Questa torsione sintattica, scrivevo, «porta con sé anche una forte funzione conoscitiva: l’allontanamento nel testo di parole che si dovrebbero accompagnare mette in cortocircuito parti del discorso altrimenti separate, conferendo alla poesia e al suo periodare un’impressione di simultaneità che stimola l’immaginazione e il pensiero del lettore». Quello che cercavo di dire (quello che la neutralità di un discorso sulle figure retoriche mi permetteva di dire senza ritorsioni) è lo stesso che ho cercato di dire a proposito della poesia di Maria Borio: la letteratura, prima di tutto, come esperienza; come frutto, forse, di un’esperienza del mondo difforme, ma soprattutto come oggetto (come, in senso mistico ma non troppo, visione) in grado di aprire gli occhi al lettore su un nuovo modo di guardare le cose. La letteratura come strumento di una conoscenza emotiva e irrazionale:
guardo i nomi, sono ancora qui dentro,
stanno per sbilanciarsi sul
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaamio sangue mio
che non può parlare né suggerire,
ma lascia un’emozione in ognuno
di voi, per finire con me
all’interno, ma sempre meno
sempre meno fino a sparire,
nessuna traccia di me,
un alone che dal platano torna all’albero
dalla linfa alla foglia dall’arenaria alla terra
dall’edificio alla casa, da io e te
a una persona, un’altra persona,
dal nostro conoscerci sui desideri
all’amore – dal mondo al mondo
a un altro mondo, senza storio
eppure lungo nella storia, un mondo
attraverso tutta questa verità
che c’era prima, che c’è sempre stata (p. 38)
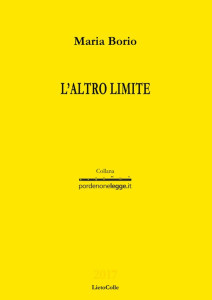 Maria Borio, L’altro limite, Faloppio, Lietocolle, 2017, pp. 65, € 13.
Maria Borio, L’altro limite, Faloppio, Lietocolle, 2017, pp. 65, € 13.