Sappiamo così poco degli scrittori in generale e ancora meno di quelli dell’Est che la lettura di Volevo tacere di Sándor Márai può emendare in un colpo solo l’uno e l’altro difetto. La bellezza della sua scrittura romanzesca non si ritrae in queste pagine a metà tra saggio e confessione. L’Ungheria degli anni Trenta e Quaranta, «quel paese che si poteva vedere da un aeroplano o nell’anima di un poeta», è l’oggetto di analisi di questo testo, che l’autore non ha voluto pubblicare in vita se non parzialmente e di cui esce quest’anno l’edizione integrale, a quasi settant’anni dalla sua stesura e a quasi trenta dalla morte dell’autore.
Raffinato romanziere, nato nel 1900 e morto nel 1989, autore di Le braci, Divorzio a Buda, La recita di Bolzano – titoli tutti adelphiani –, Márai affida a queste pagine un’appassionante disamina della situazione ungherese a cavallo di quei due tragici decenni, in cui prima il nazismo poi il bolscevismo hanno strozzato la nazione magiara. Ma pur demandando agli storici uno studio più completo dei problemi che in quegli anni si sono intrecciati, l’autore si sente legittimato a esprimere la sua visione in virtù di una triplice identità minacciata da più fronti, cioè in quanto scrittore, ungherese e borghese.
L’orgoglioso legame di Márai con la sua nazione è un elemento di fascino del libro, forse anche perché, conoscendo noi generalmente poco di essa, veniamo situati in un punto d’osservazione originale, interno a quello che per noi si configura come un paese culturalmente lontano, assimilabile a un’onda nel gran mare slavo, laddove invece i continui smottamenti e le sovrapposizioni culturali hanno percorso una Storia intrigante e centrale nel contesto europeo. Le diverse tappe di una storia millenaria vengono rievocate, seppur a volo d’uccello, per arricchire di sfumature l’identità degli ungheresi, passata attraverso un crogiolo incessante e poi compressa tra i blocchi nazista e bolscevico. Ma mentre la dimensione culturale interpella il lettore allargando il suo orizzonte, l’aspetto politico è forse quello meno interessante benché non manchi di punte notevoli, come quando Márai preconizza l’unità doganale e monetaria dell’Europa occidentale (l’aggettivo è dell’autore), mentre un anziano interlocutore lo previene e ci mette in guardia dalle utopie: «il mondo è materia infiammabile… Non è possibile rinchiuderlo nelle casseforti ignifughe di progetti e accordi».
In quanto scrittore, Márai ha una sensibilità che gli storici e i politologi forse avrebbero in misura minore: la consapevolezza di maneggiare una lingua viva e forgiata nei secoli, anche se meno prestigiosa di altre, per ignoranza altrui più che per mancanza propria. I riferimenti a questo «idioma strano, estremo-orientale, solitario» compaiono a più riprese, ma in particolare in due occasioni: lo studio budapestiano in cui Márai lavorava era tappezzato di libri tra cui molti dedicati all’origine e alla storia della sua lingua («Possedevo molti vocabolari e anche enciclopedie; collezionavo tutti i dizionari che spiegavano le correlazioni lessicali e le origini della lingua ungherese»); in un altro capitolo l’autore racconta la sua scelta di sostituire all’anagrafe il cognome tedesco con quello ungherese, già usato come pseudonimo letterario, quando molti svevi rinunciavano ai lori cognomi ungheresi e ripristinavano gli antichi cognomi tedeschi in consonanza con il crescente potere dei nazisti in Europa.
Nel momento in cui redige Volevo tacere l’autore è un uomo spogliato di tutto. Se all’inizio del volume può scrivere che un tempo «era uno scrittore e giornalista alla moda in un piccolo paese dell’Europa orientale», più avanti ci lascia il fotogramma bianco e nero della sua condizione: «Mentre scrivo queste righe, sull’unico documento ufficiale che conservo nel portafogli, dopo il mio nome compare la dicitura apolide – dunque sono senza patria» (condizione resa più amara dalla perdita di un figlio).
Dicevo, all’inizio della recensione, forse un po’ esagerando, che sappiamo così poco degli scrittori in generale e ancora meno di quelli dell’Est che la lettura di Volevo tacere può emendare l’uno e l’altro difetto. Nelle pagine di questo libro ci ritroviamo come davanti a uno specchio che abbia catturato l’immagine dell’autore, colto in mezzo agli sballottamenti interiori, tra dubbi, risposte, travagli personali e storici, con intermittenti addentature nella creazione letteraria. Documenti simili non mancano nelle nostre biblioteche e, non diversamente da questi, Volevo tacere ci dà per poche ore (il tempo di lettura) l’illusione di condividere una passeggiata con Márai, di vedere i suoi romanzi nella luce di chi li ha composti, che il nostro destino coincida con quello dell’Ungheria e che il nostro mondo sia sulla soglia della fine, che dai nostri romanzi non dipenda nulla benché siano inseparabili dalle nostre vite.
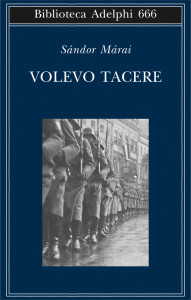 Sándor Márai, Volevo tacere, traduzione di Laura Sgarioto, Adelphi, Milano 2017, pp. 147, 17€
Sándor Márai, Volevo tacere, traduzione di Laura Sgarioto, Adelphi, Milano 2017, pp. 147, 17€