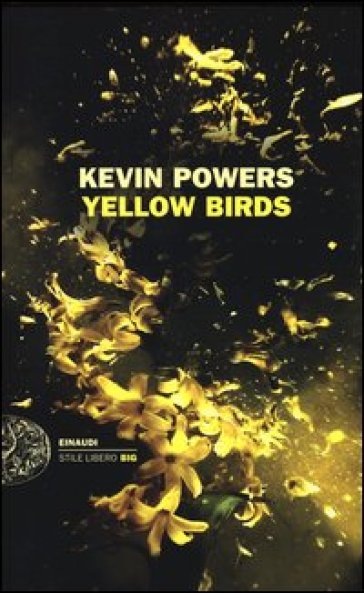Yellow Birds è stato accolto in modo molto positivo dalla critica e dal pubblico. Vincere il Guardian First Book Award 2012 ed essere tra i 10 migliori libri dell’anno per «The New York Times Book Review» è un ottimo risultato per un’opera prima, soprattutto per un libro di questo genere. Lo scrittore Dave Eggers lo ha definito come: «il miglior libro che abbia letto sulla guerra: essenziale, incredibilmente preciso, perfetto. Probabilmente è il libro più triste che abbia letto negli ultimi anni. Ma triste in modo importante». È, in effetti, un libro triste, ma di quella tristezza che vuole far pensare, meditare su ciò che ci circonda e che, come lettori italiani, ci ha riguardato in prima persona, dato che anche il nostro esercito era di stanza in Iraq e ha preso parte alle operazioni militari svoltesi a partire dal 2003. Yellow Birds è quindi un libro che parla di guerra ed è intriso di scene crude, ma ha una particolarità: diversamente dai numerosi film e libri che si sono occupati dell’Iraq questo è il resoconto di un’esperienza vissuta in prima persona, lontano dagli intenti di un libro-inchiesta o un docufilm di denuncia. L’autore Kevin Powers si è arruolato nell’esercito a diciassette anni per fuggire dal niente di una vita in Virginia, e ha combattuto come mitragliere in Iraq nel 2004 e nel 2005.
Probabilmente, in questo caso, si può tornare a parlare di letteratura dell’esperienza. Questo non è un diario né un memoriale, è un’operazione più profonda, più articolata, che vede nella scrittura proprio la possibilità e il luogo privilegiati per dare ordine e significato all’esperienza vissuta. La guerra è una delle protagoniste principali, e passa attraverso forme continuamente diverse: dall’odore di morte ai cumuli di cadaveri, dai resti delle case alla polvere sollevata dai proiettili per le strade. «La guerra provò a ucciderci in primavera», così si apre il libro. Non c’è distacco, né il tentativo di raccontare solo una storia, con una sua logica e una sua morale precise. Non c’è solo l’immaginazione di uno scrittore che racconta da una posizione protetta e separata da un filtro: qui l’unico filtro attivo è eventualmente quello della memoria, ma è una memoria che passa anche dai nervi, dal corpo. Piuttosto c’è il disperato tentativo di un sopravvissuto di mettere ordine nella sua vita e nei ricordi ormai andati in pezzi. Non c’è nemmeno la volontà di recuperare una possibile epica della guerra, di presentare gesti eclatanti, anche se in certi passi ci sono elementi riconducibili ad una sorta di codice: la difesa dell’amicizia o della parola data. Tutto però è superato dal tentativo ultimo che sembra invece quello di dare un significato, a posteriori, a quanto si è fatto, a quanto si è commesso e vissuto.
Siamo oltre la volontà di raccontare una porzione di verità per smentire delle narrazioni ufficiali. Non si può parlare di contronarrazione in quest’opera, non c’è nessuna verità da opporre a nulla, c’è soltanto la trasposizione di una sofferenza e della difficoltà immensa di gestire il dopo.
La trama si può riassumere in poche parole: due ragazzi dell’America profonda, Bartle e Murph, si incontrano in New Jersey, in un campo di addestramento dell’esercito, e vengono spediti in missione in Iraq. I due diventano molto amici e Bartle, spinto da una sorta di spirito protettivo, promette di difendere e riportare Murph a casa sano e salvo. Purtroppo è la guerra a vincere e Murph muore. Tutta la narrazione è volta a cercare di costruire o ricostruire l’unità consequenziale delle azioni, la catena di causa-effetto degli eventi all’interno di una dimensione logica. Questo tentativo però è destinato a fallire. Non c’è la creazione di una suspense perché sappiamo già dalle prime pagine che il giovane Murph morirà, lo sentiamo come presentimento, e questa morte diventerà la colpa di Bartle. Egli si addossa la responsabilità di un tradimento che non riguarda una promessa militare, ma piuttosto una affinità personale, un’amicizia che ha come unica colpa quella di un pessimo tempismo. Legato a questo tempo sbagliato c’è il caso, che rappresenta un altro elemento importante del libro. In contrasto con lo strenuo tentativo da parte della scrittura di creare un resoconto lineare o, in qualche modo, affidabile di ciò che si è vissuto in prima persona, c’è la resistenza della casualità assoluta con cui si presentano alla memoria le immagini e i frammenti dei ricordi. Tutto ciò che succede in guerra è legato al caso, qualche centimetro più a destra o a sinistra e si muore.
Si vive per pura fortuna così come si muore per sfortuna, ma in questa totale aleatorietà c’è chi decide di riprendersi un po’ di umanità, come Murph, che si “perde” nei ricordi di casa, della sua vita e di ciò che ha lasciato in Virginia. Questa scelta non premia, bisogna «rimanere degli psicopatici», come dice il sergente Sterling, altrimenti si muore. E Bartle fa suo questo insegnamento, abbraccia la casualità delle azioni, l’apatia verso la morte altrui: un atteggiamento necessario per sopravvivere, insieme a quel distacco quotidiano da sé stessi che la guerra impone, lontani anni luce dai propri ricordi e dalle proprie emozioni. Provare sentimenti mette in pericolo perché tutto ciò che è individuabile e a cui ci si può affezionare alla fine va in pezzi, come accade alla ragazza paramedico che muore sotto gli occhi di Murph.
L’abitudine a questa alienazione da sé si paga, però, nel dopo, e qui si intrecciano i piani della struttura narrativa: l’alternanza temporale tra le azioni di guerra in “presa diretta” (i capitoli dedicati al 2004, agli scontri nella città irachena di Al Tafar) e il ricordo delle fasi precedenti alla partenza per l’Iraq (il capitolo datato 2003), così come quelli che riguardano il ritorno in Virginia di Bartle (i capitoli con data 2005). Tutto ricorda sì un percorso di perdita dell’innocenza, come è stato scritto, ma che non è lineare e non trova nemmeno alcun riscatto, e forse, in fondo, non è mai esistita nemmeno una vera innocenza da perdere. È come se dopo aver perso la capacità di provare qualsiasi sentimento l’unico modo per fare gli uomini – questa volta non per dover dimostrare qualcosa ma per recuperare un senso di umanità – fosse aggrapparsi alla colpa, farsi carico della colpa, anche quando non è del tutto chiaro quale sia. La colpa di aver illuso qualcuno, la colpa di aver tradito una promessa, una parola data, o anche la colpa di aver provato pietà o di non averne provata affatto. Il finale sembra proporre un tentativo di riscatto possibile, che però si compie solo nell’immaginazione e in un momento quasi di raccoglimento in cui Bartle pensa al corpo di Murph trascinato dalla corrente del fiume Tigri: come in un antico rito, una forma di rispetto e di commemorazione dei morti; è la poetica immagine del cadavere di Murph che si ricongiunge al mondo, alla materia del mondo nella Culla della Civiltà, lontana da ogni possibile riduzione apportata dalle carte geografiche che Bartle consulta mentre è in prigione o che sono visionate da qualche generale seduto in «una stanza calda e asciutta e sicura».
 Ciò è possibile in una dimensione privata che non può essere compresa al di fuori, perché la società civile ha bisogno piuttosto di qualcuno che paghi un prezzo. L’individuo porta la colpa mentre la società esige un prezzo. Il libro presenta anche un tentativo continuo di far cortocircuitare la percezione personale, individuale, e il ruolo statale, esattamente come avviene anche nell’esercito dove ogni soldato rappresenta lo stato, e nelle operazioni militari ci si muove come un solo uomo, un solo corpo. Ma lo stato continua, è sempre integro, mentre i soldati vanno in pezzi, la loro percezione del mondo va in pezzi e non riescono più a ricollocarsi nella normalità. Lo stesso Bartle si sente sparire quando, tornato a casa, si toglie la divisa per mettersi a letto: «via l’anfibio sinistro e il calzino sinistro. Via i pantaloni. Via le mutande. Non c’ero più».
Ciò è possibile in una dimensione privata che non può essere compresa al di fuori, perché la società civile ha bisogno piuttosto di qualcuno che paghi un prezzo. L’individuo porta la colpa mentre la società esige un prezzo. Il libro presenta anche un tentativo continuo di far cortocircuitare la percezione personale, individuale, e il ruolo statale, esattamente come avviene anche nell’esercito dove ogni soldato rappresenta lo stato, e nelle operazioni militari ci si muove come un solo uomo, un solo corpo. Ma lo stato continua, è sempre integro, mentre i soldati vanno in pezzi, la loro percezione del mondo va in pezzi e non riescono più a ricollocarsi nella normalità. Lo stesso Bartle si sente sparire quando, tornato a casa, si toglie la divisa per mettersi a letto: «via l’anfibio sinistro e il calzino sinistro. Via i pantaloni. Via le mutande. Non c’ero più».
Si deve riconoscere a Powers una notevole capacità descrittiva che si alterna ad immagini di alto lirismo – l’autore è principalmente un poeta –, in grado di rendere vivide le scene narrate, anche in punti dove forse l’abitudine ad un immaginario della violenza da parte del lettore potrebbe portare ad una certa indifferenza. Non è però un lirismo di maniera, non c’è nulla di superfluo, né il tentativo di abbellire i momenti descritti né di renderli più digeribili. È un libro profondo e duro, che non vuole offrire alcuna soluzione consolatoria e non cerca un’assoluzione indiretta di ciò che la guerra fa, né tanto meno di chi la combatte: «Dire cos’è successo non basta. È successo tutto. È caduto tutto». Nella scrittura e nella lettura implodono tutti i piani, quelli temporali e quelli spaziali, per lasciare il lettore in una tristezza necessaria e in un profondo disagio causato da un libro che, come dice lo stesso Powers, racconta episodi non necessariamente veri ma che senza dubbio nasce dall’esperienza concreta di un soldato che ha combattuto una guerra alla quale nemmeno lui è riuscito a trovare un significato.
Kevin Powers, Yellow Birds, Einaudi, Torino 2013, pp. 192, € 17