Abbiamo seguito per intero i quattro giorni di CaLibro 2023, il festival che da ormai nove anni porta a Città di Castello, in Umbria, un’offerta variegata e di livello in ambito letterario. Quest’anno CaLibro si è rinnovato e, grazie alla collaborazione di Edizioni E/O, è nato CaLibro Africa Festival, edizione tematica e concentrata sulla letteratura, o meglio, le letterature africane. Tra incontri, presentazioni, letture degli autori, laboratori per l’infanzia, film e spettacoli di musica e danza, dal 28 settembre al 1° ottobre le strade e gli spazi pubblici di Città di Castello hanno potuto ospitare artisti ed esperti, professionisti dell’editoria e del giornalismo culturale provenienti da Africa ed Europa uniti nel clima familiare e accogliente che l’organizzazione del festival è stata così brava a creare. Ha partecipato anche un nutrito pubblico, locale e non, sinceramente interessato ad avvicinarsi, con postura aperta e propensione all’ascolto, alle molte voci, lingue, storie e culture provenienti dal più antico continente del mondo.
A CaLibro Africa Festival ho avuto la possibilità di parlare con Mohamed Mbougar Sarr, scrittore senegalese che con il suo ultimo romanzo, La più recondita memoria degli uomini (2021; traduzione di Alberto Bracci Testasecca, Edizioni E/O, 2022), ha vinto il Premio Goncourt 2021. Sempre pubblicato per Edizioni E/O è l’esordio dell’autore, all’epoca venticinquenne, Terra violata (2015; Traduzione di A. Bracci Testasecca, 2019) con cui vinse il Premio Ahmadou Kourouma al Salone del Libro di Ginevra e il Gran premio del romanzo meticcio all’isola della Réunion. L’ultima uscita italiana è Il silenzio del coro (2018; traduzione di A. Bracci Testasecca, 2023), Prix littéraire de la Porte Dorée nel 2018.
Avere davanti finalmente l’autore che più di tutti desideravo incontrare al festival è sicuramente emozionante; soprattutto quando si tratta di uno scrittore che, in una manciata di anni, ha pubblicato quattro romanzi e un racconto lungo e a trent’anni ha vinto il più importante premio letterario in lingua francese. Ripetendo mentalmente le domande preparate – perché una buona intervista, appurata la disposizione intellettuale degli interlocutori, dipende soprattutto da dove si sa indirizzare la conversazione -, entro nella hall dell’Hotel Tiferno per l’ultima conversazione di CaLibro 2023. Mi si para davanti un giovane uomo in camicia azzurra stirata, dallo sguardo attento ed energico. Mi presento, ci sediamo e io non posso trattenermi dall’esordire con una captatio benevolentiae: “sono un suo ammiratore, sa? Ho letto tutti i suoi libri e sono veramente felice di poter finalmente parlare con lei. Spero che il mio francese sia adeguato, vorrei che questa intervista uscisseal meglio”. Sarr mi guarda sorridente e divertito e mi rassicura con tono complice ma deciso: “sono sicuro che faremo un ottimo lavoro”.
Nel suo ultimo romanzo La più recondita memoria degli uomini, l’intera trama ruota attorno alla potenza della letteratura. La ricerca del misterioso Elimane, scomparso nel nulla, parte dal contatto tra il protagonista e la scrittura sconcertante dell’autore e genera una curiosità incontenibile che permea chiunque venga in contatto con quel testo. Pare che nel mondo abitato dai suoi personaggi, in questo e altri tuoi libri, la letteratura costituisca una pulsione vitale irrefrenabile che unisce e vivifica e una sorta di origine di tutto. È così?
Io d’impulso direi che è sicuramente così ma mentre lo dico mi accorgo che non è davvero così, ed è in questa tensione che vive la maggior parte dei personaggi in La più recondita memoria degli uomini, specialmente Diégane. Lui viene catturato in questa tensione perché ha questa fede assoluta nella letteratura. Ha delle grandi aspettative nei suoi confronti, attende una rivelazione, un’epifania, un’elevazione. Tuttavia, il confronto con la ricerca dell’assoluto nella letteratura espone al suo limite. Il suo potere non si percepisce quasi mai effettivamente come una rivelazione o un’epifania ma agisce più in maniera sotterranea, lavora e ci lavora in modo sotterraneo e carsico.
La più recondita memoria degli uomini è costantemente attraversato da una sorta di danza a due tempi; un primo tempo di grande fiducia, di attesa; il secondo, più ironico nei confronti della letteratura, che la mette alla giusta distanza e che finalmente pone in discussione le sue possibilità. Oggi, alla fine, è come se la letteratura perdesse il suo potere nel momento in cui le chiediamo di dimostrarci che ci può dare qualcosa. Se invece non le chiediamo niente, non pretendiamo che ci dimostri una sua utilità, è allora che il suo carattere vitale appare in movimenti e ritmi più interiori, più lenti, ma anche più profondi. Io mi trovo in questa situazione: è chiaro che provo uno slancio e mi aspetto molte cose dalla letteratura, altrimenti non cercherei di vivere di questo, ma vedo chiaramente che la sua azione non può essere diretta o immediata, né portare una rivelazione e tutto ciò dipende chiaramente dalla soggettività di chi si rapporta con la letteratura. Ci sono persone che possono vivere benissimo senza aver mai letto un libro e che sono molto felici e non dobbiamo dimenticarlo, ma quando sei appassionato di letteratura, e ti capita di leggere qualcosa di grandioso, inizi a pensare che i libri possano aiutarti a vivere e non puoi fare a meno di avere questa speranza, anche se molte delle cose nella vita concreta, reale, contraddicono questa tua fede assoluta.
Lo stile ricercato e vario con il quale utilizza la lingua francese, è certamente frutto di una ricerca della propria voce di grande profondità. Qual è il suo rapporto con la lingua francese e con la letteratura francofona? Ci sono dei modelli a cui si è ispirato?
Mi ci è voluto un po’ di tempo e diversi romanzi prima di approdare a questo stile, deliberatamente eterogeneo. Il tempo che mi ci è voluto è stato il tempo del mio apprendistato della lingua francese, nel suo stile più classico e nelle sue sperimentazioni. Allo stato attuale non credo di aver ancora finito di imparare, mi sento in evoluzione permanente ma sicuramente ho letto e scritto abbastanza in questa lingua da poter essere in grado di destrutturarla ed esplorare un ampio spettro di possibilità. Sento anche di essere al punto in cui posso provare ad inserire all’interno del francese le altre lingue , farle dialogare sempre più tra loro per restituire stilisticamente il mio rapporto di scrittore senegalese con le diverse lingue che parlo. Il lavoro ora è un lavoro di creazione di immagini, di equilibrio delle frasi e di sintassi tra la lingua scritta francese e le lingue dell’oralità. Nell’ultimo romanzo questo si può avvertire in un certo modo nello stile, nell’energia soggiacente ma soprattutto in alcune immagini profonde e fondamentali che riecheggiano questo mio lavoro interiore. Sento di aver finalmente creato il mio linguaggio, una lingua scritta personale, diversa da tutte le altre anche se magari utilizza le stesse parole, che si nutre e mescola in sé stessa l’apporto di diverse lingue ed esperienze.
Per quanto riguarda i miei modelli, nella letteratura scritta in francese, ce ne sono molti. Dico sempre che ho scoperto quasi contemporaneamente Balzac, uno dei miei grandi, grandi amori come lettore, e una scrittrice senegalese di nome Malick Fall, autore di un solo romanzo intitolato La Plaie (1967). Più o meno nello stesso periodo ho scoperto Yambo Ouologuem con Le Devoir de violence (1968), Mongo Beti, Léopold Sédar Senghor e Victor Hugo, Aimé Césaire e Racine. La mia iniziazione letteraria è avvenuta con la lettura quasi in contemporanea di autori provenienti da tutto il mondo (europei, africani, caraibici) che usavano il francese come lingua scritta. Li ho scoperti tutti quasi per caso e in un arco di quattro o cinque anni ho letto moltissimi classici europei, africani, caraibici, nord e sudamericani di autori francofoni. Lo so, sembrano tutti scrittori piuttosto classici ma io penso che i modelli debbano tendere sempre verso i classici, perlomeno all’inizio; non in un senso obsoleto e antiquario del termine ma con l’intenzione di prendere e fare qualcosa con un’eredità che abbiamo e a cui è sempre importante attingere.
Mi viene in mente qualcosa di Céline in quello che hai detto. Lui era in aperta polemica con lo stile classico francese tardo ottocentesco che era preso ancora a modello nella prima metà del Novecento: lo stile Gide, lo stile Proust. Leggendo questo grande autore si ha l’impressione che egli scriva come una specie di mostro, di forza primitiva della natura e in questo sta molta della sua potenza stilistica. Ma nella sua forza distruttiva e innovatrice egli era mosso da un amore immenso per la lingua francese, aveva letto i classici e conosceva la lingua letteraria alla perfezione e non sopportava di vederla imbalsamata in uno stile istituzionale.
Si, esattamente! Per distruggere, destrutturare o creare un movimento eterodosso o eterogeneo all’interno di una lingua bisogna innanzitutto saperla padroneggiare nella sua forma più classica, la più standardizzata e istituzionale. Céline è stato fin dall’inizio un padrone della lingua che ha voluto deliberatamente, come diceva lui, cercare di “far trionfare Rabelais”. Ai tempi di Rabelais lo scrittore più in vista era un tale Amyot, oggi in gran parte dimenticato, che scriveva in uno stile “imbalsamato”. Amyot avrà anche vinto la sfida della notorietà tra i suoi contemporanei ma Rabelais ha trionfato nell’eternità, dice Céline. Questo per evidenziare come lo scarto dalla norma sia l’atteggiamento vincente nel lungo termine ma per potersi distaccare dalle regole in maniera proficua bisogna conoscerle e averle comprese. Tornando a me, penso che l’essere cresciuto in un ambiente plurilingue e provenire da un’altra cultura, nella quale il primo contatto con il francese avviene tramite la scuola, mi abbia avvantaggiato come scrittore. Il francese che ho imparato è quello dei classici e delle istituzioni, un’eredità coloniale. Dopo essermi fatto le ossa con il linguaggio più istituzionale, più standardizzato, il mio lavoro di scrittore è iniziato cercando, a poco a poco, gli scarti dalla norma. Quando non li ho trovati ho cercato di crearne di miei, perché questo è lo stile, è un divario, ciò che chiamiamo una singolarità estetica; è la ricerca o creazione di un passaggio laterale, di un’immagine che sorprenda, di qualcosa che si possa distinguere da un uso già visto che a volte può essere anche considerato più saggio, più rispettoso.
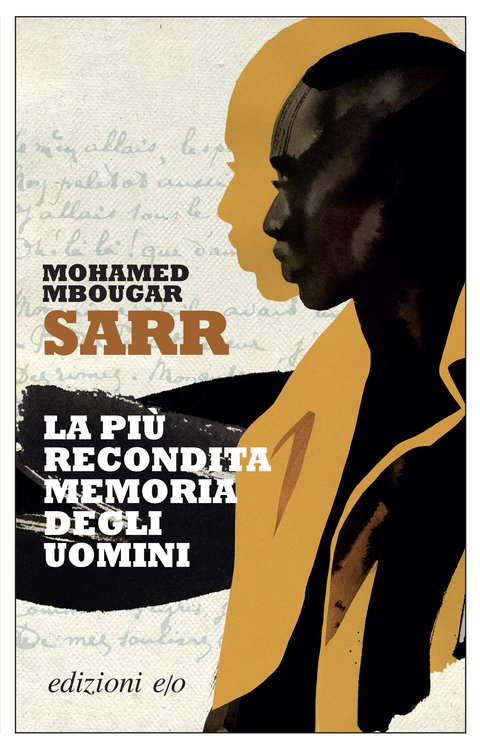
La vittoria del Premio Gouncourt 2021 sembra quasi la progressione e il coronamento del percorso di riconoscimento del protagonista di La plus secrete memoire des hommes, Diegane. Lui è teso tra la comprensibile ricerca di validazione e successo critico e la volontà di non compromettere la propria autenticità, a volte in polemica con la cultura ufficiale francese. Come ha vissuto questa vittoria? È arrivata come un sogno che si avvera o l’ha accettata con qualche riserva?
L’ho accettato con gratitudine perché è un premio importante e soprattutto perché non sono solo in questa avventura. Ovviamente sono io che ho scritto il romanzo, ma in un certo senso questa vittoria premia anche i miei editori Philippe Rey e Jimsaan, premia le persone che hanno lavorato a questo romanzo. Cerco sempre di tenere in mente la dimensione collettiva e questo è un modo di porre la giusta distanza e non farmi schiacciare dalla vittoria o pensare che sia solamente merito mio. C’è gratitudine da parte mia, come dicevo, ma c’è anche un sentimento molto ironico che deriva dal fatto che nel romanzo la legittimazione è tutto ciò che Diégane e i suoi compagni vogliono e non vogliono allo stesso tempo. Questo mi fa sorridere ed è da qui che viene l’ironia, perché mi sento come se fossi diventato un personaggio del mio stesso romanzo. Questa sembra essere la giusta punizione o la giusta ricompensa, non so bene quale delle due, ma in ogni caso è successo e sembra quasi essere una continuazione del romanzo che ormai ha trascinato il proprio autore nella sua narrativa. Ho sempre ribadito quanto i premi letterari costituiscano un incoraggiamento nella fase in cui mi trovo ora, il Goncourt lo è sicuramente stato.
Accetto il fatto che la mia vittoria possa essere interpretata in modo molto simbolico. C’è chi continua a far notare che sono uno scrittore africano, uno scrittore senegalese. Sono passati cento anni da René Maran, il primo vincitore nero del Goncourt e nel mio romanzo c’è tutta una serie di segnali che possono incoraggiare una lettura simbolica o politica che capisco, non lo metto in dubbio; ma ci tengo a ricordare sempre che quello che deve venire prima di tutto è il mio gesto letterario. Questo non significa che io sia interessato solo all’aspetto puramente letterario, perché sono anche contrario all’idea di letteratura isolata dalla politica o separata dalle grandi questioni sociali contemporanee, ma io metto al primo posto il gesto letterario perché è da quello che deriva tutto il resto e considerare più importante qualche altro elemento sarebbe un errore interpretativo.
Oltre alla gioia ho vissuto anche una grande curiosità per ciò che La più recondita memoria degli uomini ha innescato nella società francese, senegalese e in tutte le società in cui il libro è arrivato attraverso le traduzioni; è sempre molto interessante vedere la reazione che un tuo libro può provocare. In Senegal la ricezione ha assunto una dimensione polemica perché la vittoria del premio Goncourt ha riattivato la questione del rapporto con la Francia: la vecchia tensione tra centro e periferia, tra l’ex colonia e l’ex colonizzatore. Si è rialzato lo spettro di un rapporto ancora abbastanza teso, in cui è sempre l’ex colonizzatore che premia il colonizzato e in questo senso a qualcuno sono apparso quasi come un traditore per aver accettato gli onori di un premio letterario francese. Come se io avessi dovuto sacrificare qualcosa della mia cultura, del mio essere senegalese. C’è stato questo sospetto e poi una polemica che si trascinava dal mio romanzo precedente De purs hommes (2018). Quando venne pubblicato per la prima volta era ancora considerato tabù (affrontando il tema della condizione omosessuale in Senegal, Ndr), non venne letto molto e finì per essere ignorato dal pubblico. Ma non appena si sparse la notizia della mia vittoria al Goncourt per La più recondita memoria degli uomini, il precedente romanzo finì di nuovo sotto i riflettori.
Molta gente si è detta, be’ questo è un autore che vince premi perché scrive libri come De purs hommes, che criticano la società senegalese. Mi hanno più volte accusato di creare deliberatamente polemiche in Senegal per attirare attenzione sui miei libri. Io penso che sia sempre interessante quando una polemica parte da un libro perché questo può restituirmi un’indicazione di chi sono e come sono percepito come scrittore all’interno di una data società. Quindi ho vissuto anche questo aspetto ma fortunatamente è stato marginale. Io faccio tesoro di tutto e celebro la parte gioiosa, fatta di riconoscimento, gratitudine e della sensazione che questo libro e questa vittoria siano stati qualcosa di importante per il Senegal, la storia letteraria e i giovani scrittori e lettori senegalesi.
Una domanda su Il silenzio del coro, uscito nel 2017 ma tradotto in italiano quest’anno. Nel romanzo, incentrato sulle vicende di accoglienza di migranti in un piccolo paese siciliano, si alternano le voci di chi prova ad accogliere e di chi è accolto e vengono spesso evidenziati i modi in cui i migranti vengono etichettati con connotati di alterità. Gli stessi membri dell’associazione non possono fare a meno di trattare da vittime “i ragazzi”, riducendo così le loro individualità e minando il loro diritto di avere un futuro proprio. Pensa che questa sia una manifestazione involontaria di razzismo? Il razzismo è talmente radicato nella società che anche i “buoni” ne sono portatori? Si può ancora parlare di razzismo o si tratta più di pregiudizi economici?
Questa è una domanda molto complicata perché in effetti, nel rapporto con i rifugiati o i migranti, c’è un miscuglio di molte cose. A volte è razzismo duro e puro, vale a dire la sensazione, perché questo è il cuore del razzismo, che l’altro sia inferiore. Quindi l’inferiorizzazione, non solo la differenziazione, ma l’inferiorizzazione dell’altro: culturalmente, intellettualmente, moralmente, e così via. A volte è così, ma altre volte può essere solo una sorta di paura dell’altro perché non lo si conosce, può essere semplicemente ignoranza; può anche venire da difficoltà economiche o sociali molto profonde nelle società che accolgono perché l’immigrato crea un sentimento di insicurezza sociale – non insicurezza culturale, ma sociale, che genera diffidenza, rigetto e infine alimenta la discriminazione e il razzismo.
Dopodiché, ed è qui che la cosa diventa molto complessa, il fatto è che il sentimento di carità ha dei limiti. Quando si vuole aiutare qualcuno bisogna porsi sempre la domanda “da dove aiutiamo?” Stiamo creando una relazione orizzontale o una relazione verticale? Quando si tratta di una relazione verticale c’è sempre uno sfondo di gerarchia: l’altro essere umano è considerato come un superiore, un inferiore, un amante, un fratello o una sorella. Ci sono persone che vogliono insistentemente farsi carico dell’angoscia degli altri da sole e che cercano di mettersi al loro posto ma la verità è che c’è un limite. Vi è una linea estremamente sottile tra l’empatia orizzontale e l’empatia verticale, che non porta con sé il razzismo ma la traccia di una relazione che è stata e a volte rimane ancora una relazione di dominio simbolico, ed è questo che rende queste relazioni molto, molto difficili. È necessario trovare la giusta distanza, la relazione giusta con l’altro essere umano in modo che l’accoglienza sia efficace. Una modalità per la quale colui che accoglie non dia l’impressione di sentirsi superiore e colui che viene accolto non si senta inferiore. È difficile, ma credo sia qualcosa da costruire a tutti i costi. Tendiamo ad avere l’impressione che tutta la responsabilità ricada sulla persona che accoglie ma alla fine si tratta di una relazione e anche colui che viene accolto ha sempre qualcosa da portare alla costruzione di questa relazione. Perché ciò avvenga, le condizioni dell’accoglienza devono essere davvero soddisfatte: un’accoglienza che abbia al suo centro la sensibilità, tutto qui. A volte a volte non ci riesce, si fallisce, o per razzismo diretto o perché sotto la carità si nasconde una relazione verticale. Quando si vuole accogliere qualcuno non si tratta solo di aprirgli la porta; si tratta di aprirgli la porta considerandolo come un essere umano completo, e questo è molto, molto difficile.
Ho voluto parlare di immigrazione in Italia perché questo è un paese con una forte tradizione di viaggi ed emigrazioni, nel quale la mescolanza di popoli e l’accoglienza sono sempre state fonte di ricchezza e orgoglio, fino a poco tempo fa. Quando un migrante racconta la sua storia, sta anche raccontando la storia del paese dal quale viene e del paese che lo accoglie. Le loro storie sono anche le storie del popolo italiano e contribuiscono all’immagine globale dell’Italia. Quando osserviamo con un occhio sensibile alla Storia e agli equilibri mondiali ci rendiamo conto che l’Italia ricopre un ruolo di importanza simbolica non indifferente, a livello geografico e storico. Ci sono migranti quasi in ogni paese e quelli del Sud del mondo sono interessati dai flussi più massicci ma il fatto che l’Italia sia da molti identificata come una porta simbolica all’Europa è un fatto che fa riecheggiare la fondazione dell’Unione, l’Impero romano, un’intera mitologia di cui l’Italia è un simbolo molto, molto forte. Penso che la storia d’Italia faccia capire molto bene cosa significhi migrare, qualcosa di noto a tutti i popoli umani ma che qui, in particolare – attraverso la storia, attraverso tutti i popoli che sono arrivati, attraverso le diverse dominazioni che si sono succedute, l’emigrazione e l’esodo degli italiani nel mondo – si può percepire distintamente. Spero che la consapevolezza di tutto questo torni ben salda nella mente degli italiani e mi auguro che la loro tradizione di ospitalità trionfi. Anche se la gestione politica di questi fenomeni può essere, ed è stata disastrosa la gente non deve permettere che la vita delle persone diventi un mero dato statistico. Questo allontana da tutti i fondamenti culturali e storici di cui parlavo ed espone a manipolazioni in chiave identitaria. Quando il discorso pubblico si sposta sul terreno dell’identità è una sconfitta. Si permette alla politica di evitare di gestire i problemi e si riduce il dibattito a un’opposizione inutile. Non ci si deve permettere di rifiutare una visione di continuità con chi arriva in cerca di un futuro migliore. Una continuità che potrebbe portare verso l’inizio di una riflessione sulla propria storia, su ciò che si è stati, chi si è e chi si vuole diventare.
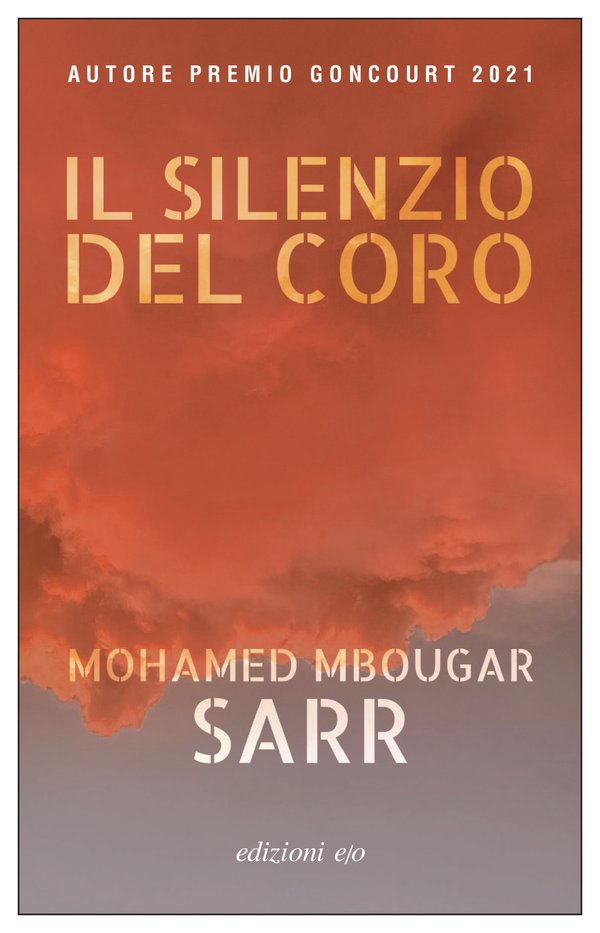
(Questa intervista è stata condotta presso l’Hotel Tiferno di Città di Castello, il 30 settembre 2023. È stata trascritta ed editata a fini di maggiore chiarezza. Ringrazio Mohamed Mbougar Sarr per la disponibilità, Giulio Passerini di Edizioni E/O per aver organizzato l’incontro, Lorenzo Alunni e tutto lo staff di CaLibro per l’accoglienza nei miei confronti e per la bellezza di questo festival).
