Dopo Le nostre ore contate (Mondadori, 2018), con cui si è aggiudicato il premio Bagutta Opera Prima, Marco Amerighi pubblica con Bollati Boringhieri il suo secondo romanzo, Randagi, un’opera ibrida e a suo modo coraggiosa, a metà strada tra il classico romanzo di formazione, il romanzo generazionale e territori narrativi più sperimentali.
La vicenda si sviluppa seguendo la parabola esistenziale del pisano Pietro Benati e della sua famiglia, su cui grava una singolare maledizione: prima o poi, in un momento non meglio precisato della loro vita, tutti i maschi Benati spariscono per un lasso di tempo più o meno lungo, e quando fanno ritorno le circostanze della loro fuga rimangono avvolte nel mistero. Pietro trascorre quindi l’infanzia e la preadolescenza con il terrore di “sparire”, mentre la “maledizione Benati” sembra non angustiare per nulla il fratello maggiore Tommaso, sorta di stupor mundi quattordicenne che trasforma in oro tutto quello in cui si cimenta, dallo studio al calcio ai rapporti con l’altro sesso. Eppure, Pietro “scompare” davvero per poco più di due minuti quando avvicina le labbra a un microfono, folgorato da una scarica elettrica al suo primo saggio di pianoforte. Prima di rinvenire, Pietro ha una visione: un corvo che si posa su una chitarra elettrica (desiderio d’evasione inconfessato) confitta nella sabbia del deserto.
La narrazione procede poi seguendo sia il ménage familiare che i molti e cocenti insuccessi di Pietro, che non brilla nello studio, tenta invano di costruirsi una carriera come musicista ed è timido e impacciato con i coetanei. La prima parte di Randagi si chiude tuttavia su una nota tragica che è giusto non rivelare. Pietro taglia quindi di netto tutti i ponti con la famiglia e si trasferisce a Madrid per frequentare l’università, dove inizia ad appassionarsi alla letteratura spagnola e fa la conoscenza di due comprimari fondamentali per i futuri sviluppi della trama: Dora Manfredini e Laurent Morin. Il rapporto che si stabilisce tra loro si basa su una continua e verosimile logica di attrazione e repulsione, di incontri abortiti o fortuiti, di momenti sì memorabili, ma imprevisti e inattesi. Pietro, Dora e Laurent sono divisi tanto dai rispettivi caratteri quanto dalle circostanze che di volta in volta si frappongono tra loro o liberano la via. È l’annuncio di un matrimonio a far tornare Pietro in Italia per lo scioglimento finale.
Si diceva in apertura che Randagi è a suo modo un’opera coraggiosa. Lo è sicuramente nel tentativo riuscito di avvicinare una materia difficile perché cronologicamente recente, ovvero uno sguardo d’insieme sulla generazione nata all’inizio degli anni Ottanta, la prima sradicata a forza dal sogno propagandistico di un benessere eterno e di infinite quanto dolcemente remote possibilità di scelta riguardo il proprio futuro, una generazione che ha visto il progressivo dilatarsi degli orizzonti (non più solo l’Italia, ma l’Europa come possibilità di studio, lavoro e di vita), la moneta unica e la nascita di internet, l’attentato alla stazione di Atocha dell’11 marzo 2004 (a cui un’amica di Pietro scampa per pura casualità). Per i suoi coetanei, Marco Amerighi ha coniato la categoria dei randagi, meritoriamente più poetica di altre (di certo non uno scrittore deve aver pensato orrori del calibro di baby boomers, millennials, gen. Z ecc…). Per i randagi, nulla può considerarsi acquisito una volta per tutte, ogni strada intrapresa non è quella giusta o quella davvero voluta. I randagi, in un mondo che si allarga a perdifiato e in cui è tanto più difficile trovare un posto, sono costretti a procedere per tentativi, cambiano spesso direzione all’improvviso, tornano sui loro passi e ricominciano. Pur nella propria irriducibile singolarità, Pietro Benati ne rappresenta bene il prototipo.
Amerighi riesce a costruire un protagonista credibile, in bilico tra realismo e surreale accanimento della sorte, lo sfortunato eroe di un romanzo picaresco e un giovane in perpetua lotta con il demone del fallimento. Pietro Benati viene ritratto in perenne affanno, quasi sempre sconfitto ma pervicacemente assiso sulle proprie posizioni ingenuo-intransigenti, e quindi capace sì di assorbire i colpi, ma mai di fare un passo avanti. È questo che tiene Pietro ancorato a una passività il più delle volte inerte e pensosa, la considerazione umana-troppo umana che ancora non ci sia la strada da percorrere, quella che dalle nostre intime aspirazioni ci conduca, non senza fatica ma una volta per tutte, là, dove per là si intende una sorta di fusione tra un luogo dell’anima e reali circostanze di vita, là dove dovremmo essere. Eppure, verso la fine del romanzo, Pietro inizia a presentire, tra le pagine di Niebla di Miguel de Unamuno, che le cose accadono o non accadono, e che quando accadono bisogna andargli incontro.
Nel sistema dei personaggi, anche Berto Benati, il padre del protagonista, calamita l’attenzione del lettore per la totale irresponsabilità delle sue smanie di ricchezza, l’esaltazione e la prontezza d’eloquio e un carattere in precario equilibrio tra ombre di cinismo, una propensione alla disonestà sorniona e sincero affetto per la moglie e i figli. L’iperprotettività della madre di Pietro, Tiziana, assume talvolta connotati un po’ macchiettistici e caricaturali («Aveva saputo di calciatori che, durante una partita, erano deceduti per infarto o per aver sbattuto la tempia contro il palo o inchiodati alla recinzione da un fulmine, o (…) affogati nella piena di un fiume che aveva rotto gli argini e trascinato via i giocatori e la terna arbitrale»), e anche il fratello Tommaso brilla di più nei momenti in cui interagisce con Pietro piuttosto che nelle lunghe e-mail dal Sudamerica.
Un discorso analogo può valere anche per il personaggio di Laurent Morin, sorta di versione ancora più disinibita di Tommaso e in fuga da una famiglia troppo “normale”, quasi asfissiante: se le folli imprese in cui coinvolge Pietro sono una boccata d’aria fresca rispetto agli stereotipi che permeano il romanzo di formazione (preso come sottogenere a sé, vedi ad esempio Due di due o Di noi tre, entrambi di Andrea de Carlo) e riecheggiano di atmosfere malapartiane, i capitoli dedicati interamente ai Morin stonano forse nell’economia “pietrocentrica” dell’opera; basta una scena come quella che coinvolge il giovane francese e la sua ragazza Marianne per intuire già molto dell’aria che si respira in casa di Laurent.
Una seconda lettura mi ha invece pienamente convinto della solidità del personaggio di Dora. Amerighi gioca bene con luci e ombre di fisionomia e carattere, e la sensazione è davvero quella di trovarsi di fronte a un’altra randagia, un personaggio interiormente franto e imprendibile: Dora mescola strafottenza e insicurezza, fascino e sciatteria, volgarità ed eleganza di forme, ostenta certa intransigenza giovanile e nasconde un passato doloroso vissuto in solitudine per via dei difficili rapporti con la madre e (guarda caso) la repentina sparizione del padre. La storia di Dora armonizza bene con quella di Pietro, e con lei funziona il tentativo di Amerighi di spezzare un altro cliché di genere, ovvero la focalizzazione esclusiva su un solo personaggio. Il protagonista rimane Pietro, ma con Dora ci avviciniamo ad un altro modo di vivere una vita randagia, più impulsivo e apertamente distruttivo. Amerighi regala, scavando nel passato della ragazza, pagine di prosa in stato di grazia, come quelle che raccontano l’angosciosa rapsodia sessuale che si dipana dal primo incontro con un vecchio professore:
Quando finii di leggere, mi pregò di non dire nulla. Si alzò per spalancare abbaini e finestre, come se fare entrare il tramonto fosse il rito propiziatorio che gli avrebbe garantito il mio giudizio positivo. Secondo te, mi chiese dal terrazzo, si può impazzire per il caldo? Cazzo di domanda… Secondo me si può impazzire per un sacco di cose, dico bene? (…) Pena, senso di colpa, noia, qualunque fosse stata la motivazione che mi spinse a sfilarmi gli shorts e a farmi leccare dalla lingua di quell’uomo che in tre anni ci aveva ammorbato straparlando di Dolce Stilnovo, di Sturm und Drang e del martirio di Pietro Gobetti, alla fine di quella notte sentii che avrei dovuto ringraziarlo (…), grazie a lui avevo scoperto quello che da sempre sospettavo, e cioè che dentro di me c’era qualcosa che non andava, e che quel qualcosa non era una delusione o un lutto o la paura del futuro, ma qualcosa di concreto e reale. (p.178)
Bastano queste poche righe per entrare nel mondo di Dora, un mondo costantemente in bilico, alla ricerca affannosa di un’identità, segnato dallo scarto repentino tra turpiloquio e Stilnovo, tra il ribrezzo e la pietà che prova nei confronti del professore. Amerighi qui gioca con una materia incandescente con cui è facile bruciarsi, ma pennella velocemente l’amplesso senza piacere di Dora e con i saliscendi del linguaggio fornisce al lettore un ritratto vivido sia del personaggio sia della situazione prima comica e poi tragica che lei stessa sta raccontando.
Randagi, infatti, si dimostra un’opera coraggiosa anche in relazione all’orditura stilistica delle quasi quattrocento pagine di cui è composto. Amerighi, anche in questo caso in controtendenza rispetto ai variamente intesi “romanzi di formazione” più contemporanei che tendono ad assolutizzare i poli (alta leggibilità o immaginifica elaborazione stilistico-retorica: per citare due ottimi esempi si veda Presunzione di Luca Mercadante nel primo caso e Io sono la Bestia di Andrea Donaera nel secondo), alterna una lingua scorrevole, frizzante e “beverina” (ma mai scontata) a un incedere perifrastico più articolato, ricco di scorci suggestivi e inclinazioni liriche, come l’episodio che vede Pietro al provino per entrare nella live band di una leggenda della chitarra come Paco de Lucia:
Cosa voleva fare, strangolarlo? E perché mai, se neanche lo conosceva? Perché rappresentava l’uomo che più di ogni altro era riuscito nell’obiettivo che lui aveva mancato? Più Pietro si osservava le mani e più il cervello gli si affollava di domande. (…) Era come se il suo corpo non fosse più il suo, come se le dita incriminate non fossero più le sue, come se i suoi occhi non stessero osservando il Maestro con il volto nascosto da un panno profumato ma suo nonno Furio, la notte in cui era caduto nella doccia spaccandosi un sopracciglio e Pietro, sentendolo lamentarsi dal piano di sotto, era salito a soccorrerlo coprendogli i genitali con l’accappatoio («Mi volete morto, ma io non me ne vado da solo!») mentre il sangue serpeggiava nello scarico. (p.83)
La contemporaneità asfissiante di impulsi, pensieri, gesti e ricordi è resa tramite una prosa martellante, sonora e ripetitiva che si apre all’improvviso, anche sintatticamente, sulla caduta del nonno, sull’anatema che scaglia su tutti e nessuno prendendo direttamente e prepotentemente la parola nella testa di Pietro, che nel medesimo istante ha il pensiero folle di strangolare Paco de Lucia. Interessante anche l’utilizzo del verbo “serpeggiare” per il sangue, che definisce un orizzonte di immaginazione visiva ma anche sonora, tattile.
Certo, non è sempre agevole mantenere questo equilibrio, e può capitare, data anche l’estensione dell’opera, di imbattersi in qualche episodio meno cesellato, dove il tell della famosa formula prevale sullo show(la ricostruzione del rapporto di Dora con il compagno di scuola Luca e del Rainbow party poteva essere forse trasformata in qualcosa di più oscuro e sperimentale, un po’ come accade con la maledizione Benati all’inizio), oppure in lunghi elenchi descrittivi che se per la gran parte dipingono quadri accesi e dettagliati dell’ambiente, qualche volta possono invece risultare un po’ gratuiti, soprattutto perché uno dei punti di forza di Amerighi, credo, sta nella rappresentazione di momenti quasi “atemporali” e “aspaziali” in cui i personaggi prendono o perdono coscienza di quello che gli accade.
Come ad esempio alla fine del capitolo “Il mio petto è un mare profondo”, in cui la medesima scena è raccontata dalle due diverse prospettive dei gruppi di personaggi coinvolti. È da qui che prende avvio la conclusione del romanzo, e Amerighi vira a tutta forza verso uno stile ancora più alto, denso, chiaroscurale, consustanziale alle atmosfere ora tragiche ora plumbee dei singoli capitoli, fino quasi allo scioglimento, catartico ma non definitivo.
Con Randagi, Marco Amerighi scrive un romanzo dalla grana solida, capace di travalicare i confini tra sperimentazione e tradizionale bildungsroman, una storia costruita con sapienza che rielabora in chiave mai scontata temi quali lo smarrimento generazionale, la ricerca di un’identità, i fili, le reti e i nodi scorsoi che ci legano a noi stessi e agli altri.
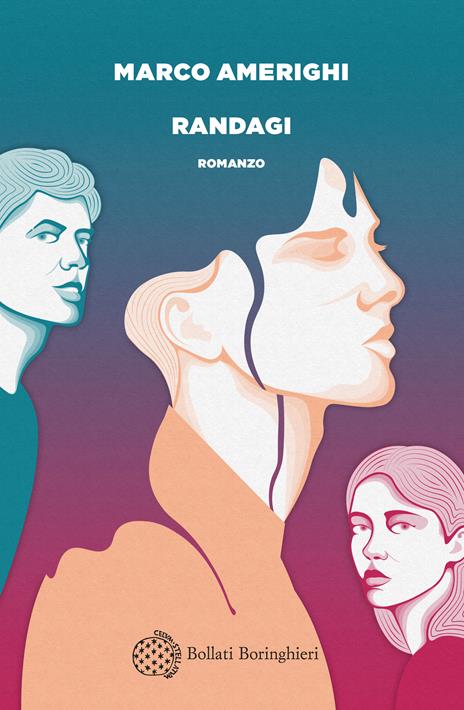
Marco Amerighi, Randagi, Bollati Boringhieri, Torino 2021, 400 pp. 18,00€