Un romanzo in versi non è il genere di libro che ci si aspetta di trovare facilmente negli scaffali di una libreria; la riedizione di un romanzo in versi, però, specie se per una grande casa editrice nazionale, è un fatto che può stupire ancora di più.
Nel caso di Perciò veniamo bene nelle fotografie di Francesco Targhetta la cronologia e il contesto editoriale hanno una certa importanza: la prima edizione, quella del 2012, nasceva su commissione della casa editrice ISBN in seguito alla lettura della silloge d’esordio, Fiaschi (2009), in cui si coglieva una propensione all’aneddoto e alla narrazione. Come ha notato Andrea Cortellessa nella sua bella postfazione per il testo Mondadori, nel 2012 il romanzo si inseriva immediatamente nel solco di una “letteratura del precariato” già ben avviata e matura, al limite quasi dell’epigonismo; da questa, però, si smarcava trasferendo la «sede specifica del precariato» nel mondo dell’università e nei meccanismi del baronismo. Il protagonista-narratore, di cui non conosciamo mai il nome, è infatti un dottorando in Storia alle prese con la stesura della tesi e con le felici quanto fallaci promesse del prof. Pacchioni, che lo spingeranno infine su un binario morto, incerto e senza prospettive. Ed è stato anche questo, in effetti, uno dei motivi che hanno agevolato la circolazione del testo, recepito da alcuni (più o meno a ragione) come un libro di denuncia contro un sistema sociale e accademico totalmente paralizzante.
Nel 2012, ad ogni modo, quest’opera rappresentava un unicum anche sul piano formale: quello del romanzo in versi era un sottobosco quasi inesplorato persino dagli ‘addetti ai lavori’, sicuramente relegato al margine dell’editoria; il genere su cui Targhetta e ISBN scommettevano rimandava, anche nella memoria della critica, ai pochi e illustri esempi di Pagliarani e Bertolucci. Oggi, invece, il libro rinasce in un contesto leggermente mutato, dal momento che nel giro di quattro anni sono usciti almeno altri tre romanzi in versi per case editrici di una certa nomea: prima la pseudo-ballata Qualcosa sui Lehman di Stefano Massini (Mondadori, 2016, tra i finalisti del Premio Campiello), poi Pacific palisades di Dario Voltolini (Einaudi, 2017) e infine, molto recentemente, Il conoscente di Umberto Fiori (Marcos y Marcos, 2019), già in parte anticipato nel 2014 nell’edizione Mondadori delle Poesie. Non saprei dire se l’opera di Targhetta, con la sua discreta circolazione del 2012, possa avere a sua volta stimolato l’attenzione di editori e poeti nei confronti del romanzo in versi: questo “genere ibrido”, di cui Perciò veniamo bene nelle fotografie è sicuramente un esempio di alto livello, sembra dipendere da fattori socio-culturali complessi e di volta in volta variabili, a partire dalle attese di lettori, critici e autori in un determinato momento storico; di sicuro, però, possiamo affermare che il potenziale editoriale di quest’opera sembra oggi maggiore rispetto a sette anni fa, tanto più se pensiamo che Mondadori può giovarsi anche della fortuna del romanzo in prosa di Targhetta, Le vite potenziali, edito nel 2018 dalla medesima casa editrice e premiato da critica e lettori.
Venendo al testo, questa seconda edizione non presenta grandi novità: oltre a qualche minimo ritocco, sono stati riesumati «tre brevi gruppi di versi stralciati dal testo originario in fase di editing»; è su uno di questi (il più esteso, se non ho visto male) che vorrei soffermarmi, anche perché mi sembra rappresentativo dell’intera narrazione.
Siamo al capitolo V, sullo sfondo di una Padova notturna e decadente. Chi ha già letto il romanzo sa bene che le vicende ruotano per buona parte attorno al cronotopo di Via Tiziano Aspetti, nell’Arcella padovana, una zona tangente alla stazione e generalmente associata al degrado. Qui vivono e si incontrano quasi tutti i protagonisti del racconto fino a quando, circa a metà del romanzo, viene meno anche il fragile equilibrio che li unisce, sostituito da tante storie individuali e da un comune destino di precarietà. È proprio sullo sfondo dell’Arcella che Targhetta – studioso appassionato di Govoni e dei simbolisti italiani ed europei – ci regala alcune straordinarie pennellate di sapore crepuscolare, secondo un’estetica urbana che anticipa (o ricorda, a seconda del caso) il fascino quasi ossessivo per le vie “dell’Elettrotecnica” o “delle Industrie” della Marghera delle Vite potenziali:
E poi è bello, no?, con questo sole
che ti tramonta tra le mani fendendo
di sbieco i palazzi, le macchine
parcheggiate storte, la scia dei pini
marittimi che inganna le betoniere,
e copre, a sbuffi, i miasmi dei bidoni
per l’umido e i vapori vaghi
delle sere.
Nell’inserto in questione, però, i personaggi si portano appresso il degrado anche negli spazi del centro storico, come un marchio esistenziale. Si muovono tra una «massa di sfollati /e studenti ricalcati da ieri», in mezzo a «poliedri / di bicchieri sui cestini come plastici /di nuovi ospedali / a sembrare ritoccati / da quanto il sonno ci invecchia male, / a impoverirci come l’uranio»; i loro spostamenti sono quelli di corpi quasi inerti, condizionati a un certo punto dal solo bisogno di trovare un WC:
finché, dopo alcune birre,
si aggiunge il problema
di trovare un wc, perché a te non va
di farla per strada addosso alle vetrine
o alle rastrelliere, negli androni interni
di qualche palazzo, e allora tocca
entrare in un pub e ubriacarsi di più
volendo solo pisciare.
Questa auto-stigmatizzazione ha forse un sapore eccessivo, tanto da sfiorare quasi il grottesco quando l’io narrante constata anche l’incapacità di pisciare: un non-atto, ben scandito dalle allitterazioni («di pisciare neanche più ti riesce»), che è però qualcosa di più di una facile trovata narrativa, dal momento che si lega al tessuto tematico del romanzo e anche ad alcune delle sue situazioni più caratteristiche. La prima di queste è la relazione con l’altro sesso: la «ragazza con la frangetta e il magone» a cui il protagonista, «concludendo la seduta», lascia il posto in bagno, e con cui poco prima ha tentato un approccio piuttosto sterile nel mezzo di una fila «tragica» davanti al Nazionale, rinvia al complesso quanto irrisolto rapporto con l’altro sesso, tra cui va contemplata anche Mara, l’amica più intima e più estranea all’ambiente padovano, quella che fino a un certo punto del romanzo riesce ancora a sognare un futuro nel mondo del teatro. La seconda è il tema della guerra, che si lega agli studi storici del protagonista e che emerge in alcune felicissime sequenze del racconto, dove collima più o meno esplicitamente con le sorti dei protagonisti:
Caporetto sinonimo di sfascio
mica è una bella eredità: subito
Diaz al posto di Cadorna, un rinculo
pauroso alla ricerca del primo fiume
che possa essere sbarramento
sicuro: […]
La fame, poi, in primavera,
spinge gli altri al saccheggio in guerra,
con le operazioni Lawine – Trentino
Radetzky – Grappa
Albrecht – Treviso
e allora scrivilo, nel preambolo,
che quando si torna, il weekend, il centro
si riempie dei pendolari in esilio,
e li ritrovi tutti, nelle strade uguali
a case per anziani,
Ma in questo caso, di nuovo, la condizione è spinta al parossismo: non l’azione eroica di un esercito, ma la visita per la naia, «quando riconsegnasti, entrambe le volte, vuota / la fialetta»: quasi a dire, senza alcun senso di «autoindulgenza», che non c’è azione, nemmeno la più banale, che possa riuscire dignitosamente. Il recupero di questo inserto, insomma, ribadisce a distanza di sette anni la più autentica direzione della trama: quella di una spirale negativa, di un nastro dove ogni passo in avanti serve solo a tornare indietro, con la conseguente tentazione, a un certo punto, di lasciarsi trasportare ai margini del sistema. «Non si muove nessuno / qua, perciò veniamo bene / nelle fotografie»: questi sono i versi che conferiscono il titolo al romanzo e che ne suggellano in maniera impeccabile il contenuto.
Nonostante l’esilità della trama, è davvero difficile non restare imbrigliati nelle maglie del racconto. La voce narrante, complice anche il ritmo del verso, ingloba ogni cosa in una dimensione intima e schietta da cui nulla sembra fuggire, nemmeno il lettore. Tutta la realtà è deformata dalla prospettiva dell’io, che invade persino gli spazi mentali degli altri personaggi. Quando, ad esempio, ci descrive la vita di Teo a Torino, non c’è soluzione di continuità tra gli eventi reali e quelli che sono invece frutto di immaginazione, rievocazione di ricordi padovani proiettati nel presente e nel futuro, in cui si annida il sospetto di un nostalgico attaccamento al passato:
[…] a Teo ancora piace annusare
i budelli ombrosi e certe strade
laconiche, appena svoltata la via
principale, sopra scarti di barriere
architettoniche e cassette della posta
residuali col distinguo tra città e altre
destinazioni, che è come
i cartelli tutte le direzioni,
quel magma indistinto
che non lascia mai scampo, e adora poi finire
in fiorerie, empori, case del detersivo,
a comprarsi un filo, uno spago, uno shampoo,
approdando infine in libreria, in via
Roma, a parlare con la cassiera
di argomenti vari, di collezioni
De Agostini e magazine dei quotidiani,
Tanto che, restando ancora su Teo, persino il suo matrimonio con Anna viene ridotto a una condizione ordinaria, dove «tutto / finisce, ogni volta / nel modo più normale».
Targhetta è un autore che nelle sue prove narrative sembra quasi dilettarsi a sfiorare i confini più incerti per poi salvare l’opera al momento giusto, con strategie minimali ma efficaci. Accade con la trama delle Vite potenziali, accelerata in extremis, e accade, qui, per ciò che riguarda il tono generale del racconto. C’è infatti un espediente linguistico che salva la voce narrante dall’autocommiserazione stucchevole o dall’eccesso di pessimismo: è il ti riflessivo con cui il soggetto si auto-rappresenta, a cui si possono aggiungere anche le intime invocazioni a un destinatario femminile (ad es. «Ma noi, cara, ci stringeremo in modo diverso, gliela faremo pagare esempio») disseminate qua e là lungo i capitoli. Sono invenzioni che dimostrano una notevole maestria narrativa: il discorso, anche nei momenti in cui la voce è palesemente non obiettiva, resta sempre e comunque sincero, perché è come se osservassimo il narratore alle prese con un soliloquio, al più con un dialogo privato. Una volta accertata la sua onestà, ciò che fa la differenza – e in questo si intravede forse l’ombra della voce narrante della Corda corta di Ottieri – è il suo grado di lucidità.
Mi pare, allora, che si possa cogliere l’indizio di una distanza: non solo perché, come osserva Cortellessa, il paragone con Caporetto rimanda a un orizzonte altro rispetto alla sconfitta del protagonista, a una resistenza in grado di introdurre la prospettiva di un riscatto e di un rovesciamento di segno; ma anche perché l’ostentazione della propria immobilità è tale da far sospettare che a cercarla sia quasi il narratore stesso e che la sua denuncia sociale, in certa misura, possa essere ridimensionata. È il caso di qualche auto-caricatura («Una felpa da black bloc col cappuccio / ci vuole, e ce l’hai, nera come le blatte / che ti sogni la notte, dopo averla / indossata nella camera da letto /per specchiarti nello schermo del pc»), che sembra quasi suggerire che lì, a guardar bene, il narratore sta indossando una maschera. Insomma, proprio nel dare voce al soggetto, Targhetta riesce anche a incrinarne la credibilità, introducendo sottoli fessure in cui il lettore può, se ne sentisse il bisogno, cercare una via di fuga.
Della trama e del progetto narrativo non direi di più, sia perché costruito su piccoli movimenti quotidiani che vanno letti, vissuti, e che si prestano poco a una sintesi, sia perché, in fin dei conti, a contare sono soprattutto lo stile e la forma. In Perciò veniamo bene nelle fotografie, a differenza che nelle Vite potenziali, la staticità della storia è compensata dal verso, che funziona come una «rete elastica di salvataggio» in grado di sostenere il racconto dal rischio di una caduta. La metrica (così come la lingua) di Targhetta si presenta sotto forma di una partitura ricca e varia, fondata su un’attenta regia ritmico-fonica mai spinta agli eccessi del verso lungo o della canzonetta; una ‘rete’ che talvolta (soprattutto negli incipit) accompagna il lettore con passo endecasillabico, o si spezza e si complica per sostenere le varie acrobazie della voce narrante, o, ancora, si organizza in strutture visive dall’effetto epigrammatico, ereditate anche dalla Ragazza Carla di Pagliarani:
con il nuovo lavoro:
«la scritta affari
negli ipermercati», mi fa Dario,
finito il caffè, «ricorda:
vuol dire sempre affari loro».
La densità fonica, ritmica e lessicale coinvolge tutti i livelli del discorso, alterandone le strutture e producendo di tanto in tanto un piacevole senso di spaesamento. Un aspetto, questo, che sembra accostare Perciò veniamo bene nelle fotografie più alla dizione dei grandi esempi novecenteschi – dal «pedale del ritmo» di Pagliarani al «pendolo» di Bertolucci – che a quella di alcuni esiti più recenti, dove le strategie formali (altrettanto valide e conformi al progetto complessivo) sono più nette o tendono a diluire il rischio del disorientamento: penso ad esempio al ritmo controllato e discorsivo del Conoscente di Umberto Fiori, alla polimetria quasi schematica di E niente è ciò che è di Roberto Nassi, alla prosodia circolare ed essenziale di Qualcosa sui Lehman di Massini, alle ottave per l’occhio di Ogni cinque bracciate di Frungillo o, ancora, alle trasparenze speculative di Pacific palisades.
Nei romanzi in versi la questione del ritmo è centrale, poiché definisce la natura stessa del discorso e colloca l’opera in una terra di mezzo tra poesia e romanzo. In questa “zona franca” si ripristinano di volta in volta alcune funzioni del verso che, nell’orizzonte delle attese più comuni, sembrano quasi estranee alla prassi poetica contemporanea: la narrazione, la speculazione, la costruzione di un discorso organizzato coerentemente nel tempo. Un romanzo in versi, per essere tale, deve dunque presentarsi come una sintesi impeccabile e ragionata di forma e contenuto, e da questo punto di vista Perciò veniamo bene nelle fotografie è un esperimento ben riuscito: leggendolo si coglie chiaramente la volontà di indirizzare le risorse del romanzo e della poesia in un percorso del tutto originale, tanto da dare l’impressione che in prosa non potrebbe né funzionare né esistere. La riedizione, dunque, ha se non altro il merito di rimettere in circolazione un’opera non solo attualissima per temi e contenuti, ma anche fondamentale per comprendere e fissare il panorama del romanzo in versi contemporaneo, proprio ora che quel ‘genere’ sta acquisendo maggiore visibilità. L’idea di salvarla dalla circolazione clandestina a cui sembrava destinata dopo la chiusura di ISBN e di porla sotto i riflettori della grande distribuzione nazionale non può che essere salutata felicemente, a beneficio tanto della critica quanto, e anzi soprattutto, dei suoi nuovi, potenziali, lettori.
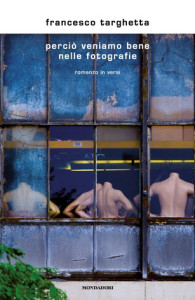 Francesco Targhetta, Perciò veniamo bene nelle fotografie, Mondadori, Milano 2019, 264 pp. 17,00€
Francesco Targhetta, Perciò veniamo bene nelle fotografie, Mondadori, Milano 2019, 264 pp. 17,00€