Il gennaio dello scorso anno, Edizioni Clichy ha pubblicato in prima edizione mondiale, con la traduzione di Tommaso Gurrieri, l’ultimo romanzo di Régis Jauffret, 1889. Dans le ventre de Klara è il titolo in lingua originale: un cambiamento su cui vale la pena di ragionare, quello verso l’italiano, poiché sposta l’attenzione dal corpo della protagonista che, come si vedrà avanti, domina la narrazione, per concentrarsi sui temi di destino e ineluttabilità, pure importanti nel romanzo.
La prima di copertina dell’edizione italiana gioca un ruolo importante di guida alla lettura: riporta, infatti, la dicitura “Romanzo”, che nella postfazione l’autore conferma (ma ammettendo di aver lavorato a partire dalla scarsa documentazione storica disponibile), e aggiunge, in fondo, “La nascita di Adolf Hitler”. Se la seconda di copertina non specificasse che la storia raccontata dal romanzo è quella della gravidanza di Klara, madre di Hitler, ci si aspetterebbe la storia romanzata dell’infanzia di quest’ultimo, la cui nascita invece chiude la narrazione e il cui nome non è mai menzionato. La quarta di copertina, infine, riportando un passaggio della postfazione dell’autore, esplicita l’intento autoriale di fare dell’opera un memoriale per le vittime della Shoah.
Il romanzo ripercorre il periodo tra il concepimento e il parto di Hitler, includendo flashback dell’infanzia della madre Klara, di cui descrive la vita domestica e l’interiorità, affidata dalla ragazza, di nascosto, a un quaderno («Nascondo questo diario in fondo al grande cassetto della mia coiffeuse. […] Sono una donna priva di istruzione. Devo spesso e più volte smontare le mie frasi prima di imbastirne una che stia in piedi», p. 8). Quello del diario è un topos narrativo spesso usato soprattutto per la caratterizzazione delle personagge, ma qui viene adottato in modo affatto tradizionale: il romanzo non è la trascrizione del quaderno di Klara, che a un certo punto lei stessa brucerà sostituendolo con una lavagna per bambini da cui cancellerà di volta in volta ciò che scrive, quanto piuttosto un dialogo interiore della protagonista (compaiono spesso virgolette che segnalerebbero un discorso diretto senza però la presenza di altri interlocutori), fatto di un registro e di parole che non potrebbero appartenere a una ragazza analfabeta come lei, e che sembrano esserle suggeriti dal suo stesso feto: «“In alcuni momenti mi sembra che il frutto abbia preso il mio posto”. È lui che decide ogni mio movimento e ascolta le mie parole ancor prima di lasciarmele dire. M’impedisce di pronunciarne alcune a cui ne sostituisce altre» (p. 210). Klara comincia ad avere visioni, di morte e guerra, a lei inspiegabili, ma familiari a chi legge poiché richiamano tutte in modo sempre più esplicito l’iconografia occidentale della Seconda Guerra Mondiale e della Shoah:
Con i loro apparecchi portatili che possono infilare in tasca i soldati fotografano i prigionieri che costringono a spogliarsi nel freddo e a danzare, cantare, frustando bambini, vecchi, vecchie cadute a terra. E in un angolo buio un neonato poppa il seno della madre morta e il ragazzino perforato da una pallottola nella pancia con voce impercettibile reclama la seconda pallottola per risparmiarsi la fine del calvario (p. 119);
Tutte queste parole insensate cadute da un altro secolo. Passano trasparenti, silenziose. Non so niente di loro, né della loro assenza. Non mi ricordo il futuro (p. 127).
Il romanzo si fa quindi onirico ogni volta che queste immagini vengono presentate improvvisamente, così come improvvisamente appaiono a Klara: «Stamattina, sentendomi meglio, mi sono messa a far parlare Johanna, chiuse entrambe nell’anticamera della toilette mentre mi aiutava a intrecciare i capelli appena spazzolati. Capigliature tagliate prima che si richiudano le porte, che i corpi nudi battono per respirare nell’aria come sospiri. I parrucchieri snodano una a una le trecce delle ragazzine prima di lavarle, pettinarle, avvolgerle con il resto del bottino fino all’ultimo capello che verrà tessuto in vestiti caldi per proteggere dal freddo guardiani, soldati, meccanici del convoglio che li ha portati fin lì» (p. 178). Klara ha l’oscuro presentimento che non solo il feto sia ispiratore di queste immagini, ma che le immagini siano esse stesse direttamente collegate all’agire futuro del bambino non ancora nato. A questo sentore si aggiunge un uso sottilissimo e amaro dell’ironia da parte dell’autore, che accosta spesso il feto alle sue future vittime («Lo consegno al destino come quel neonato buttato da sua madre come un pacchetto di stracci a un viaggiatore stupefatto sul marciapiede di una stazione prima che i poliziotti la spingano in un carro bestiame […]», p. 231) o all’ebraismo («[…] il suo cervello è di buona fattura diventerò forse un soggetto così brillante che lo si crederà figlio del popolo di Bloch», p. 232).
D’altra parte, anche il mondo di Klara è estremamente violento: subisce gli abusi sessuali dello zio vedovo che poi la sposerà (per tutto il romanzo la protagonista lo chiamerà Zio, in quanto figlio del bisnonno paterno); gli unici suoi interlocutori sono un sacerdote e la sorella, che però alimentano in lei i sensi di colpa derivati da un cattolicesimo superstizioso; subisce i rapporti sessuali con lo Zio/marito come una punizione divina da tollerare pur di partorire, ma continua ad abortire o i suoi figli muoiono ancora infanti. La nascita e il parto stessi sono spesso accostati a un’esperienza di morte («Tutti gli esseri umani sono nati da un supplizio. Le donne dimenticano, altrimenti strangolerebbero con le loro mani lo strumento della loro tortura quando esce dal ventre», p. 220; «Il mio ventre è una necropoli», p. 172). Proprio il corpo materno e gestante diventa centrale nella rappresentazione del Male che offre Jauffret.
Il Bene sembra assente o fagocitato completamente da un Male che serpeggia e inquina ogni aspetto della vita quotidiana, in attesa di esplodere. Quella proposta abilmente da Jauffret è una tensione simile a quella che Haneke costruisce e rappresenta nel suo film Il nastro bianco (2009), nel quale abusi domestici, atti di sadismo e delitti sempre più frequenti riempiono l’assenza di una trama forte, fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. 1889 ritrae con tinte cupe e truculente lo stesso secolo e lo stesso tipo di Male, che sembra avere origine proprio dal ventre materno. La superstizione religiosa e la fallocrazia imposta dal marito e dalla società convincono Klara che essere una donna sia una maledizione («Meglio non crescere donna ed è quello che auguro al frutto delle mie viscere», p. 208) e che le donne generino il Male: «Le madri saranno responsabili dei peccati commessi in seguito dal figlio che hanno portato dentro di loro», p. 5; «Una donna incinta porta nel suo ventre il peccato carnale come un peso che cresce», p. 149, «[…] nel ventre delle donne che hanno sfidato Dio, Satana fa la sua casa e porta a ebollizione il liquido nel quale sguazza il suo erede», p. 170; «Nel mio ventre, la sventura del mondo», p. 212.
Come nasce dunque il male? Si trasmette come una malattia già durante la gestazione? Si eredita? Si assorbe dal mondo circostante? Il romanzo non si propone come una riflessione filosofica, tanto meno come un resoconto storico. Non vi è risposta: quel che è certo è che non sembrano esistere innocenti, se a partorire il Male è proprio il ventre di una innocente («Sono una partoriente normale, ignorante, innocente, come i suppliziati di cui sono piena», p. 127). Nessuno può essere redento o scagionato. Klara, assuefatta a un secolo e a un ambiente violenti, consapevole del fatto che il bambino che aspetta non è solo suggeritore ma anche responsabile del Male che sta per esplodere, non può e non vuole fare niente per combatterlo: «Eppure non proverò mai vergogna verso di lui, qualunque cosa accada. Le madri degli assassini devono essere fiere del proprio figlio quando sale coraggiosamente sul patibolo» (p. 188).
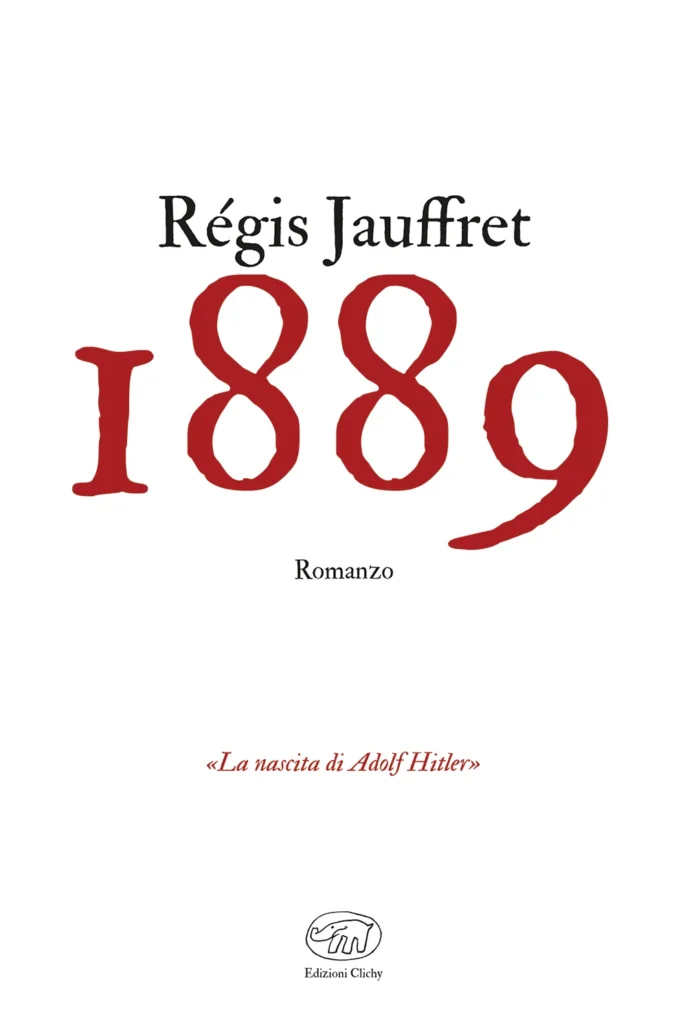
Régis Jauffret, 1889, traduzione di Tommaso Gurrieri, Firenze, Edizioni Clichy, 19,50 €, 240 pp.