Prosegue la presentazione dei libri finalisti del Premio Narrativa Bergamo 2023. Gli incontri con gli autori si tengono alle 18.00 alla Biblioteca Tiraboschi di Bergamo; dopo Alberto Ravasio, oggi tocca a Giorgio Vasta.
Non ci siamo ancora e già non ci siamo più: Palermo di Vasta e Fazel
Noi siamo fatti degli sguardi che ci sono stati rivolti, dal primo sino all’ultimo, dal più lontano al più recente. Lo sguardo degli altri plasma, sin da piccoli, il nostro e condiziona radicalmente le modalità percettive attraverso cui auscultiamo e interpretiamo la realtà circostante, la postura del nostro esserci nel mondo. Lo sguardo è la consapevolezza dell’occhio, che si tende e sbircia nella luce e nulla potrebbe afferrare senza di essa. La luce, pur conservando in sé una propria specifica geografia e un altrettanto speculare storia, è un passe-partout spazio-temporale, che permette di scardinare la linearità dell’esistenza – inizio, procedimento, fine – e di esplorare la sospensione, l’arresto, il non-detto di ogni vissuto, per riannodare i gangli cruciali e risalire ai momenti cairotici in cui ciò che poteva essere e non è stato si ammutina e decade. La luce c’è sempre stata, mai neutra tutto ha invaso, orientato e avviluppato.
Non è però così semplice. La logica aristotelica di questa progressione assiomatica si scontra con l’inafferrabilità della luce stessa, con la manchevolezza delle parole che tentano di fornirle consistenza. In Palermo. Autobiografia nella luce (Humboldt Books) Giorgio Vasta, nuovamente in tandem con il fotografo Ramak Fazel, s’interroga sulla oltre-dicibilità di questo elemento assoluto, che c’è anche quando sembra non esserci, presente persino nella filigrana del suo tangibile rovescio, l’ombra. Tentare di esprimere la luce di Palermo – tanto crepuscolare quanto abbagliante – per esprimere al contempo, come frutto maturo di una filiazione impossibile e però oggettiva, il proprio passato, ricostruire i tasselli sfuggenti di un’autobiografia destinata a rimanere incerta, abitata da smagliature e contraddizioni. Non solo però un’autobiografia della luce che diviene, contestualmente, un’autobiografia nella luce, segmentata e disorganica, preda di anacronie e cortocircuiti, costituita da brani di memoria selezionati e assemblati secondo un principio di fluidità e di parallelo accavallamento di date, luoghi e nomi, ma anche – ed è qui che il piano del particolare interseca più ampi orizzonti di universalità – una riflessione sul senso ipotetico del nostro stare sulla terra, sul nostro relazionarci col prossimo, nonché una digressione sull’incomprensibilità dell’amore – che sia per una persona, per una città, per un ricordo –, sentimento che può essere solamente percorso, mai afferrato, mai realmente compreso: come la luce, del resto.
Sin dai suoi esordi interessato a mettere in forma, o meglio ad estrarre una forma dal grumo informe delle cose, Vasta procede – dopo Spaesamento (2010) e Absolutely Nothing (2016) – nella sua operazione di scandaglio fenomenologico del reale, che viene scomposto cellularmente per frammenti ottici, effetti di piano-sequenza, sezioni alveolari di gesti, pensieri e movimenti atti a catturare le emanazioni invisibili del visibile. Se in Spaesamento, anch’esso ambientato a Palermo, si trattava di un presente da risemantizzare, su cui effettuare una “presa”, vale a dire una decodifica in grado di emanciparlo dal suo status quo, dal suo intorpidimento cronico, dalle sue derive posticce e derealizzanti, per riportarne a galla lo scheletro sommerso, in Palermo Vasta sembra chiedere alla città, propaggine che diviene centro simbolico – di un intero Paese, di una intera esistenza – non più di parlargli metaforicamente dell’Italia, bensì di raccontargli di sé, di ciò che è diventato nel corso degli anni, di ciò che resta e dovrà restare, nonostante i reiterati tentativi di disconoscere ogni retaggio di naturale appartenenza, ricevendo in cambio, anche questa volta, risposte sibilline e opache. La vivisezione diacronica del proprio tempo, portata avanti per carotaggi profondi ma inevitabilmente incompleti, fa il paio con l’attraversamento, per sopralluoghi e avvicinamenti repentini, dello spazio urbano, esperibile sempre e solo a metà, nell’interstizio liminale in cui il vissuto si fa memoria e insieme immaginazione, irriducibile ad ogni tentazione sistematizzante.
Palermo, in fondo, è una città intransitiva e iperbolica, divoratrice e divorata, che rimanda all’osservatore solo il riflesso sovraesposto delle sue superfici, rimanendo irriducibile ad una esaustiva trascrizione. Il dialogo intrapreso con quest’ultima, allora, non può che essere aporetico, abbozzato nei suoi nuclei pregnanti, nelle giunture in cui pare depositarsi un filamento di senso condivisibile, nelle estremità di due tangenze che si toccano alla base della medesima struttura sentimentale: «ciò che nel tempo perdura: rifiutarsi, rifiutare». Esponendo il fianco alla vulnerabilità delle proprie radici, Vasta, in quanto soggetto percipiente svuotato di certezze, si sottopone a un processo di spettralizzazione – mentale e corporale –, che si allarga sino a comprendere il perimetro stesso della città, all’interno di una dialettica contrappuntistica in cui la continua dislocazione dell’io, posto dentro uno spazio ben preciso ma sempre alienato e centrifugo, corrisponde, in un costante gioco di rimandi, all’impotenza di localizzare il proprio desiderio, di proiettarlo e farlo aderire su una persona o un luogo definito. L’impossibilità di ancorarsi ad un tempo e ad uno spazio esatti, e, a cascata, la predisposizione innata ad un peregrinare apparentemente senza meta, sembrano derivare da una soggiacente incapacità di esserci, per sé e per gli altri, di aderire pienamente all’attimo presente, di riconoscersi nel momento in cui si è riconosciuti. I testi autobiografici di Vasta – e Palermo in questo non fa eccezione – esprimono costantemente il bisogno, da parte dell’io narrante, di consistere, di inscriversi nel crocevia di coordinate determinate, di darsi peso, di non lasciarsi regredire ad uno stadio d’indifferenziazione.
A ogni passo svanivo nella luce nella fluorescenza, la luce non illuminava le cose, attraverso la luce non c’era nessuna possibilità di comprensione: solo smarrimento: non c’erano cause ed effetti ma labirinti, tergiversazioni e procrastinazioni – Vedrai, mi dicevo, vedrai, domani anche tu diventerai carne, ma domani non arrivava mai – e, dunque, così come nelle mappe tradizionali c’è un puntino che dice voi siete qui, a me serviva una mappa che mi dicesse dove mi trovavo: io sono qui, questo volevo sapere: in questo punto: in questo istante: in questa luce […].
A questo disorientamento costitutivo, a questo stato di permanente sfocatura e di relativa afasia, i suoi testi oppongono perciò l’esattezza nomenclatoria, la brama di discernere e denominare il caos del circostante, il tentativo di penetrare e poi tratteggiare linguisticamente la sostanza babelica del presente, assecondando un principio di «panico ordinato», espressione usata dallo stesso Vasta in Spaesamento che mi pare segnali perfettamente la fisionomia della sua scrittura, ciò che la anima e le dà spessore. Una scrittura che accoglie in sé il piacere dell’ossimoro, ne fa una marca caratterizzante, riflesso poietico di una visione estremamente elastica e turbinosa, di un pensiero teso alla ricerca di una sintesi tra i più evidenti contrasti, che abbracci ciò che è e ciò che non è, la cristallizzazione e l’essere in potenza. La prosa di Vasta si presenta rigorosa, nitida, sostenuta dal concetto, disvelante una ricchezza lessicale tanto rara quanto funzionale alla restituzione delle infinite sfumature che sostanziano l’umano vivere, e però anche filamentosa, sempre sul punto di agglutinarsi e rovinare precipitosamente. A volte si ha persino l’impressione che l’evoluzione via via affinata del fraseggio rischi di avvitarsi su sé stessa, di auto-dissiparsi, di smarrire il proprio baricentro e scivolare via, per poi, al contrario, assistere ad un improvviso riassestarsi, ad un testacoda in grado di riallineare le correnti di un discorso apparentemente debordante.
È lo stesso Vasta, del resto, a descrivere nell’incipit gli sviluppi sofferti di una radicale metamorfosi comunicativa e a ragionare sulle conseguenti difficoltà del proprio “dire”, ossia sui problemi riscontrati, superata la soglia dei trent’anni, nell’incanalare i discorsi sui binari di un tracciato coeso e sostenibile, confessando, in una sorta di implicita mise en abyme di stilistica, l’impossibilità di continuare a «stare serenamente nel linguaggio». Palermo rappresenta allora l’epitome del virtuosismo vastiano. Anche in questo caso, infatti, la tenuta sorprendente della scrittura, pur soggetta ad un’esposizione e ad una esasperazione fluviale – in netta antitesi con il sentimento di “fissità” e di “lignificazione” che paralizza lo scrittore –, porosa, quasi apparentabile ad un monologo interiore, permette di controllare le oscillazioni temporalesche della riflessione, le associazioni improvvise di immagini, il sovrapporsi rapido dei piani temporali, senza indebolire la costruzione aerea dei significati.
Nel precipitato discorsivo che rende Palermo simile ad un auto-confessione in fieri – composta paratatticamente da una lunghissima frase-discorso, in cui la sintassi si espande incontenibile proprio come un fascio di luce posto davanti agli occhi – la vertigine dell’origine – della luce, della vita, degli oggetti – informa le circumnavigazioni pacate della scrittura vastiana, controbilanciando quell’ossessione, ben presente in Absolutely Nothing, per la fine, per l’abbandono, per tutto quello che, una volta dismessa la propria funzione, diviene monumento al suo stesso anacronismo. La seduzione per il decadimento, per il reperto, per le tracce inattuali di un tempo altro, qui muta pelle, metamorfizzandosi in un’ossessione irreprimibile per il cominciamento, ossia per il momento – l’unico possibile – in cui ogni cosa è apparsa, in cui ciò che non poteva non accadere è accaduto, in cui tutto, disgregandosi, è venuto a compimento. Se nel reportage sui deserti americani era possibile radiografare l’esistente senza dover per forza ricorrere a ulteriori metaforizzazioni, rimanendo attaccati alle sole manifestazioni caratterizzanti di un paesaggio scarnificato, extra-terrestre, terminale, in bilico tra autenticità e falsificazione, in Palermo questo non è possibile, perché entra in gioco il piano della storia personale, dunque famigliare. Al viaggio come progressione geografica e temporale inscrivibile in una narrazione orizzontale, costruzione ondivaga di tessere e passaggi, ripensamenti e nuove partenze, si sostituisce il viaggio a ritroso nella scrittura, nella verticalità di un approdo tormentato, la conclusione sofferta di un ritorno a casa a lungo rimandato, mai pacificato, che comporta l’emersione di un’eredità pulsante al fondo, sebbene a lungo rimossa. I referenti rarefatti che nel deserto producevano una sorta di fluttuazione esistenziale, a Palermo – dove tutto è troppo vero, colorato, rumoroso –, si presentano, al contrario, saturi, estremizzati. L’absolutely nothing si rovescia in absolutely everything rivelando la complementarità di due momenti successivi di una stessa illimitata ricerca, costretta a passare attraverso i vuoti e i pieni dell’esperienza, dei legami affettivi e famigliari.
E adesso avrebbe senso dire che negli anni erano accadute tante cose, o almeno sul piano di un’autobiografia tradizionale che dà credito ai fatti dovrei dire così, nel senso che intorno al 2015, quando il nodo di ogni legame era ormai del tutto esausto, avevo lasciato anche Roma e dopo circa vent’anni – senza aver mai desiderato il ritorno, senza nessuna riconciliazione, al contrario avvertendo la città sempre più lontana e incomprensibile – ero tornato a Palermo […].
Analogamente, nelle foto di Ramak Fazel, che compongono un capitolo indipendente, la luce aumentata, che permette ai soggetti di risultare sovraesposti rispetto al contesto circostante, aumenta la discrasia fra l’oggetto reale e l’oggetto rappresentato, secondo un sottile principio di non-corrispondenza per cui la presenza così ostentata del materiale umano genera per paradosso ed estremizzazione un disegno dalle sembianze fantasmatiche (d’altronde la sezione è intitolata City of Phantoms), rendendo l’eccesso – di colori, corpi, volumi – rispecchiamento di una carenza soggiacente, speculare controcanto di ciò che si sottrae alla visione, dell’imprendibile contingente. La potenzialità espressiva dello sguardo di Fazel lavora per reinventare l’identità dell’immagine, e dunque dell’immaginario, producendo scampoli di una realtà ri-mediata in cui la fotografia non viene limitata alla semplice ostensione del quotidiano, ma diventa una sorta di performance sulla luce, un arabesco sul suo potere compositivo e strutturale. Gli spazi troppo pieni di Palermo vengono restituiti mediante una serie di tecniche – uso del fuori campo, della sfocatura, esposizione delle ombre dei corpi ritratti, forzature del flash analogico (Fazel utilizza una Rolleiflex di fine anni Sessanta) –, tese a far emergere un rapporto mesmerico e al contempo spettrale con il reale catturato dall’obiettivo. Sebbene le foto di Fazel fungano da reagente, come moltiplicazione di uno sguardo che permette di problematizzare ulteriormente la pluriformità dell’entità indagata, l’apparato iconotestuale progredisce in maniera autonoma (anche a livello temporale, dal momento che Vasta ha lavorato al suo racconto dopo aver visto le foto). Tra le due parti vi sono però evidenti sponde e contiguità, elementi basilari di una complicità che si sviluppa in modo cieco, senza che una sezione assorba l’altra. In particolare, emerge la volontà di Fazel di far esistere plasticamente la luce, di fornirgli un corpo, una sua peculiare fisionomia, così come la sua predisposizione istintiva a cogliere l’hic et nunc in cui non solo la luce ha permesso ai colori di predisporsi sulla retina, ma si è fatta essa stessa presenza. In questa operazione di messa a fuoco ad essere preponderante è dunque sempre il punto di fuoco, che si slancia cromaticamente oltre la piattezza un poco oscurata della profondità di campo, come a dire che ciò che importa davvero è solo il volto-corpo-gesto fattosi frazione di tempo, a sua volta dispiegatasi nella luce, a sua volta divenuta materia afferrabile per pochi secondi, a sua volta catturata nello scatto: tutto il resto è mera scenografia, mancanza, nostalgia.
Le strategie compositive di Fazel trovano felice eco in quella tensione per l’increato che, in Palermo, si sposa con l’urgenza di rappresentare (nel senso primordiale del termine: “riportare alla presenza”) la luce, di tratteggiarne una genealogia archeologica, ciò che la compone e ciò che essa compone, un tormento inesauribile che non può essere risolto pienamente dalla scrittura, ma solamente riorganizzato, rappreso intorno a deboli appigli. Ed ecco perché l’intero dettato viene costruito intorno ad un vuoto, nei pressi di qualcosa che non si può lambire, nel presentimento di ciò che c’è ma pare sfuggire, l’istante epifanico in cui la presenza si fa sparizione e viceversa. Per Vasta la nostalgia – correlativo semi-oggettivo di questo sfasamento cronico – sembrerebbe non essere altro che lo spazio emotivo di un’involuzione, all’interno del quale il presente si aliena da sé stesso, si flette sotto il peso della mancanza e si decolora sino a dissolvere l’intero spettro cromatico. La nostalgia è il bisogno di avere a disposizione una «camera remota» in cui poter contemplare il mistero struggente della propria dissoluzione, vivere nell’arresto e nella sfocatura di un tempo dissociato, minore, che si vorrebbe fatto di soli inizi, in preda alla paura e al desiderio che qualcosa accada o smetta di accadere. Ne consegue che sulla superficie del reale esperito viene a depositarsi una ragnatela di nostalgie dislocate, i cui fili disegnano una topografia di varchi, crepe e simulacri. Dallo smottamento del terreno sottostante, che si fa friabile e bucherellato, prende origine non solo la scrittura di Vasta, ma l’intero immaginario che ne indirizza il movimento spiraliforme.
La lacuna diviene così direzione del racconto, motore cognitivo che fa della parzialità dell’esperienza, dello sguardo, un paradigma epistemologico. Consapevole del valore dell’ellissi e dell’omissione, Vasta invoca il proprio passato solo per negarne l’esistenza, per farlo dissolvere, per scarnificarlo e ridurlo al punto nodale in cui è ancora possibile immaginare un’altra vita, rivivere dall’occhio della cinepresa un’altra nascita, potenziale, parallela, forse impossibile. Lo sforzo di risalire alla sorgente della propria esistenza non è finalizzato all’accertamento di un fatto incontrovertibile, alla presunzione di aver scoperto e chiarito l’arcano, ma risponde all’esigenza di provare a capire com’era fatto lo sguardo di chi ci ha guardato davvero, come esso si è organizzato nella materialità della luce. Solo così, sporgendosi per un istante negli occhi dell’altro, negli occhi del padre, è possibile arrivare a guardare sé stessi, per la prima volta rinvenire, o forse inventare (verbi che condividono la stessa radice etimologica: “trovare”) l’origine del proprio sguardo. Qui si esaurisce la frase, nel momento impossibile in cui non ci siamo ancora e già non ci siamo più.
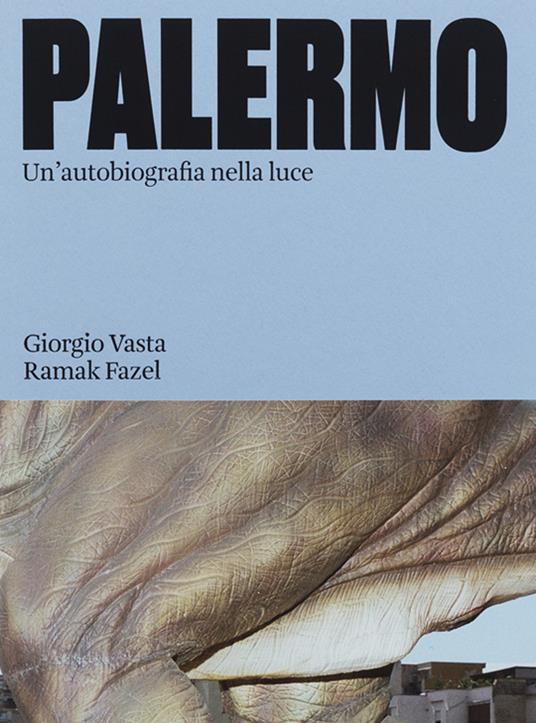
Giorgio Vasta, Ramak Fazel, Palermo. Un’autobiografia nella luce, Humboldt Books, Roma 2022, 128 pp. 24,00 €
