Francia occidentale, regione della Deux-Sèvres, a lato del Marais Poitevin. Se nelle opere precedenti – specialmente in Zona (2008) e in Bussola (2015, Premio Goncourt e Premio Von Rezzori) – Mathias Énard aveva raccontato il volto proteiforme del Mediterraneo e i crocevia storici che puntellano il sempre problematico rapporto tra Occidente e Oriente, nell’ultimo romanzo – Il banchetto annuale della confraternita dei becchini, pubblicato in Italia da Edizioni E/O nel settembre scorso – la cornice geografica che funge non solo da scenario e da ambientazione delle vicende diegetiche, ma da vero e proprio innesco mitopoietico, è la profonda Francia dell’Ovest, nella zona di Niort, terra natale dello scrittore. È qui che David Mazon, dottorando in antropologia, si reca, dopo aver lasciato Parigi, per stendere “sul campo” la sua tesi riguardante le comunità rurali del XXI secolo e le pratiche di vita, socialità e lavoro sviluppatesi in campagna nell’epoca della finanziarizzazione del mercato e dell’economia post-industriale. È qui che il protagonista, una volta sistematosi in una fattoria da lui rinominata “Pensiero Selvaggio” in omaggio al libro di Lévi-Strauss, comincia a tenere un diario di lavoro, che occupa la parte iniziale e finale del romanzo. Nell’ottica di rompere le diffidenze e le reticenze della popolazione locale e al contempo intenzionato a calarsi gradualmente nello spirito del luogo, Mazon comincia a frequentare gli abitanti dell’immaginario paesino di La Pierre-Saint-Christophe e gli spazi di maggior socializzazione del borgo, come il Bar Pesca. Si va così delineando il ritratto di personalità accese – il sindaco-becchino Martial, Thomas il proprietario del Bar Pesca, Max l’artista parigino in fuga, Lucie la scontrosa orticoltrice, suo cugino Arnaud, enciclopedia vivente di date e ricorrenze – caratterizzate per eccesso, fortemente idiosincratiche, ma che rimangono palpabili, reali, capaci di restituire l’atmosfera della provincia contadina, i suoi vezzi, i suoi riti, le sue pratiche di sopravvivenza, senza mai divenire macchiette o caricature.
Il diario tenuto da Mazon funge proprio da espediente narrativo per mettere in contatto il lettore con una realtà sconosciuta, solitamente lontana dai riflettori, secondo una prospettiva non mediata, non filtrata dalla penna del narratore, per cui l’ingenuità e lo spaesamento che caratterizzano il periodo di acclimatamento del giovane studioso e che si riflettono nei toni e nelle impressioni dei suoi appunti garantiscono maggiore trasparenza e veridicità alle descrizioni e agli stati d’animo messi via via nero su bianco. Mazon è, infatti, un protagonista decentrato, tendente all’autosabotaggio ma all’apparenza lucido e razionale, che si lascia a poco a poco inglobare dal suo oggetto di studio sino a far implodere dall’interno la supposta linea di demarcazione che pone il dottorando parigino dal lato gerarchicamente più elevato, riservato all’osservatore, e gli abitanti del paesino agreste sulla sponda opposta, quella destinata agli osservati. Alla luce di questo graduale rimescolamento delle posizioni iniziali, l’ultimo romanzo di Énard può essere letto, tra le tante piste possibili, anche come racconto sull’impossibilità di conoscere davvero qualcosa o qualcuno rimanendo a distanza di sicurezza, senza lasciarsi bagnare a pieno dalle leve di quell’ignoto che si vorrebbe scrutare costantemente protetti da una lastra di vetro. Osservare è solo la parte preliminare del fenomeno di accostamento, che deve essere poi integrata dall’immersione viva, dal dialogo, dal coinvolgimento emotivo, consapevoli però del rischio (forse salvifico) in cui si incorre: ossia quello di essere costretti a destrutturare le proprie tassonomie personali e le categorie ermeneutiche con cui si leggono e si definiscono gli accadimenti del mondo circostante. È sul liminare di tale avvicendamento che l’analisi antropologica di Mazon, sempre titubante e insicuro non solo dei propri mezzi intellettuali ma anche dei propri obiettivi accademici, si trasforma pian piano in un ben più decisivo processo di rinegoziazione identitaria, votato a scompaginare i presupposti e il senso originario della sua “missione” di studio.
Così come accade negli altri libri di Énard, si tratta, allora, anche qui di delineare narrativamente le coordinate esistenziali di un attraversamento, di un passaggio di soglia, anzi, di più passaggi, dalla città alla campagna, dalla mondanità alla ruralità, dalle solitarie astrattezze teoriche alla vividezza cangiante dei rapporti umani, con tutto il loro bagaglio di incomprensioni, fascinazioni, simpatie e rancori, senza scadere mai in facili manicheismi. Non c’è, infatti, alcuna apologia del ritorno alla terra, nessuna traccia nostalgica per un passato agreste ed edenico da recuperare, ma, al contrario, una riflessione anche velatamente critica (che rivela al fondo il sostrato politico del romanzo) su ciò che vuol dire oggi, nel 2021, lavorare in un contesto rurale, apparentemente lontani dai centri nevralgici del potere, eppure fortemente condizionati dalle crescenti speculazioni edilizie, dagli accelerazionismi finanziari e dalle miopi politiche post-industriali. Ad esempio, Mazon racconta con un velo di amaro sarcasmo di come una manifestazione di ecologisti contrari allo sfruttamento delle falde acquifere da parte di grosse multinazionali comporti un assalto del tutto ingiustificato da parte della polizia, nonché l’arresto di Lucie, una dei personaggi centrali del romanzo. Alle sezioni romanzesche maggiormente permeate da echi di attualità politica ed economica, si accompagna una riflessione sui luoghi in quanto depositari di una coscienza storica e di una memoria condivisa, dimensioni da preservare e da ri-significare per mezzo di una letteratura che funga da verifica di un reale colto nel suo svolgersi quotidiano e prosastico. Énard tenta così di archiviare quella visione fittizia ed esoticheggiante della vita rurale (la stessa che ha Mazon quando arriva nel paesino col suo carico sedimentato di pregiudizi e false convinzioni) per cui la campagna sarebbe soltanto un mondo chiuso, arretrato e incapace di comunicare con l’esterno.
Terminata, però, la prima sezione, il romanzo comincia a presentare una complessa stratificazione interna, per cui la dimensione diaristica viene sostituita da una narrazione “classica”, onnisciente, che allarga notevolmente il respiro romanzesco, sia in senso verticale – cominciano le incursioni nel passato della comunità, volte a ricostruire induttivamente la storia secolare di questo pezzo di Francia –, sia in senso orizzontale – la platea dei personaggi si allarga e di conseguenza aumentano i nomi, le affiliazioni, i nessi genealogici. Emerge, allora, il concetto di Ruota del Tempo (e all’inizio sorprende un po’, bisogna tornare un attimo a rileggersi l’epigrafe per intuirne il significato), metempsicosi delle anime per cui ogni morte non è che l’inizio di una nuova vita, sia essa umana, animale o vegetale, e soprattutto, in questo caso, espediente compositivo fondativo del romance, capace di tenere insieme e al contempo di contestualizzare i numerosi fili che iniziano a dipanarsi lungo le direttive sfalsate che dalla storia dei singoli si collegano e si compenetrano alla Storia collettiva – dai Plantageneti alle due guerre mondiali, passando attraverso i conflitti religiosi del Cinquecento e le campagne napoleoniche. Sulla scia di Sebald, la storia, soprattutto quella che piace ai collezionisti di minuzie e marginalia, diviene fonte inesausta di narratività, di potenzialità romanzesche, sia che essa rimanga introiettata ed esplorata all’interno della sua cornice contingente, come fatto in sé e per sé conchiuso, sia che se ne sondino le proiezioni innestatesi nel presente, i probabili legami ereditari e le eventuali continuità sotterranee con ciò che è accaduto dopo, anche a secoli di distanza, e con ciò che sarà in futuro, oltre il presente della narrazione.
Se in Zona e ne La perfezione del tiro lo scrittore francese si interrogava su cosa fosse il male, su quale forma potesse assumere e su quali effetti producesse su coloro che, volenti o meno, erano destinati a conviverci stabilmente, nel Banchetto, sulla scia di questo ciclico samsara che assurge a supremo strumento democratico e livellatore, la riflessione che sottende carsicamente la narrazione gravita intorno al senso della morte, al suo reale significato e ai suoi sorprendenti risvolti escatologici. Il trait d’union rappresentato dal principio di vita-morte-rinascita permette al narratore di decostruire la linearità del tempo materiale, la sua supposta oggettiva diacronia, per riattivarne le potenzialità sopite, mediante una costante manomissione garantita dalla forma romanzesca e da una successiva azione ricostruttiva, che permette di innescare nuove traiettorie di senso e sorprendenti ciclicità umane e storiche all’interno di una macrostruttura di impronta realista. In tal modo la superficie del presente affonda inconsapevolmente nei substrati di un passato che non finisce mai di riproporsi, per cui se da un lato la storia universale sembra procedere linearmente per tappe successive, dall’altro le persone si succedono ciclicamente e casualmente, rimanendo entità sensibili e senzienti, reificazioni temporanee – cinghiali, cavalieri, principesse, gran dame, sassi, arrotini, cani, lavandaie, assassini – di quella porzione di storia individuale che è toccata loro in sorte più o meno fortunatamente.
Nel bel mezzo di questo movimento ondivago e sussultorio, votato a ricomporre tutte le tessere del puzzle con l’intento di fondere definitivamente i destini singoli con i destini generali, si pone, quale epicentro, spartiacque e summa dell’intera architettura romanzesca, l’episodio che dà significativamente il titolo all’opera. Qui il libro di Énard diventa un’altra cosa ancora, un’orchestrazione rabelaisiana, una spartitura esplosiva che racchiude l’ode di una festa grande, corroborante, catartica, la festa del riso, del cibo e del vino. Così come accade ogni anno, la confraternita dei becchini si dà appuntamento per un convivio di tre giorni in cui la morte esce di scena, garantendo una sospensione temporanea dei suoi servigi e dunque liberando loro, suoi fedeli adepti, dal giogo opprimente e dall’assillo costante delle tombe e delle lapidi per almeno settantadue ore. Nel periodo in cui Mazon, il giovane dottorando, è a La Pierre-Saint-Christophe, tocca proprio a Martial, il sindaco-beccamorto, fare da padrone di casa. Come fosse una riproposizione contemporanea della Cena Trimalchionis di petroniana memoria, il banchetto della confraternita è pervaso sin dai suoi inizi da un esprit ludico, da una tensione edonistica, libertaria, giocosa e corporale che si riverbera in immagini di lussuria enogastronomica, secondo un climax figurativo che accresce il pathos della scena nonché gli effetti di divertissement che ne conseguono, concedendo a noi lettori momenti di puro godimento letterario. Sì, perché le dispute scherzose tra i convenuti divengono ben presto tenzoni medievali e sofisticati panegirici che ruotano intorno ai massimi sistemi e la scrittura di Énard si esalta e si arricchisce, le raffigurazioni del simposio tendono a una variegata abbondanza descrittiva, all’eccesso consapevole di dettagli e minuzie, all’iperbolico ben selezionato. Come insegna il simposio greco, il banchetto si trasforma non solo in cornice essenziale della parola e dei discorsi saggi, proprio in virtù della libertà garantita dall’ebbrezza, ma anche e soprattutto in un’esaltazione smodata della vita e dei suoi irrefrenabili appetiti, in un tripudio sensoriale in cui si mescolano senza soluzione di continuità sacro e profano, spirituale e materiale. È nel perimetro del banchetto, allora, che si accede alla vena carnevalesca dell’esistenza umana, spazio rigenerativo all’interno del quale è possibile rovesciare ogni antica gerarchia, annullando differenze, pacificando dispute, appianando liti.
Giunti alla fine del romanzo, una volta accostati questi numerosi ma complementari livelli di lettura, viene da chiedersi inevitabilmente se l’eccessiva abbondanza di materiale narrativo non finisca per indebolire l’intelaiatura formale e tematica che al fondo ne dovrebbe garantire l’intima coerenza. Questo non accade, perché anche se non tutte le sezioni che compongono l’arco romanzesco sembrano fondersi in un unicum armonico e omogeneo, è la prosa di Énard, al di là dei piani diegetici e dei rispettivi significati che si tenta loro di assegnare, il vero collante, il certificato di garanzia che convalida l’intera architettura testuale (bisogna perciò fare un plauso anche alla sua traduttrice, Yasmina Mélaouah). Forte di una lunga tradizione alle spalle, che guarda in Francia ma anche altrove, che parte da Dumas per arrivare sino a Sebald, Énard ha maturato uno stile, un’estetica della parola, una capacità di allargare il portato semantico del discorso, di renderlo plurimo e diversificato nelle scelte lessicali, sempre altamente espressive e spesso lontane dalla lingua standard, e nella costruzione fraseologica, ma con una padronanza sintattica, una varietà di soluzioni formali e un senso del ritmo narrativo (l’avvicendarsi frenetico di dialoghi, monologhi, elenchi, inserzioni poetiche, citazioni, descrizioni) tali da non appesantire mai la prosa e da non farla scivolare oltre il perimetro della storia. La lingua di Énard è il francese di Rabelais, di Villon, di Hugo, ma anche il francese dell’anno 2021, ed egli sa declinarla a seconda della direzione che la storia deve intraprendere, sa fonderla con la materia narrata per trarne il massimo in termini di espressività, gusto figurativo, raffinatezza lessicale. L’erudizione enciclopedica di questo autore europeo, cosmopolita, considerato l’anti-Houellebecq per eccellenza, è, infatti, sempre stemperata dal gusto per la battuta, per i saliscendi tra alto e basso, per il gioco di parole, per il bon mot, per la contaminazione reciproca dei più disparati registri linguistici, che gli permette di alternare con assoluta fluidità, così come succede spesso anche nel Banchetto, canzoni popolari, intermezzi lirici, retaggi verbali folkloristici e dotte elucubrazioni filosofiche. In virtù di questo plurilinguismo coscienzioso , che tutto sottende e trascende, verrebbe voglia di parlare per il Banchetto non tanto di realismo magico, com’è stato fatto, ma, rifacendoci a Bachtin, di realismo grottesco, il cui tratto caratteristico è, appunto, «l’abbassamento, cioè il trasferimento di tutto ciò che è alto, spirituale, ideale ed astratto, sul piano corporeo, sul piano della terra e del corpo nella loro indissolubile unità»[1].
Terra, corpo, natura, anima, vita, morte, rinascita, sradicamento, persecuzione, goliardia. L’ultimo romanzo di Énard è, allora, un micro-universo saturo di storie e di lingue che si sovrappongono, si intrecciano, si fondono, un libro-finestra che parte da una piccola e marginale regione della Francia, e da un protagonista tutt’altro che indimenticabile, per intraprendere una sorta di viaggio (o, forse, di scavo) ultratemporale tra le piaghe della Storia, capace di illuminare con fulgori repentini ciò che rende il passato dell’uomo mai del tutto passato, ossia l’infinità di storie reali e potenziali che vi si annidano al fondo, andando a ritroso sino all’origine di ogni cosa, e ne determinano poi la successiva parabola, con le sue proiezioni future, le sue biforcazioni, i suoi incroci, le sue improvvise svolte. Girando senza mai scendere sulla giostra infinita del tempo, ogni persona ha radici sempre più profonde di quelle che crede di avere, pare voglia suggerirci Énard. Girando senza mai scendere sulla giostra infinita del destino, ogni persona è sempre più di ciò che crede di essere.
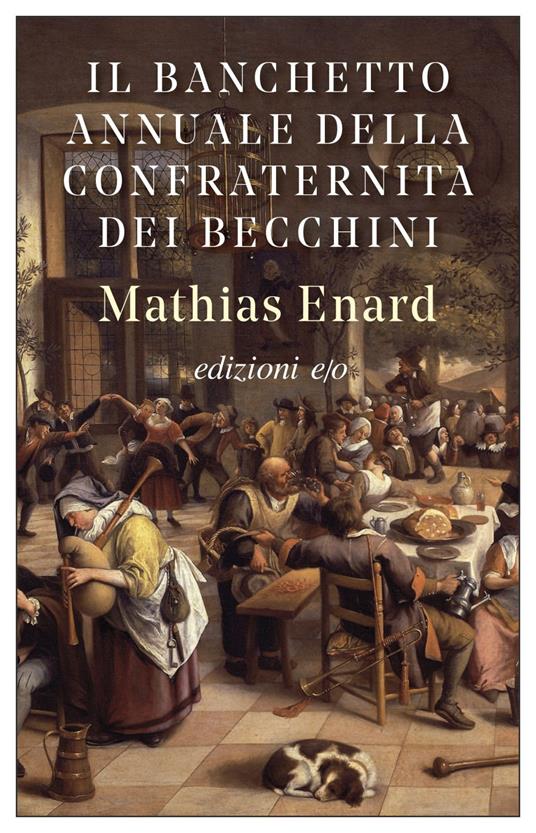
Mathias Enard, Il banchetto annuale della confraternita dei becchini, trad. Y. Mélaouah, E/O, Milano 2021, 470pp. 19,00€
[1] M. Bachtin, L’opera di Rabelais e la cultura popolare. Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale rinascimentale, Torino, Einaudi, 1979, p. 25.