L’attività di uno scrittore non è importante: bisogna partire da qui. Solo mettendo al centro la non importanza di questo lavoro, la sua assoluta gratuità, si possono forse misurare quali sono le possibilità di intervento. Questo l’ho avuto chiaro fin dall’inizio. Non ho mai dato un particolare valore al lavoro che faccio, anzi ho sempre provato un certo imbarazzo nei confronti degli altri tipi di lavoro, che a me sembrano “lavori veri”. La sensazione è che, finiti gli studi, i miei compagni hanno cominciato ad aprire pance, a tirare fuori gente dalla galera (o a mandarcela, a seconda dei ruoli) mentre io ho continuato a fare le cose che facevo da ragazzino e poi da ragazzo. Quindi ho sempre sperato di far coincidere questa mia disposizione con qualcosa che assomigliasse a un «lavoro». La macchina da scrivere con cui ho viaggiato per anni mi sembrava il mio strumento, il mio attrezzo, come la chiave inglese o il sifone di un idraulico: se avevo uno strumento, potevo forse pensare di avere anche io un lavoro. (p. 178)
Questo appena riportato è un passo dalla Zona del narrare, uno degli scritti di Del narrare, la recente raccolta di saggi di Daniele Del Giudice uscita da Einaudi per la cura di Enzo Rammairone. La zona del narrare è una splendida riflessione sulla scrittura, altrui e di Del Giudice stesso, in cui l’autore di Atlante occidentale si interroga non solo sulle modalità di questa attività, ma anche sul ruolo della letteratura nella sua vita e nella società in generale; rilanciando l’«assoluta gratuità» di questo mestiere, La zona del narrare funziona perfettamente da ouverture della seconda sezione del libro, che dà il titolo alla raccolta, e che riunisce gli scritti più teorici dell’autore sull’attività narrativa. La prima parte, invece, si intitola Scrittori, e raduna alcuni scritti dedicati agli autori preferiti di Del Giudice: fra tutti spiccano Primo Levi (è qui riproposta l’introduzione alle opere complete dell’autore torinese), Italo Calvino e soprattutto Joseph Conrad, protagonista di due saggi ma anche nome evocato spessissimo nella raccolta. Nonostante la varietà dei temi trattati, in tutti gli scritti è ben riconoscibile lo stile di Del Giudice, cosa che conferisce al libro un’apprezzabile coerenza complessiva.
Il tema di fondo, diventa chiaro saggio dopo saggio, è il rapporto fra letteratura e vita. Prima di addentrarci in questa discussione, esprimo un primo giudizio di valore sulle due parti, giudizio senz’altro personale ma non gratuito: la prima sezione, Scrittori, riunisce saggi dalla qualità più altalenante che la seconda, Del narrare. Quando parlo di qualità, non mi riferisco solo alla brillantezza dello stile, la quale varia, ma non viene mai meno del tutto; tanto più se si tiene conto della diversità dei testi, tra cui compaiono, nella seconda parte, anche scritti inediti, che si può supporre non siano presentati nella loro forma finale. Più che questo, parlando di qualità intendo uno specifico grado di entusiasmo che si avverte fra le righe: si percepisce chiaramente quando Del Giudice sta scrivendo di un autore che gli piace davvero e quando invece scrive di autori per mestiere. In questa seconda categoria rientrano i saggi che ho trovato meno interessanti, fra l’altro piuttosto brevi: quelli su Freud e Zweig. In ogni caso, le due parti dialogano bene l’una con l’altra, e insieme contribuiscono a fornire un’immagine chiara di cosa sia la letteratura per Del Giudice, e quale sia il suo posto nella società.
Il tema principale, si diceva, è il rapporto fra vita e letteratura. Conrad, autore prediletto, offre subito un appiglio per confermare questa impressione. A suo proposito, Del Giudice osserva: «varia da scrittore a scrittore la posizione della vita rispetto alla letteratura: per qualcuno la vita viene prima della letteratura, per qualcuno, e credo sia questo il caso di Conrad, la letteratura viene prima della vita» (pp. 130-131). Con «vita», Del Giudice si riferisce sia al concetto di esistenza, sia ai fatti propriamente biografici degli scrittori (un esempio: il passato da marinaio di Conrad e l’influenza di questa esperienza sui romanzi). Questo rapporto fra la biografia e l’opera, lungi dall’essere mero biografismo, guida Del Giudice in molti dei suoi giudizi. Risulta interessante il caso di Italo Svevo, in cui la dicotomia è sottolineata dallo pseudonimo e dalla mancata fortuna delle sue prime opere: «il signor Ettore Schmitz inventò lo scrittore Italo Svevo. Questi pubblicò due romanzi, Una vita e Senilità, che non ebbero alcun successo. Dal fallimento non conseguì una ritirata di Italo Svevo in Ettore Schmitz. Al contrario, Italo Svevo scomparendo dal mondo come scrittore, modellò una nuova e straordinaria creatura, che prima non esisteva, un personaggio per la vita: Ettore Schmitz il buon marito, il padre affettuoso» (pp. 90-91). Per altri, in maniera tragica, la parola letteraria viene necessariamente dopo la vita, come per Primo Levi: «al testimone si pongono due compiti connessi, primario il “voler sopravvivere”, successivo il narrare. Sarà testimone, cioè narratore, in quanto sopravvissuto; potrà portare la sua testimonianza, il suo racconto, solo se sarà riuscito a sopravvivere a quel che dovrà poi raccontare» (pp. 6-7).
Le varie gradazioni di questo rapporto, non sempre conflittuale, ispirano forse alcune delle pagine migliori di Del Giudice saggista; ritroviamo le due posizioni opposte nei due autori più amati, Levi e Conrad. Altre volte il dialogo è più complesso: è il caso di Calvino, «che spera ogni volta, attraverso il racconto di ogni storia, di trovare, di produrre un piccolo mutamento dentro di sé» (p. 54).
In ognuno di questi casi, però, il rapporto fra le due sfere dell’esistenza (reale e immaginativa) produce una serie di conseguenze che rappresentano gli ulteriori snodi dei ragionamenti di Del Giudice, su tutti quello visivo. Questo elemento è rintracciato in modo sistematico negli scrittori di cui tratta: «certamente Stevenson fu uno scrittore trionfalmente visivo» (p. 125); di Calvino dice: «a questo tipo di scrittore le storie si presentano molto spesso per immagini» (p. 54). L’elemento visuale è funzionale non solo alla lettura critica dei singoli autori, ma anche ad alcune osservazioni circa lo statuto della letteratura, che, secondo Del Giudice, nel corso del Novecento, è in qualche modo ‘retrocessa’ a mezzo fra gli altri mezzi, e deve per forza di cose intrattenere un dialogo con gli altri media. Tuttavia, questo principio va messo in pratica senza rinunciare alle peculiarità della scrittura letteraria, specificamente narrativa: «un narratore vede veramente soltanto mentre narra», scrive in Narrare e vedere, a p. 208 (recuperando una sua stessa intuizione su Stevenson). Il confronto tra letteratura e altri media è reso necessario dalla crescente confidenza del pubblico col mezzo cinematografico e televisivo, che influenza le modalità di scrittura, come argomenta in Cosa significa scrivere romanzi oggi. In ultima analisi, comunque, la questione visiva per Del Giudice rimane di natura ‘incantatoria’: «il vero problema non è smontare l’incantesimo ma conservare la capacità di incantarsi» (p. 230).
Proprio per questo, nei saggi è dato grande rilievo non solo all’atto visivo, ma anche all’oggetto della visione: cosa va visto, secondo Del Giudice? Innanzitutto molto, moltissimo spazio: «detesto il romanzo nelle stanze chiuse. Ho bisogno di spazio, ho bisogno delle strade, del territorio, dei bassifondi delle città, dei basalti, dei residui tellurici, dei fiumi e delle montagne, della geografia, che ho sempre privilegiato sulla Storia» (p. 170). Ma lo spazio – in particolare il cielo, luogo privilegiato da Del Giudice anche nella sua narrativa – va indagato e scandagliato mediante la tecnologia, e il rapporto che essa ha con gli oggetti. Quest’ultimo tema è già anticipato nel magnifico saggio su Verne della prima sezione, che contiene una rapida ma elegante rassegna di strumenti per il volo nel mito classico e medievale; in ogni caso, la questione della tecnica riguarda per forza di cose gli oggetti, il nostro rapporto con essi, e il suo cambiamento: «Forse su questa grande mutazione non si è mai riflettuto abbastanza. L’attenzione è stata tutta per la “crisi del soggetto”, così come si è manifestata sul finire dell’Ottocento. Certo, il “mondo dell’io” andava in pezzi, ma non ci si accorgeva di quanto, contemporaneamente, stesse andando in pezzi anche il “mondo delle cose”» (p. 240).
Per questa via, si affaccia in Del Giudice un sentimento di nostalgia analogica, e qui si insinua il rimpianto dovuto alla malattia che negli ultimi anni gli ha impedito di osservare l’ulteriore evoluzione delle dinamiche che aveva già intravisto, e di scriverne. Non di rado, nelle pagine di questi saggi si fa riferimento alla musica; la sparizione delle cose in favore delle loro versioni virtuali è esemplare proprio nella fruizione di quest’arte (che storie avrebbe raccontato Del Giudice, nell’epoca di Spotify? D’altra parte, era uno scrittore intelligente: non credo avrebbe vanamente inseguito l’attualità).
Al tempo stesso, uno dei risvolti dell’attenzione verso la tecnica delle attività umane è la componente di responsabilità personale. Non a caso, Rammairone pone il saggio su Levi all’inizio del libro, e proprio in quel testo c’è un paragrafo dedicato al rapporto fra tecnica e responsabilità nell’autore torinese che suona davvero come una dichiarazione di intenti da parte di Del Giudice. Prendendo spunto da La chiave a stella, lo scrittore evidenzia le possibilità letterarie di questo sentimento di responsabilità:
C’è una certa epica in Faussone, una nota epica, epica del lavoro ben fatto, della responsabilità personale di un’opera, foss’anche un traliccio, un derrick, montato, tirato su in chissà quale parte del mondo […]. Epica del lavoro, talvolta esaltata, talvolta temperata dal linguaggio del fare, gergo tecnico che di per sé non avrebbe risonanza poetica o letteraria, ma l’acquista […] (pp. 33-34).
Tecnica e oggetti hanno un’ulteriore funzione narrativa, secondo Del Giudice: non solo suscitano nostalgia o chiamano a responsabilità; attraverso di essi si può ragionare sui sentimenti, precisamente sulla parte dei sentimenti che muta col passare del tempo: «Il primo elemento di cambiamento dei sentimenti è proprio questo: gli oggetti che ci circondano, le cose che ci circondano. A me pare che, tutti voi potete constatarlo, le cose stanno cambiando. Non le cose in senso generico, ma proprio le cose della nostra vita quotidiana […]. Gli oggetti che usiamo e sempre più useremo perdono la loro solidità» (p. 217). Ci avviciniamo, qui, a quello che Del Giudice chiama «mistero del narrare», ovvero la possibilità di raccontare ciò che, in un mondo sempre più votato alla visualità, rimane nell’ambito dell’invisibile, o con più precisione, di ciò che necessita uno sforzo della visione per essere identificato. Se da un lato queste idee si ricollegano alla ricerca letteraria e visuale degli anni Ottanta (penso a Celati, a Tabucchi, a Magrelli), dall’altro Del Giudice offre anche un’interpretazione più contestualizzata, legata alle contingenze della nostra società:
La radice dell’immagine non è più estetica o contemplativa, ma diffusamente economica. […] Nel nostro mondo del tutto visibile, quello che a me sta a cuore è il margine dove si crea nuovo invisibile, cioè mistero. Una parte del non visibile, quello che potremmo chiamare il non visibile di «grado zero», è fatto delle immagini che non vediamo più: non ci ossessionano né ci appartengono semplicemente perché il nostro sguardo non le trattiene più (p. 211).
L’eleganza della prosa di Del Giudice rende l’esposizione dei vari concetti, che ho cercato qui di riunire in un percorso coerente, particolarmente attraente, e lascia senz’altro il rimpianto per la scomparsa della voce di questo autore. Anche quando parla di altri scrittori, o di idee sulla letteratura, si avverte nel fraseggio di Del Giudice una nota di assorta malinconia; si sente, in particolare, una doppia consapevolezza: quella divertita di chi ha provato a circoscrivere qualcosa, e quella serena, persino sollevata, di chi sa di non aver perimetrato claustrofobicamente il tema. Queste sensazioni pervadono la scrittura della seconda sezione, mentre nei saggi della prima – in cui Del Giudice è alle prese con autori amati – si aggiunge anche una certa passione, una gioia della scrittura e dello svisceramento, ben espressa, credo, dalla disinvoltura dei prelievi testuali, e dall’agilità delle panoramiche tematiche messe in atto in alcuni saggi (ad esempio, in quelli su Svevo e Verne).
Del Giudice è entrato nella nostra letteratura come romanziere e scrittore di racconti, ma la maggior parte dei suoi scritti è saggistica, ed è dedicata, mutuando un celebre titolo calviniano, ai «libri degli altri». Se l’idea di continuare a dissotterrare questa produzione è stata un’operazione felice, è perché essa ci dà un’idea ancor più precisa della sua statura come autore. Al tempo stesso, Del narrare lascia lieti ma non sazi: consola sapere dall’introduzione di Rammairone che vi sono ancora testi inediti, che forse meriteranno la pubblicazione in futuro. Al di là del divertimento intellettuale che si prova nel seguire i percorsi concettuali di Del Giudice, infatti, vi è una particolare forma di piacere legata propriamente alla sua prosa, alla gioia dell’analisi, e soprattutto allo stile con cui tutto ciò è condotto, che Del Giudice ripesca dal Conrad di Avvisi ai naviganti. Teorizzando una «perfetta esattezza», afferma: «forse quello che io cerco di leggere nei libri degli altri e cerco di scrivere nei miei è proprio la possibilità di lanciare avvisi ai naviganti, avvisi a quelli che, come me, vanno per mare» (p. 227).
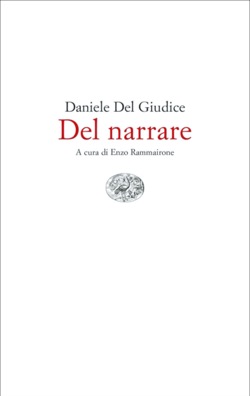
Daniele Del Giudice, Del narrare, a cura di Enzo Rammairone, Torino, Einaudi, 2023. pp. 276, € 36.