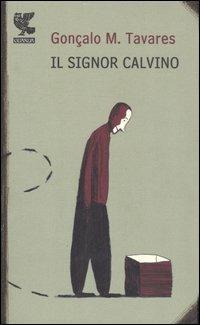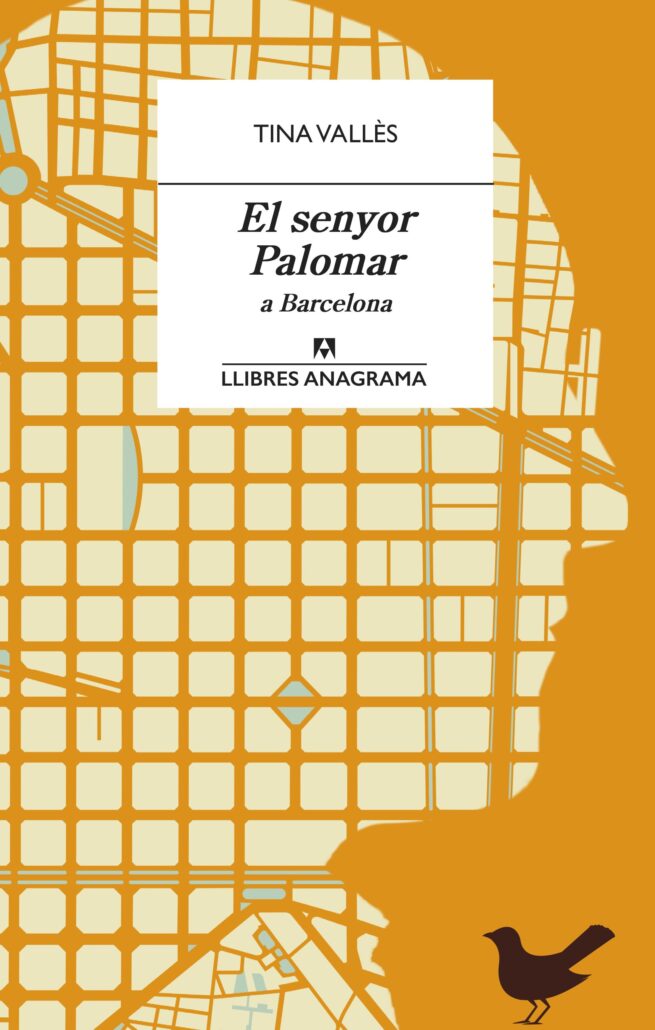Affermarsi… non vuol dire affermare un nome ed una persona. Vuol dire affermare se stesso con tutto quello che si ha dentro… E appunto in ciò sta la mia certezza: questo qualcosa non rappresenta l’oggi, rappresenta il domani. Ed è questo qualcosa che voglio affermare, non Italocalvino; Italocalvino morirà e non servirà più a niente: il qualcosa rimarrà e darà buon seme (7 Marzo 1942)
A cento anni dalla nascita di Italo Calvino, la storia della ricezione delle sue opere difficilmente può essere contenuta in un discorso lineare e strutturato. Da un lato, l’immagine autoriale di Calvino si è cristallizzata già durante la sua vita e carriera, per poi consolidarsi usando le coordinate fornite dallo stesso autore-editore, sempre attento al rapporto tra i testi dei suoi libri e i contesti in cui venivano ‘consumati’: venduti, letti, tradotti, adattati. Allo stesso tempo, i tanti contesti di ricezione – i vari media, le culture, i pubblici – fungono anche da prisma per far emergere i diversi lati e colori di Calvino, le possibili letture forse invisibili a un primo sguardo. Si ottiene così una moltiplicazione della figura autoriale, e Italocalvino, la firma stabile e riconoscibile, si trasforma in tanti Calvini a volte paradossali, incompiuti, sconnessi. Nondimeno, nonostante la pluralità di fatto, il nome dell’autore rimane quello: apparentemente sempre uguale a sé stesso, punto fermo in un mondo mutevole. Questo contrasto si ritrova nella critica letteraria e nel mondo accademico, ma anche (e su questo vorrei soffermarmi in questa sede) tra i colleghi-scrittori di Calvino, che adoperano il suo nome e lo inseriscono nelle proprie opere per riferirsi a versioni di Calvino molto eterogenee.
Dopo la morte nel 1985, con la veloce canonizzazione dell’autore ligure-cosmopolita, alcuni libri hanno presentato il nome di Calvino o di Palomar – il suo personaggio spesso ritenuto più autobiografico o persino testamentario – in sede di testo e paratesto. Si tratta di libri molto diversi tra loro, ma apparentati dall’uso del nome Italocalvino, e in qualche modo anche influenzati dalla sua presenza. In alcuni questa presenza è più approfondita e precisa, su altri aleggia uno spirito calviniano non sempre perfettamente definibile. In ogni caso, la scelta di citare Calvino nel titolo, oppure nel testo di sopraccoperta o di risvolto, costituisce un invito a cercare l’autore nel libro stesso. Cosa può allora trovare di Calvino chi legge questi libri? E che informazioni se ne possono trarre sulle diverse fasi della ricezione calviniana, sul rapporto tra testi e contesti?
I quattro libri che verranno qui presi in considerazione sono Il salto con le aste di Domenico Starnone (1989), O senhor Calvino di Gonçalo M. Tavares (2005), El senyor Palomar a Barcelona di Tina Vallès (2021) e Il bambino e le isole (un sogno di Calvino) di Marino Magliani (2023). I libri non verranno discussi tanto nel loro insieme o per il loro specifico valore letterario, ma prevalentemente alla luce della presenza calviniana che catalizzano. Partiremo proprio dal peritesto, da ciò che attira i lettori verso i libri, verso questi e non altri, dopo aver scavalcato la valanga o le falangi di Libri Che Hai Intenzione Di Leggere Ma Prima Ne Dovresti Leggere Degli Altri.
Nel caso di Starnone, Calvino non è presente nel titolo, Il salto con le aste, ma sicuramente lo è nella sopraccoperta della prima edizione pubblicata da Feltrinelli (il libro è stato poi riedito da Einaudi nel 2012). Qui si legge il nome di un solo personaggio della storia, una volta viene menzionato il nome di Starnone stesso, mentre ricorre ben tre volte il nome di Calvino. È importante ricordare che il libro è stato pubblicato nel 1989, quando Starnone non era ancora uno scrittore pienamente affermato. Sono gli anni in cui la scuola è ancora lo scenario dominante dei suoi scritti. Ma sono anche gli anni successivi alla morte di Calvino, in cui l’importanza del suo lascito si fa sentire, e per alcuni anche il peso del monumento a lui eretto (si veda ad esempio il numero della rivista Wimbledon nel 1990, in cui voci autorevoli come quella di Franco Fortini criticano fortemente soprattutto il Calvino oulipiano-postmoderno). Starnone non ha mai nascosto il suo apprezzamento per Calvino, che trasmette però in modo particolare e con molta ironia in Il salto con le aste.
Il testo di sopraccoperta informa che Michele Astarita, giovane membro del PCI, vuole diventare scrittore come Calvino. Si capisce che lo sfondo storico di questo desiderio sono gli anni Sessanta, quando Astarita riceve una lettera di Calvino che risulta poi essere apocrifa. E così già sulla soglia del testo nasce un dialogo interessante, dal momento che l’apocrifo è un tema borgesiano-calviniano ben noto, che avrà anche il suo peso nella discussione che Carla Benedetti, in Pasolini contro Calvino (1998), farà dell’’effetto di apocrifo’ dei libri di Calvino, effetto a suo parere egemone nella letteratura dell’epoca. Oltre all’apocrifo, la sopraccoperta presenta anche l’ironia come punto forte del libro, anch’essa parte integrante del ‘marchio Calvino’.
In Il salto con le aste Italo Calvino è allo stesso tempo onnipresente e assente. Si legge tante volte il suo nome, ma la sua presenza nella trama è volutamente superficiale, legata prevalentemente alla sua reputazione. Il peritesto dei libri d’altronde è anche parte intrinseca dell’esperienza di lettore di Michele Astarita, che (come Starnone stesso) scopre le opere di Calvino all’età di 17 anni, intorno al 1960, ma all’inizio solo tramite le copertine: «Se le era studiate, contemplandole nelle vetrine delle librerie, nelle edicole della stazione. Studiava per ore tutte quelle dei libri esposti» (116). Calvino raffigura l’ideale da raggiungere, col suo fascino da viaggiatore cosmopolita – «Imparò che questo scrittore se la sapeva spassare. Saliva sugli alberi, viaggiava, parlava di una cosa che si chiamava bitgenerèscion» (11) –, ma anche e soprattutto la meta irraggiungibile, distante e distaccato, quasi irreale e sicuramente intoccabile: «Fu alla fine degli anni ’50 che Michele scoprì l’esistenza di Calvino. La prima volta lo intravedemmo appena: distante, era lì a quattro passi come la statua di un santo taumaturgo che non si fa a tempo a toccare» (11). E, verso la fine del libro, la distanza non è certo colmata: «Perché Calvino era lunare. Pallido del pallore che al cinema ha la gente che viene da un altro mondo. E arrampicarsi fino a lui […] sarebbe stato uno sforzo umiliante» (172). Quel Calvino lunare fa pensare alle belle parole scritte da Natalia Ginzburg qualche anno prima, in occasione della morte dell’autore: «A poco a poco sono scomparsi dai suoi libri i paesaggi verdi e frondosi, le nevi scintillanti, l’alta luce del giorno. Si è alzata nel suo scrivere una luce diversa, una luce non più radiosa ma bianca, non fredda ma totalmente deserta. L’ironia è rimasta, ma impercettibile e non più felice di esistere, bianca e disabitata come la luna».
La distanza che separa i protagonisti da Calvino è anche una differenza generazionale, quasi un abisso: «È inavvicinabile […] inavvicinabile per noi, cioè, che già provavamo rancori senza fondo contro il padre, la madre, l’umana specie, il tempo, il luogo, il seme della semenza che casualmente ci aveva generato, collocandoci dove ci trovavamo invece che altrove» (134). Questo abisso ha a che fare non solo con la letteratura, ma anche con la politica: «Calvino non può capire tutto quello che capiamo noi; sarà anche un’aquila, ma appartiene a un’altra generazione; è un borghese illuminato, propenso alla composizione degli opposti» (180). Si intravedono qui anche le possibili critiche a un Calvino non-politico, troppo raffinato e rarefatto. Lo stesso Michele Astarita che prima ha cercato l’approvazione di Calvino, alla lettura di una nuova lettera contraffatta nello stile dell’autore, reagisce pensando: «Bene. Però basta con la letteratura» (180). Calvino in questo libro è fascino giovanile e disillusione di mezza età, è presenza-assenza che non si può ignorare, ma di cui non si può neanche seguire l’esempio. Rappresenta una pietra miliare, ma proprio in quanto pietra con lui non si va avanti (ma questo in realtà non sarà vero per Starnone, che ancora nel 2023, nella sua rubrica su Internazionale, dimostra di apprezzare Calvino).
Lo scrittore portoghese Gonçalo M. Tavares pubblica O senhor Calvino nell’anno in cui vince il premio José Saramago, il 2005. Il testo di risvolto dell’edizione italiana (Guanda) è estrapolato dalla postfazione di Roberto Mulinacci, professore di letteratura lusofona. Vi si legge che «A dispetto della mancanza di più concreti appigli referenziali, Il signor Calvino di Tavares è comunque un testo intimamente calviniano per affinità elettiva, un precipitato di invenzioni, surreali e piene di ironia, capace di far vibrare alcune delle corde tipiche dello scrittore italiano». Sulla retrocopertina vediamo il quartiere in cui il signor Calvino vive, con il signor Valéry, ma anche Henri, Brecht, Walser, Breton e altri (e solo Woolf in rappresentanza del genere femminile). Tavares produce dieci di questi volumi ‘O Senhor’ tra il 2002 e il 2010, che insieme costituiscono O Bairro, ‘il quartiere’: non sorprende quindi che nel libro prevalga la logica della serie. Nel progetto, che è un omaggio alla letteratura, Calvino stesso diventa un Palomar o un Marcovaldo, con toni surrealistici e fiabeschi accentuati. Una leggerezza pensosa pervade il testo e il protagonista, che di racconto in racconto si pone delle mete insolite, medita soluzioni a problemi solipsistici ed esplora il filo che collega il concreto e il quotidiano da una parte e la sua mente fantasiosa e matematica dall’altra (mente rispecchiata nei disegni geometrici e semplici che accompagnano i racconti). È quella curiosa attenzione e attenta curiosità al mondo, il muoversi tra il (micro)cosmico e il comico, tra la Via Lattea e le tante possibili vie laterali, che fa pensare forse al Calvino ‘vero’– seppur in un modo trasfigurato, più leggero e fanciullesco:
Per allenare i muscoli della pazienza il signor Calvino metteva un cucchiaio da caffè, piccolino, accanto a una pala gigante, pala utilizzata abitualmente in opere di ingegneria. Subito dopo, imponeva a se stesso un obiettivo non negoziabile: un mucchio di terra (50 chili di mondo) da trasportare dal punto A al punto B – punti situati a 15 metri di distanza l’uno dall’altro.
L’enorme pala rimaneva sempre per terra, ferma, ma visibile. E Calvino utilizzava il minuscolo cucchiaio da caffè, tenendolo con tutti i muscoli disponibili, per eseguire il compito di trasportare il mucchio di terra da un punto all’altro. Con il cucchiaino ogni minimo pezzo di terra era come accarezzato dalla curiosità attenta del signor Calvino.
Paziente, nel compiere il lavoro, senza desistere o utilizzare la pala, Calvino sentiva di imparare svariate grandi cose con un cucchiaino piccolino (47)
Se il libro di Tavares ci lascia col dubbio che il signor Calvino si sarebbe potuto benissimo chiamare signor Cavilla, e che il rapporto tra Calvino e il contenuto del libro sia fin troppo esile per giustificare un titolo con quel nome così ingombrante e importante, Il bambino e le isole (un sogno di Calvino) di Marino Magliani (66thand2nd) comporta simili sfide interpretative. Il titolo indica chiaramente una presenza calviniana, ma anche una presenza indiretta, sognata e forse ingannevole: come interpretare ‘Calvino’ nel sottotitolo? Calvino è sognato o sognatore o dimezzato tra le due possibilità? A questa domanda si aggiunge il curioso contrasto tra la menzione nel titolo, e quindi l’innegabile enfasi che questa scelta implica, e le parentesi tra cui si trova il nome di Calvino. La copertina dichiara quindi di nuovo una sorta di presenza-assenza di un nome insormontabile quando si parla di Liguria (come fa questo libro). E anche qui, leggiamo nel risvolto, si trova un Calvino bambino, diverso dalla figura canonizzata e pensosa con le caratteristiche rughe della fronte tra il severo e l’ironico. È un Calvino bambino che incontra un anziano Walter Benjamin a Sanremo, il quale gli racconta la storia di un bambino che perde il pallone dall’altro lato dei binari e va a cercarlo senza mai attraversarli (come promesso alla madre). È una storia che il ‘vero’ Calvino raccontò ad amici ma non scrisse mai, e che quindi si presenta quasi come un inedito calviniano.
Il bambino sognato prende corpo in questo romanzo e attraversa la Liguria in una missione che, come quelle descritte da Tavares, non è dettata dalla logica o della verosimiglianza, ma da una logica fiabesca. Walter Benjamin sparisce ben presto dalla storia e il suo ruolo è soprattutto pretesto o pre-testo (si tratta di una trovata di Magliani basata sulla reale presenza di Benjamin a Sanremo negli anni Trenta). Ma Calvino rimane, in un dialogo che, a parte il nome che ricorre spesso e i commenti su libri o viaggi e legami liguri, è quasi interamente implicito, passando soprattutto per il paesaggio. Non a caso quest’anno è uscito anche un volume sul paesaggio ligure in letteratura che include sia Calvino che Magliani (e qui Calvino non è tra parentesi ma il primo nome del titolo: Calvino, Biamonti, Magliani. Il racconto del paesaggio, lo sguardo, la luce di Luigi Marfè et al.). Magliani, che risiede da decenni nei Paesi Bassi, spiega nella nota d’autore a fine libro il ruolo del paesaggio: «Insomma, a forza di stendere prose a una quota pianeggiante del genere nederlandese, uno finisce per prenderci fin troppo la mano» (181). È una Liguria orizzontale, la sua, fatta più di mare e isole che dei retroterra o delle terrazze e colline della Strada di San Giovanni. Invece dell’opaco e aprico di Calvino, la Liguria di Magliani esplora prevalentemente gli assi orizzontali e verticali che determinano il paesaggio della regione: un paesaggio concreto, più vicino alla calviniana Speculazione edilizia. I nomi delle stazioni sono come le ancore di realtà di questa fiaba. I lettori seguono il filo dei nomi che si possono tracciare su una mappa (ferroviaria): Arenzano, Bergeggi, Torre del mare, Spotorno, Albenga, Alassio, Taggia, Cervo, Andora, Laigueglia, Capo Mele e l’inevitabile Sanremo. Forse il ‘personaggio’ più approfondito e poetico del libro è proprio il paesaggio e il bambino dei binari prende vita solo per suo tramite:
Sulle colline tra il Monte Calvario, il Parasio e Capo Berta ci si era fermato più a lungo. Dalle serre in cima si vedevano le spume crollare su altre spume e infine sulle spiagge, ma era un altro trucco e le onde sotterranee in qualche modo dovevano risalire lentamente la china, altrimenti prima o poi sarebbe finita l’acqua. A volte la quota dell’orizzonte sembrava proprio all’altezza del Calvario, a un tiro di scaglia. Poi, se si svegliava, esplodeva la Corsica, si stirava e allungava spazi e sogni e i corridoi di luna sbadigliavano fin dentro la prossima notte (32).
E in quel paesaggio c’è anche Calvino, è naturale: c’è appena il suggerimento delle Città invisibili, c’è il Palomar che guarda il mare, c’è Il barone rampante, ma tutti sono evocati soprattutto dal paesaggio. Anche la resistenza ligure è menzionata, così come i ritorni di Calvino in zona (per incontrare Carlo Levi o dopo la morte di sua madre), e i mancati ritorni (l’invito a presentare il volume Storia della resistenza imperiese che giunge troppo tardi). Tutto sommato il paesaggio convince di più, come legame con Calvino, rispetto ai commenti di lettura sparsi per il libro o a quel bambino che non conquista mai veramente il cuore del lettore, neanche quando invecchia fuori tempo, senza invecchiare. Ma forse anche quel bambino-vecchio è un perfetto omaggio al «cinico bimbo Calvino» che «va incolume» (sono le parole di Fortini nel 1959), o al bambino anziano che ha scritto pazientemente Le città invisibili (secondo il giudizio di Pier Paolo Pasolini), o al ragazzo che non poteva invecchiare di cui scrisse la Ginzburg.
Tutti i libri discussi in questa sede sono accomunati dalla scelta di rappresentare un Calvino molto giovane, oppure presentato dalla prospettiva dei giovani ad un pubblico di adulti. A questo proposito, vale la pena di citare un altro libro, stavolta per ragazzi, uscito quest’anno: In fuga col barone nel mondo di Calvino di Stefano Tofani (Edizioni EL). Come Magliani e Starnone, Tofani parte dalla premessa di un (mancato) incontro con l’autore che poi diventa un viaggio nel suo mondo: nel caso di Magliani soprattutto nella sua regione, per Tofani invece nel paesaggio di carta offerto dai suoi libri.
Il più calviniano tra i volumi qui considerati è, a mio parere, anche il più riuscito. Come Magliani, Tina Vallès schiude una realtà geografica ben delineata nel suo libro El senyor Palomar a Barcelona, scritto in catalano. La premessa del libro è semplice: Palomar non è morto e si è trasferito a Barcellona, e il libro segue le sue (dis)avventure nella nuova città per un anno, che va dall’agosto del 2019 al luglio del 2020, e che include quindi anche le prime esperienze della pandemia. Come negli altri casi, la presenza di Calvino (e di Palomar) è evidente dal titolo e dalla sopraccoperta. In una nota autoriale a fine libro Vallès spiega che questo raccoglie, come Palomar, una dozzina di articoli mensili usciti prima in altra sede. Tra i nomi nei ringraziamenti si trova anche Tavares con il suo Bairro.
Anche questo libro si riallaccia soprattutto al Calvino leggero, che tramuta la realtà in fiaba, anche quando i contorni della città sono concreti e ben definibili, descritti coi loro nomi e nei loro aspetti materiali. A differenza degli altri lavori, tuttavia, il dialogo intertestuale è molto più dichiarato e fitto: non c’è quasi pagina del libro che non presenti un riferimento aperto o sottile a Palomar, Le città invisibili, Marcovaldo ed altri libri calviniani. Anche il personaggio di Palomar è indubbiamente riconoscibile, reso gradualmente un personaggio a tutto tondo di cui si indagano i tic, le insicurezze, le contraddizioni, le debolezze e le ansie. È un personaggio apprensivo e nevrastenico, che non aiuta abbastanza sua moglie e sua figlia nelle faccende domestiche (e qui viene da pensare a La poubelle agréée), che non sopporta i rumori forti, il caos della folla, gli imprevisti. Ma nonostante tutti questi inconvenienti e i tanti contrattempi, mantiene intatto il suo sguardo unico su ogni ambiente in cui si trova.
Ciò che Palomar vede e fa conserva una chiara eco delle sue micro-avventure di circa 25 anni prima, con dei piccoli cambiamenti. La formaggeria si diffrange in una libreria, una profumeria e una panetteria; invece di isolare un’onda Palomar vuole isolare un minuto; mentre il geco si ritrova sotto forma di uccello, lumaca, gatto e raganella (la tartaruga invece rimane tartaruga). I veri cambiamenti stanno piuttosto nella presenza di aspetti già rintracciabili nel primo Palomar, ma spesso troppo sottili per essere notati o apprezzati dalla maggior parte della critica; oppure nella descrizione di lati possibili di Palomar che Calvino stesso non ha voluto sviluppare; o anche nell’aggiornamento al mondo odierno di alcuni aspetti dell’originale.
Per iniziare con la prima categoria, il Palomar di Vallès non è certo solo un occhio ambulante. Non lo è nemmeno quello originale, certo, ma considerando l’enfasi teorica e retorica sulla vista nel libro originale e nel suo paratesto (dal titolo stesso alle interviste), non è certo strano che il Palomar di Calvino abbia la reputazione del telescopio. Il Palomar di Vallès, invece, quando va in cerca di sé stesso nel Carrer Palomar, ossia calle Palomar, si ricorda che questa zona non prende il nome da un osservatorio, ma dalle colombaie (paloma infatti significa ‘colombo’, ‘piccione’) che si trovavano in questa zona di città dal X secolo. A Barcellona quindi Palomar si rende conto della propria vicinanza ai piccioni (e ai tanti animali che incontra in generale), con cui si identifica, «perché anche loro vagano per le strade e imparano a conoscere la città pezzo a pezzo, come lui» (160).
Tante volte Palomar si guarda dentro invece di guardare fuori, talvolta non può fare il suo ‘lavoro’ di osservazione, oppure si ritrova a meditare sul perché non guardi certe cose, come nel caso di un uomo che chiede l’elemosina davanti alla panetteria: «Vuole pensare che sia la prima volta che lo vede, ma forse è solo la prima volta che lo guarda» (110). Altre volte cerca di capire cosa può fare con le cose invisibili come con un virus. Ma anche in quel caso, e anche in lockdown, quando il campo visivo si restringe notevolmente, Palomar spesso riesce a vedere e capire, come in questa bellissima riscrittura di una scena famosa da Le città invisibili (e, si badi, qui l’invisibilità acquista un significato diverso):
È incredibile quanto si riesca a osservare quando non c’è niente da vedere, pensa Palomar con lo sguardo fisso sui graffi del legno attorno alla serratura dell’appartamento accanto al suo. Ci abita una famiglia numerosa, i cui membri entrano ed escono sempre con molto impeto e i segni della loro fretta sono rimasti incisi per bene, al punto da far saltare un po’ la vernice marrone scuro che rende tutte le porte uguali.
L’area attorno alla serratura dei Palomar, invece, è immacolata come il primo giorno: sentirsi sempre di passaggio ti fa aprire e chiudere le porte con un atavico rispetto; non sai mai quando lo farai per l’ultima volta (134).
In più, Vallès insiste sulla duplicità o molteplicità di una figura che certamente è instancabile nella sua ricerca di vedere «l’inesauribile superficie delle cose» (parole calviniane riprese da Vallès, 55), ma è anche un corpo che registra il mondo in tutti i sensi e con tutti i sensi. Nella versione di Vallès, Palomar non è solo una mente isolata, perché la mente dipende dalle mani che si aggrappano al ponte, dal naso o dal sedere che si raffredda troppo, dai fuochi o dal chiacchiericcio in un bar che lo stordiscono, dalle vibrazioni di musica che sente attraverso il corpo intero (steso per strada, una delle tante volte che dà spettacolo di sé). Varie volte ci sono persino sfuggevoli sensazioni di sinergia («Il signor Palomar si sente musica […] fuori dallo spazio e dal tempo, senza corpo, senza materia, soltanto suoni e ritmo fin quando…», 37) o sinestesia («avvolti da odori che si possono quasi masticare, da rumori che si possono toccare, un capogiro sensoriale che Palomar cerca di affrontare con dignità… ma non ci riesce», 38), oppure casi in cui il personaggio si concentra su un (altro) senso (come in Sotto il sole giaguaro) cercando di essere solo naso o pancia o tatto.
In questo libro Palomar è anche un corpo instabile che cerca il sostegno di moglie e figlia, un corpo malato bisognoso di cure (almeno dalla sua prospettiva ipocondriaca). Le domande che si pone attraverso il corpo sono quasi sempre domande sul rapporto con l’ambiente in cui si trova: quello locale, ma anche quello cosmico. Ogni volta che si domanda se c’è posto per lui in un contesto specifico, scatta in modo naturale la domanda sul suo posto nell’universo, sulla sua esistenza, sulla ragione per cui c’è invece di non esserci: «Il signor Palomar non riesce a vedere alcuna certezza, in quella costellazione di persone, e piano piano i suoi occhi vogliono rivolgersi verso il buio del cielo, non per osservare le stelle, ma per perdersi nell’oscurità, perché cosa ci può mai essere di più stabile del nulla?» (54). Il suo corpo comico diventa persino un corpo cosmico, quando è sole e solo nel mezzo della folla che gli sembra giri intorno a lui senza notarlo (ambedue le parole si scrivono sol in catalano, 84).
Per quanto riguarda le aggiunte all’originale, Vallès approfondisce l’occhio antropologico (e non solo zoologico) di Palomar. Il suo personaggio non si interessa di politica in modo diretto, ma sicuramente si interroga sulle emozioni, sulla rabbia di massa, sulle proteste che vede intorno a sé nell’ottobre 2019 (e da questo esempio si capisce che l’ambientazione non è solo sfondo, ma parte reale delle esperienze di Palomar). Palomar non manca di essere l’oggetto di una velata ironia da parte dell’autrice, come quando viene descritto in libreria, un’ora prima della presentazione di uno studio di argomento politico che non gli interessa, solo per poter studiare la gente: in quel caso non si rende conto che fuori la strada è invasa dalle proteste (e che non ci sarà nessuna presentazione in libreria). Ma è proprio quel non sapere e non capire che spinge Palomar fuori dal suo habitat naturale, e perciò la sua scelta di osservare la gente è perfettamente coerente con le motivazioni profonde del Palomar originale: «Lui salirebbe su un terrazzo a guardare le stelle, ma la rabbia della gente lo chiama di nuovo, perché della gente non ha ancora capito tutto quello che gli serve per smettere di osservarla. È così che lavora: finché non ha capito, il lavoro non è concluso» (52). Questo Palomar più palombaro, che scava in profondità, è sicuramente apparentato al Palomar che si morde la lingua, che non si esprime su alcune questioni prima di avere l’assoluta certezza di essere convinto di quel che dice – certezza che, puntualmente, non arriva. Ed è indubbio che sarebbe stato molto interessante avere i resoconti di un Palomar che va per le strade a vedere più da vicino gli anni Settanta e la Storia in atto, osservando e interpretando la rabbia di massa, la situazione politica sempre in movimento, fragile ed esplosiva, di quegli anni.
Più moderno rispetto all’originale è il ruolo della famiglia di Palomar, di sua moglie e sua figlia. Mentre nella versione di Calvino sono appena delle sagome, menzionate ma non approfondite, Vallès presta loro più attenzione, pur se in relazione al protagonista. Nel loro sguardo non c’è tanto la derisione o l’estraniamento di fronte agli strani comportamenti di Palomar; prevale invece il loro amore, la profonda conoscenza e l’accettazione di Palomar con tutti i suoi difetti. Una pagina caratteristica e commovente che lo dimostra è uno dei frammenti che dialogano in modo diretto con l’originale. Palomar va con la figlia (ormai quindicenne) allo zoo di Barcellona, luogo in cui era già stato nella versione di Calvino per vedere il gorilla albino. La figlia, per cui il gorilla albino fino a quel momento è stato soltanto un personaggio di un affascinante racconto, va controvoglia, è critica verso l’uso di tenere gli animali in cattività. Durante la passeggiata verso lo zoo, Palomar stesso inizia a dubitare dell’idea che lui stesso ha avuto, perché il gorilla è morto da tempo e non vorrebbe che il bel racconto nella mente della figlia si trasformasse nella triste realtà di un gorilla morto (e si noti che le ragioni del ripensamento di Palomar sono di diversa natura rispetto a quelle della figlia, forse mettendo a nudo una differenza generazionale: per l’una è triste la vita, per l’altro la morte dell’animale). Palomar si ferma a pensare sotto l’Arc de Triomf e la figlia, quando se ne rende conto, invece di chiamarlo comincia a osservarlo:
Palomar non è molto alto, ma per lei ha ancora le dimensioni irraggiungibili che suole avere un padre per una figlia. Lo vede grande e, se si concentra sulle sue mani, si sente invadere tutto il cuore da un’ondata di benessere e sicurezza. Ha mani forti, dita grosse e di un colore rosa primate. Inoltre, da un paio d’anni, ha anche qualche pelo bianco e, in testa, da circa cinque anni si pettina una discreta capigliatura grigia che perde le tonalità scure un inverno dopo l’altro (72).
È l’amore della figlia, ma anche l’occhio della conoscitrice con cui lo osserva, che trasforma Palomar stesso in Floquet de Neu, ‘fiocco di neve’ (questo il nome del famoso gorilla). E subito dopo si trova un altro racconto pieno di ibridi uomo-animale. Nel racconto ‘Con le ruote ma vorrebbero le ali’, Palomar «si vede riflesso in una vetrina e gli viene in mente il movimento disarmonico delle giraffe allo zoo di Vincennes» (75). Lo sguardo della figlia è diventato anche il suo.
E se lo sguardo di Palomar viene ricambiato da altri esseri anche nel libro di Calvino (si pensi soprattutto all’occhio stratificato e complesso dell’iguana), per Vallès quegli sguardi non sono imperscrutabili. I lettori hanno accesso anche a ciò che vedono gli occhi intorno a Palomar, e il corpo negato diventa un corpo studiato (soprattutto dalla famiglia). Per dirlo in termini palomariani: il mondo guarda il mondo. Anche la moglie, nonostante il lungo matrimonio, guarda Palomar con un’attenzione che di solito si rivolge all’ignoto, e mentre cerca di immedesimarsi in lui e nel suo modo di rapportarsi con l’ambiente, lui si trasforma marcovaldianamente in un albero sotto il suo sguardo: «La signora Palomar fa cenno di sì con la testa mentre con gli occhi cerca lo sguardo di suo marito, che sembra sempre di più un albero. E insieme, con gli sguardi coordinati, osservano quel passero scontroso che si ritrovano per figlia e non hanno bisogno di dirsi null’altro» (92-3).
Concludendo, si potrebbe dire che tutti i libri qui discussi riportano Calvino all’infanzia, e in varie misure insistono su un mondo leggero e incantato, altamente letterario anche se inserito in un contesto reale e riconoscibile, forse pieno di insidie ma anche di possibilità di trasfigurazione attraverso il potere dello sguardo, della volontà. I quattro libri mostrano chiaramente il ritorno dell’autore (una volta dichiarato morto da Roland Barthes), per la maggiore attenzione che rivolgono al ‘personaggio’ Calvino, alla sua figura autoriale, invece che ai suoi testi. Allo stesso tempo, e forse paradossalmente, attraverso la scelta di un Calvino leggero, ma anche di una leggerezza ulteriormente infantilizzata, si accentua il Calvino apolitico, e lo stereotipo di un autore poco legato al mondo ‘reale’ e cangiante, fissato nel suo mondo parallelo di fiaba e filosofia (a differenza di Pasolini e altri scrittori della sua generazione). Nondimeno, pur con meriti diversi e diversa qualità letteraria, il lavoro di questi autori sul lascito di Calvino rispecchia la fantasia e la disciplina del gioco. Lo dice bene Walter Benjamin, scrittore e pensatore troppo maestoso per lasciarlo lì a Sanremo come suggeritore di fiabe:
Lambiccarsi pedantescamente il cervello per creare prodotti – materiali visivi, giocattoli o libri – adatti ai bambini è sciocco. Sin dall’Illuminismo è questa una delle fissazioni più stantie dei pedagoghi. La loro infatuazione per la psicologia gli impedisce di accorgersi che il mondo è pieno dei più incomparabili oggetti dell’attenzione e del cimento infantili. Dei più azzeccati […] Negli scarti di lavorazione riconoscono la faccia che il mondo delle cose rivolge proprio a loro, a loro soli. In questi essi non tanto riproducono le opere degli adulti quanto piuttosto pongono i più svariati materiali, mediante ciò che giocando ne ricavano, in un rapporto reciproco nuovo, discontinuo. I bambini in tal modo si costruiscono da sé il mondo oggettuale, un piccolo mondo dentro il grande (W. Benjamin, Strada a senso unico. Scritti 1926-1927, a cura di G. Agamben, Einaudi, Torino 1982, p. 13).
Un piccolo mondo dentro il grande, fatto con i più svariati materiali trovati in giro. Questo è il dono che ogni grande scrittore offre ai propri lettori e ai futuri scrittori che parleranno, a loro modo, a nuove generazioni.