Vivre vite: Vivi veloce – un titolo strano quello dell’ultimo libro di Brigitte Giraud edito in Italia da Guanda. Strano per un romanzo, un contratto e densissimo memoir che ripercorre solo pochi giorni, pochissime azioni della vita dell’autrice – o, per meglio dire, del suo compagno. Giorni in cui la vita di Giraud è cambiata per sempre, giorni a cui lei vorrebbe disperatamente ritornare. Non solo per cambiare le cose ma anche per capire, per comprendere. Ed è proprio per analizzare e comprendere che Giraud scrive questo libro, che si è aggiudicato nel 2022 il premio Goncourt, il più prestigioso dei premi francesi (per intenderci: Emmanuel Carrère ancora non è ancora mai riuscito ad aggiudicarselo): l’equivalente, per quel che può valere, del nostro Strega. Tra i nomi dei vincitori degli ultimi anni che hanno valicato le Alpi risultano alcuni nomi – Mathias Énard, Pierre Lemaitre, Michel Houellebecq, Jonathan Littell – che inducono a provare a conoscere meglio anche quest’ultima vincitrice, in Italia ancora poco nota.
Brigitte Giraud, classe 1960, è nata nell’Algeria francese, per poi passare gran parte della sua vita a Lione, città dove è ambientato anche Vivi veloce. Il Goncourt l’aveva già vinto nel 2007 per la sua raccolta di racconti L’amore è sopravvalutato(Guanda) in cui undici donne raccontano la fine di un amore. Della sua vita sentimentale dice lei stessa in un’intervista rilasciata a «Marie-Claire»: «Ho vissuto vent’anni con lo stesso uomo, mio marito. È morto in un incidente di moto a 41 anni, nel 1999. Ho scritto un libro, A présent, che parla di questo avvenimento che ha diviso in due la mia vita». Ed è proprio da questo lutto che riparte, a più di vent’anni di distanza, con Vivi veloce: l’anatomia scrupolosa e spietata di una morte, l’autopsia di un lutto. Ogni capitolo serve per sviscerare uno dei tanti “se” che avrebbero potuto impedire alla vicenda di svolgersi, e a questo libro di esistere:
Se non avessi voluto vendere l’appartamento.
Se non mi fossi intestardita a vedere quella casa.
Se mio nonno non si fosse suicidato quando avevamo bisogno di soldi.
Se non ci avessero dato le chiavi di casa in anticipo.
Se mia madre non avesse chiamato mio fratello per dirgli che avevamo un garage.
E così via, moltissimi “se” che avrebbero potuto deviare di un attimo, decisivo, il corso luttuoso degli eventi. La morte di Claude, suo marito, avvenuta nel tiepido e soleggiato 22 giugno del 1999, poteva essere evitata? Una domanda che, per quanto intima, risuona nelle pagine di Giraud come un’interrogazione collettiva. Non solo perché tutti, nella nostra esistenza umana, ci troviamo prima o poi di fronte alla perdita e all’infinita, lacerante varietà di alternative da cui, come da un groviglio di inestricabili determinazioni, abbiamo ricavato quella scelta, quel destino. Ma anche perché l’autrice stessa sembra coinvolgere tutti, come un coro greco, davanti a questa ineluttabilità tragica: ogni nostra scelta, anche la più banale e minima, è imperscrutabile persino a noi stessi. Soprattutto a noi stessi. Mettere gli occhi nel passato, nelle sue più infinitesimali congiunture, è un atto di coraggio e, insieme, una constatazione pubblica d’impotenza: abbiamo ben poco potere sulla nostra vita; siamo ciechi, vediamo il tanto che basta a tirare avanti, e a volte neanche quello. È un’epopea dell’istante che ha già generato opere che hanno condizionato molto l’immaginario del ventunesimo secolo, l’ultima delle quali è probabilmente il pluripremiato Everything Everywhere All at Once (scritto e diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert). La dimensione di Vivi veloce è ovviamente molto più lirica, più minuta, più personale, e allo stesso tempo più profonda, forse più crudele, una piccola parabola universale. Un racconto che, come l’epos classico, si intesse sulle trame del destino, e ha il destino come vero tema centrale e segreto. Scrive Giraud:
Mi ci è voluto tutto questo tempo per capire se la parola destino, sentita pronunciare qua e là, ha un senso. (…) Quando non sopravvengono catastrofi, procediamo senza voltarci indietro, con lo sguardo sulla linea dell’orizzonte, dritto davanti a noi. Quando si verifica una tragedia, torniamo sui nostri passi, ripercorriamo i luoghi, ci dedichiamo alla ricostruzione. Vogliamo comprendere l’origine di ogni gesto, di ogni decisione. Riavvolgiamo il nastro mille volte. Diventiamo professionisti del causa/effetto. Tracciamo, dissecchiamo, sezioniamo. Vogliamo sapere tutto della natura umana, delle molle interiori e collettive che fanno accadere ciò che accade. Sociologhi, poliziotti o scrittori, non sappiamo neanche più cosa siamo, deliriamo, vogliamo capire come si diventa un numero nelle statistiche, una virgola nel grande tutto. Mentre ci credevamo unici e immortali.
La chiusa di questo pensiero di Giraud ci offre l’occasione per aprire una riflessione sul genere letterario che, dallo Strega al Goncourt al Nobel, imperversa apparentemente incontrastato da almeno due decenni: l’autofiction. Ci vuole poco a notare come questa modalità narrativa sia nata e si sia andata via via affermando su una strada parallela a quella dei social network, forse la ragione primaria per cui non ci ha del tutto stancato. Viviamo nell’epoca dell’autorappresentazione, del Super Io – che differentemente da quello di matrice psicanalitica, non controlla, ma bensì lascia liberi: va tutto bene a patto che sia reale, spontaneo – del Super Uomo digitale: se dedico così tanto tempo alla contemplazione della vita di sconosciuti o semisconosciuti perché dovrei mostrare avversione o percepire fastidio nei confronti dell’autofiction che all’autorappresentazione aggiunge perlomeno – o presume di aggiungere – l’ingrediente dell’arte? Sì, d’accordo, è solo la vita di qualcun altro: però è bella, perfetta, stilizzata, e dice qualcosa anche della mia vita per la quale, spesso, la vita dell’altro diviene un modello. Su queste basi, la narrativa aspira al racconto didattico, all’exemplum, alla parabola, appunto.
Il termine “autofiction” coniato da Serge Doubrovsky per definire il suo romanzo Fils nel 1977, ha trovato in Emmanuel Carrère il suo traghettatore sulle riviere del vasto pubblico. Con la sua lingua pulita, il periodare malizioso insieme alla costruzione di uno straordinario antieroe moderno, Carrère ha trasformato l’autofiction in ciò che era destinata ad essere: la forma letteraria del nostro tempo. Non siamo più, come alcuni (non senza un po’ di malafede) suggeriscono, nelle zone di Agostino o di Proust, al centro delle cui opere resta sempre e comunque l’evento del linguaggio. Se è plausibile la mia ipotesi secondo cui sono stati – e sono ancora – i social parte importante dell’incredibile fortuna degli epigoni di Carrère, qual è stato il motore che ha innescato questo movimento? Andrà cercato, ma è solo una mia proposta, marxianamente, nella struttura capitalista, nei suoi ingranaggi di alienazione e individualizzazione: l’io che diventa non più parte di una società, ma epopea autonoma, che nell’espressione artistica cerca continuamente la sua autolegittimazione. Pensiamo, ad esempio, a L’evento di Annie Ernaux: il tema collettivo, sociale e politico dell’aborto viene affrontato dalla prospettiva autobiografica; oppure all’operazione che fa Jonathan Bazzi in Febbre, dove smonta e mette a nudo i falsi miti e i pregiudizi che circondano l’Hiv, anch’esso argomento di assoluto interesse collettivo, prendendo a paradigma la sua esperienza diretta. La mitologia collettiva viene così sostituita dalla mitologia personale. D’altra parte, in un periodo storico in cui il corpo privato diviene oggetto mercificato, allora la storia personale può diventare soggetto politico.
«Le cose che possedevi ora possiedono te», scriveva Palahniuk in Fight Club. In letteratura potremmo dire: le cose che possedevi ora le possiedono gli altri.
In un articolo uscito su Libération Paul B. Preciado ha scritto:
La felicità sta nella capacità di percepire ogni cosa come facente parte di noi stessi, proprietà al contempo di tutti e di nessuno. La felicità sta nella convinzione che essere vivi significhi essere testimoni di un’epoca, sentendosi in questo modo responsabili, in maniera vitale e appassionatamente responsabile, del destino collettivo del pianeta.
Percependo il dilatarsi di una distanza tra l’individuo e la collettività Preciado cerca una possibile via d’uscita verso la “felicità”, e la trova in una forma di “alleanza umana” di leopardiana memoria. Gli scrittori invece hanno spesso risposto a questa esigenza in modo opposto: di fronte alla solitudine, alla fragilità, ai deserti umani e morali generati dal consumismo hanno risposto mettendosi a nudo, con piccoli e continui gridi di aiuto verso un esterno che è sempre pubblico, e mai comunità. Cercando l’autolegittimazione per sentirsi parte di qualcosa: nell’epoca in cui più che mai i nostri amici sono relegati a piccoli nomi dietro uno schermo, a voci che corrono accelerate in un vocale di WhatsApp, abbiamo scoperto la necessità di confidarci, di aprirci, a chiunque sia disposto ad ascoltarci. D’altra parte, il male che percepiamo – quello sì – non può che essere comune. Il luogo della parabola è, quasi sempre, il male, il cui solo sollievo è nella condivisione. Ce lo insegna anche Giraud, che, scandagliando il lutto genera ferite da cui fuoriesce la luminosità della sua vita amorosa: ha perso molto perché aveva molto. La sua memoria offerta al lettore riporta in vita suo marito Claude, che ora è anche una nostra perdita. Il racconto condiviso e affidato alle pagine permette che il vuoto generato dal lutto si colmi e si trasformi in letteratura.
Si arenerà proprio sulle sponde del XXI secolo la nostra capacità di inventare storie iniziata ancor prima di Omero? Personalmente, mi limito ad avere una fiducia totale nella nostra incapacità di indovinare le cose del futuro, che, come dice Eschilo, conosceremo solo quando sarà arrivato. Per ora, prendendo atto del presente, abbiamo Vivi veloce di Brigitte Giraud che ci insegna la perdita e la racconta con grazia; che ancora dopo secoli, proprio come Omero, s’interroga sull’ineluttabilità di un fato rimasto senza volto. Perché, quale che sia la prospettiva con cui si decide di iniziare un racconto, al centro della materia ci sono sempre e solo “le cose degli uomini”.
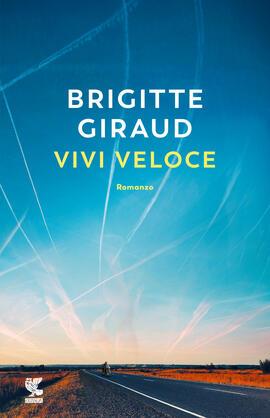
Brigitte Giraud, Vivi veloce, trad. M. Uberti-Bona, Guanda, Milano 2023, 192 pp. 18,00€