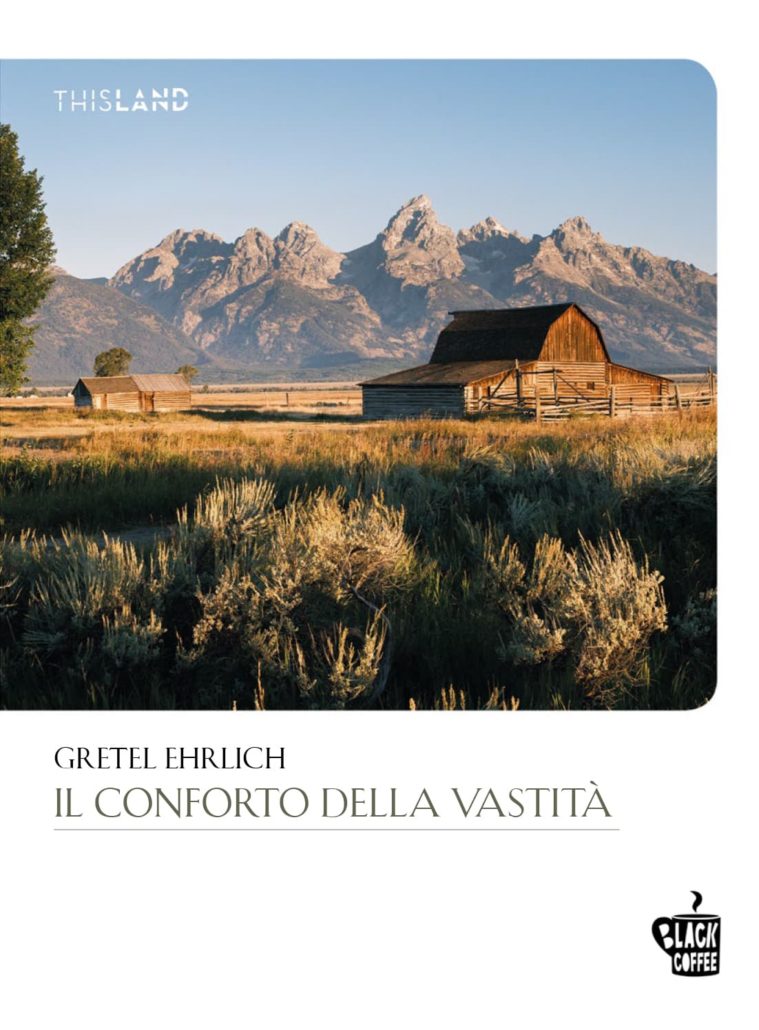L’Ovest americano è un Mona Lisa smile: ti fissa, e parla un po’ di te. Per interpretare il suo sguardo obliquo nessun Baedeker, ma John G. Cawelti e il suo Mistery, Violence, and Popular Culture (Wisconsin University Press. Popular Press, 2004). Allora il calderone di pelli, tremori e sudori attizzato dall’espansione Pacific-ward dei neonati Stati dell’America del Nord si lega all’epica. Ottenuta la conquista, il West diventa un genere, West-ern – appunto, “dell’Ovest” –, che butta quel ponte nell’immaginario comune tra le radici cristiane ed evangeliche dei Pilgrim Fathers e l’etica del lavoro – eau de capitalisme – protestante che seguirà la stabilizzazione della situazione politica nel Nuovo Mondo. Non serve scavare in profondità per ravvisare come i valori della frontiera permangano nella cultura occidentale, e mainstream: individualismo, movimento, competizione. Tutti puntualmente attribuiti all’eroe maschile della vicenda. Questa fissità di valori, questo radicamento profondissimo nella cultura contemporanea, sempre secondo Cawelti, rende il genere uno tra i più, se non il più immutabile dei generi canonizzati. Per convincersi della bontà dell’argomentazione, basterà guardare, per esempio, Ombre rosse (John Ford, 1939), e accorgersi che non si fa fatica a entrare in contatto né con le dinamiche, né con il messaggio della pellicola. Come se avessimo una familiarità naturale con quanto stiamo vedendo. Per un esempio-controparte, lo stesso esperimento potrebbe risultare maggiormente fallimentare nel caso di un film noir di Otto Preminger o John Huston. Ci vorrebbe dell’applicazione, per riconoscerci a primo impatto in una di quelle cose, come si dice.
In questo contesto, aggiunge Cawelti, solo un elemento può dirsi più immutabile dell’immutabile western, ed è il cowboy, uomo di frontiera per eccellenza, prototipo di ogni tipo-umano inquadrato (dalle mie parti lo direbbero testa quadra), rude, e con un perverso senso d’amore iperprotettivo verso le donne a cui si accompagna. D’altronde, che cosa sarebbe il western senza i cowboy? Una storia di monotone fattorie, o di riconquiste indigene di territori espropriati. Qualcosa di molto più simile alla vita vera. Ma forse, come spesso accade, non è questo il punto.
Il punto comincia a rivelarsi all’apertura delle prime pagine de Il conforto della vastità di Gretel Ehrlich, portato quest’anno in Italia da Black Coffee nella sua più recente collana, This Land, e nella traduzione di Sara Reggiani. Non il grande romanzo sull’Ovest americano, più nello specifico, del Wyoming, ché poi c’è Ovest e Ovest, bensì un memoir con la stoffa di un reportage di viaggio. Ehrlich nasce in California, nel 1946, e si trasferisce nello Stato-rettangolo nel 1978, poco dopo la prematura morte del compagno. Quello che Ehrlich ricercava, la purificazione del cuore; quello che ha trovato, una casa, e i cowboy, di quelli veri: «Quel mondo arido rappresentava un nuovo inizio. La sua totale indifferenza mi ancorava a terra.»
Presto, però, Ehrlich in quel mondo arido affonda le mani, ne impasta la carne, e accetta la sfida dell’osservarlo in tutte le sue sfaccettature. Dal bivacco al badare alle gravidanze delle mandrie, dagli sguardi sospettosi dei locali alle notti d’inverno passate al pascolo, la pelle crepata sotto la spinta del freddo. Parrebbero scene di un film già visto. Invece, no. Perché tra pendii, ruzzolare di rocce, vento, distese erbose e ripide scarpate, l’occhio di Ehrlich svicola, e si fissa alla ricerca di tutte le versioni di quel sorriso enigmatico, timido Ovest che si para dietro la sua stessa espressione. Il conforto della vastità è un libro estremamente divertente, che provoca sorrisi affettuosi, e gonfia gli occhi di emozione per il riconoscimento, innanzitutto, di una diversità, insondabile, e che giace al fondo dell’anima degli abitanti del posto, anzi, nello specifico, dei cowboy, uomini o donne siano. Essere cowboy, pare dirci Ehrlich, è un fatto dell’anima, ancestrale contatto con la terra e morale interiorizzata. Scoppia all’esterno con una certa difficoltà a parlare se non per figure. In fondo, il linguaggio denotativo non serve, quando la natura si dispiega con la potenza del Wyoming. Una giusta connotazione è, al contrario, ottimo legante per la comunità. Anche quando si tratta di dare degli imbecilli ai forestieri e costruire schietti paragoni sul livello di intelligenza del miglior cavallo che si ha nella stalla e i nuovi arrivati.
Una natura potente sa però plasmare i suoi abitanti in modi persino più accentuati. Dice Ehrlich, gli anni del Wyoming sono quelli in cui è stata più sola. A livello fisico, certo, essendosi scelta la via del ranch e dei bivacchi. Ma anche a livello morale. La prima necessità è, infatti, che il sistema si regga. E per reggersi deve tollerare l’infrangersi temporaneo dei suoi stessi valori, primo fra tutti proprio quella rigida identità di maschio alpha canonicamente appioppata al cowboy, oppure la granitica divisione per sesso dei compiti, e degli atteggiamenti e dei comportamenti sociali. «Il rancher come il cowboy è di norma considerato un macho – di poche parole, bevitore, imperscrutabile – ma la verità è che non esiste figura al mondo che bilanci in maniera altrettanto naturale la parte femminile e quella maschile, la grazia e la virilità rude e vigoroso nell’aspetto, il mandriano è androgino dentro.» Non c’è Ovest, pare dirci Ehrlich, senza cura. E qualora questa percepita androginia sfociasse in comportamenti sessuali non precipuamente attinenti ai dettami della cultura che ha il cowboy come simbolo del maschio per eccellenza – oh, be’. Basta saperlo.
Questo punto meriterebbe una replica da parte di D.A. Miller, il quale, in un’analisi de I segreti di Brokeback Mountain di Ang Lee (2005) – in Bellissimo. Un’analisi dei Segreti di Brokeback Mountain e di Chiamami col tuo nome, nottetempo, 2022 –, pone proprio questa conoscenza passiva della “devianza” da parte della società alla base del “perbenismo progressista” colpevole di queerwashing. Nello specifico, la sua lettura del film rintraccia un punto di vista e di narrazione scisso, lambente a turno tutti gli attori sociali che osservano, e deplorano, la passione omoerotica innescatasi tra i due mandriani protagonisti, Ennis Del Mar (Heath Ledger) e Jack Twist (Jake Gyllenhaal). I due lo sanno, ed è per questo, secondo Miller, che non vediamo la storia raccontata da uno dei loro punti di vista. Perché la vicenda – SPOILER – finirà male, il “gay contrito e sottomesso” avrà la sua ennesima apparizione nell’intrattenimento per le masse, e la morale dominante ne uscirà con una bella lucidata.
Simile, ma in un certo senso complementare, ragionamento potrebbe condursi per The Power of the Dog di Jane Campion (2021), adattamento dell’omonimo romanzo di Thomas Savage e premiato con l’Oscar alla Miglior Regia nel 2022. La vicenda ha per protagonista Phil Burbank (Benedict Cumberbatch), apparentemente coincidente con lo stereotipo culturale del cowboy che abbiamo menzionato. L’entrata in scena di una nuova moglie (la vedova Rose Gordon, interpretata da Kirsten Dunst) e del di lei figlio (Peter, interpretato da Kodi Smit-McPhee) per il fratello George (Jesse Plemons), con cui gestisce un ranch, creeranno una crepa sempre più evidente nella sua facciata di marmo, rivelando un’autocensura interna della propria sessualità queer, attitudine che Paolo Pedote individua come omofobia interiorizzata, ovvero paura e disprezzo per se stessi, nel suo saggio Per una genealogia dell’omofobia, in We Will Survive! Storia del movimento LGBTQI+ in Italia (Mimesis Edizioni, 2020; a cura di Paolo Pedote e Nicoletta Poidimani). Se non fosse che il racconto devia sul finale, togliendo il velo alle nostre stesse aspettative di veder sbocciare anche per Phil una bromance sullo stile di Brokeback Mountain. E allora ci frega, e dobbiamo vederlo una seconda volta. Ma insomma, anche qui, avere un cowboy con una tender side sembra essere il motore per una storia. Quasi un tabù: dei sentimenti del cowboy non è da parlare.
Credo che Miller apprezzerebbe lo sguardo diegetico con cui Ehrlich abita la terra che calpesta, apprezzerebbe il superamento a priori della dicotomia di genere sociale nel West portando sulla pagina donne nerborute e cowboy gentilissimi. Questa, e la soffusa tristezza che aleggia sulle pagine, sono delle ottime motivazioni per tornare, ogniqualvolta lo spirito ne avverta il bisogno, alle parole ristoratrici de Il conforto della vastità. Perché chiunque, amante del western o meno, avrà una casa ad aspettarla. Basterà aprire le orecchie, ascoltare bene. Per me, che sono creatura d’Appenino, leggere Ehrlich è stato tornare al mutismo con cui i nonni contadini riempivano le stanze, allo sguardo scocciato con cui scrutavano i picchi di quella loro terra astuta, sospirando: «E tu, cosa saresti dietro a fare?», che è sempre una bella domanda da farsi al cospetto dell’infinito. Per chi, invece, viene magari di pianura, o ha la fortuna di aver conosciuto il mare, la raccomandazione è comunque la medesima: leggere Il conforto della vastità, spostare la frontiera sempre un pelo più in là, così che ci sia spazio per la meraviglia, il sibilo del vento.
Gretel Ehrlich, Il conforto della vastità (trad. Sara Reggiani), Edizioni Black Coffee, 2022, pp.160, € 16.