Stai per andare a cena con tua moglie e tuo figlio. A casa ti aspetta un cane cui hai dato il nome di Fred Flinstones, e due gatti: Epaminonda e Kociss. Tua moglie Barbara, vegana, e tuo figlio Tommaso, sensibile fino al cervellotico, sono entrati per primi al ristorante; tu sei in ritardo, sull’uscio. Ti chiami Davide, fai il neurochirurgo. Un uomo insidia tua moglie, la minaccia: tu guardi. Qualcuno in vece tua accorre. Qualcuno più abile nel convogliare in sé tutta la violenza possibile. Qualcuno come un maestro zen. Tu sei costretto a riconsiderare le tue teorie sulla violenza, e di conseguenza le tue prassi. Sei, per di più, il protagonista del nuovo romanzo di Fabio Bacà, Nova, edito da Adelphi a ottobre di quest’anno.
C’è sempre nei lavori di Bacà, a cominciare da quel Benevolenza Cosmica pubblicato del tutto inaspettatamente da Adelphi nel 2019, una solida relazione tra l’Evento e l’esistenza individuale. L’Evento è quella rottura (rupture, per servirsi del termine impiegato da Michel Foucault che tante opere ha dedicato alla questione) dell’ordine cosmico che viene a dare nuova consistenza (e dunque nuovo significato) ai modelli traverso cui si conduce la vita.
Dove la figura principale di Benevolenza Cosmica si ritrovava impelagata (forse) in un complotto a proprio gaudio, quella di Nova è invischiata in una rupture ben più quotidiana. Il perturbante si insidia nella quieta biografia di Davide per diventarne sovrano.
Il primo romanzo di Bacà era investito di uno stile brillante, dove non di vero e proprio umorismo. Ricordava in questo le commedia marxiane (dei fratelli Marx) o quelle di Woody Allen. Ma tale umorismo era generato in una frizione tra gli eventi e il contraccolpo subito dal protagonista. In Nova la medesima frizione produce un secondo tipo di effetti: brillanti dal punto di vista dialogico e di alcune situazioni, tragici da quello della loro sublimazione. Il ruolo esercitato dalla Storia nelle opere di Bacà risponde a questo principio di sgomento del soggetto. Da essa non ci si redime: in modo più dimesso, ne si accoglie la tragicità, a volte con sardonico cinismo (Benevolenza), altre con risentimento (Nova).
Abbiamo discusso con l’autore dell’opera e dei suoi temi.
Quando fu edito Benevolenza Cosmica (Adelphi, 2019), il tuo primo romanzo, un gran sgomento avvinse l’industria culturale: Adelphi, casa editrice di culto, pubblicava un perfetto esordiente narrativo a ventisei anni da La variante di Lunenburg di Paolo Maurensig. Hai condiviso in molte occasioni come alcuni tuoi lavori precedenti non siano stati accolti nel novero delle opere pubblicabili. Sentivi di essere uno scrittore cui per qualche ragione – metafisica o materialistica che fosse – non davano abbastanza credito?
Quello che posso risponderti è come mi sentivo io in quel periodo: estremamente depresso. Il mio primo romanzo è stato non solo rifiutato, ma non ha neanche visto la luce. Ho scritto Benevolenza Cosmica (Adelphi, 2019) come tentativo estremo di entrare nel mondo editoriale con un romanzo che mi sembrava più leggero. Anche Benevolenza Cosmica all’inizio è stato rifiutato. È questione di quali sono le mani che leggono… gli occhi che leggono il tuo romanzo. Ti dico questa cosa. Alla fine del 2016, dopo circa un anno che facevo girare Benevolenza Cosmica, mi ricordo che telefonai alla mia compagna – in quel periodo non vivevamo insieme – e le dissi: “sono finalmente giunto alla pacificazione, non voglio più fare lo scrittore. Ho capito che il mondo editoriale non mi vuole”. Ed ero relativamente in pace. Non ero felicissimo, ma ero in pace. Senonché mi viene a trovare qualche settimana dopo una mia cugina che fa la scrittrice, Giorgia Tribuiani, e mi dice: «be’, sono anni che vuoi fare lo scrittore – da quando sei giovane, da quando sei piccolo. Ti arrendi così?». «Sono anni che mando in giro i miei due romanzi e non mi si fila nessuno, non c’è bisogno di un aruspicio per leggere i segni». «Facciamo così» mi disse lei, «facciamo che lo faccio leggere a Giulio Mozzi». Giulio Mozzi rimase colpito. Cominciai la sua bottega di narrazione, poi la abbandonai. Fu una cosa importante: quella fu veramente l’epifania. C’era una persona che quel romanzo lo apprezzava. Allora se ce n’era uno, per di più esperto, poteva essercene anche un secondo. Ho ricominciato a farlo girare, ho aspettato un anno buono e poi è arrivato nelle mani di un’agente letteraria molto capace e da lì è cominciata questa avventura. C’è stato un momento in cui io non avevo toccato il fondo: avevo scavato.
Il protagonista di Benevolenza cosmica è un uomo a cui va tutto bene. Il protagonista di Nova è un neurochirurgo costretto a rivedere le sue posizioni sulla violenza. Lavori anzitutto sull’idea o sul personaggio?
Per me viene sempre prima l’idea; la consapevolezza che sono successi uno o più fatti, spesso nella mia vita. Per Nova c’è stata una serie di circostanze che mi ha portato a riflettere sulla violenza. Io sono un tipo mite quanto il mio protagonista, però in un paio di occasioni mi sono chiesto se non fosse il caso di risolvere le cose in maniera più sbrigativa. Per me parte sempre prima lo spunto, non c’è mai una morale di fondo che voglio sviluppare tipo: voglio parlare della violenza, voglio parlare di sesso e morte, voglio parlare della fortuna. Sarei incapace di scrivere un romanzo in questa maniera. Come vanno avanti i miei romanzi? Vanno avanti mettendo uno o più tizi in una situazione che reputo problematica; dopodiché cerco di rendere quella situazione più problematica possibile. Quindi non c’è nessun altro tipo di connotato morale, nessuna aspirazione filosofica. La mia prima preoccupazione è scrivere un romanzo interessante: qualcosa che tenga incollato il lettore. Non credo ai romanzi che hanno altre aspirazioni. Dopodiché è evidente che essendo io un essere umano dotato di pulsioni, sentimenti, emozioni, un bagaglio di lettura discreto – ma nemmeno eccezionale, non pensare che abbia letto chissà quanto: ma so leggere – è evidente che tutto quello che ho assimilato in questi anni, le cose che mi interessano di più le metto lì sopra e non devono essere necessariamente pertinenti al tema del romanzo. In Nova si parla di violenza, ma si parla anche di veganesimo, si parla anche di una cotta adolescenziale, si parla anche di zen, si parla di musica classica, che può essere anche un accenno. Se la cosa ritengo sia propedeutica a una visione d’insieme interessante, allora la inserisco: tutto qui. Se c’è una cosa che non amo – per mio gusto, poi ci saranno altre migliaia di scrittori e migliaia di lettori che lo apprezzano – è un romanzo che parla di un solo tema, massimo due e fondamentalmente si va su quel binario fino alla fine. Non fa parte di me, non sono cresciuto così. I miei numi tutelari – Don DeLillo, Martin Amis, David Foster Wallace, ce ne sono tanti – non mi hanno cresciuto così come scrittore.
Si potrebbero riscontrare due canoni nel romanzo italiano. Uno più cittadino, proposto da scrittori formati geograficamente nelle grandi città (l’ultimo potrebbe essere Gli Iperborei di Pietro Castellitto) e uno più provinciale, spesso in dialetto (mi riferisco, per esempio, a Arruina di Francesco Iannone o Sangue di Giuda di Graziano Gala), in cui si dispiega tutto un capitale di minorità e controstoria. Tu sei uno scrittore abruzzese, ma preferisci una letteratura – per così dire – cittadina. Benevolenza cosmica è ambientato a Londra, Nova a Lucca. Perché questa decisione?
Ci sono due motivi. Il primo è che vivo in un paese di provincia, ma non abbastanza caratteristico – come per esempio la mia bravissima corregionale Donatella di Pietrantonio, che abita nel cuore dell’Abruzzo. Il mio paese, Alba Adriatica, è sul mare, quindi la maggior parte dei miei amici anche da bambino era milanese, torinese… Inoltre, Alba Adriatica è una città di confine: sto vicino a San Benedetto del Tronto, appunto, a dieci chilometri dal confine con le Marche. Io delle radici abruzzesi conosco pochissimo. I miei genitori sono relativamente acculturati, il dialetto si parla poco in famiglia. Di che potevo scrivere, io, rispetto a quello di cui scrivevano molto meglio di me Donatella di Pietrantonio, Remo Rapino e tanti altri scrittori legati un po’ più al territorio?
Secondo motivo, un po’ più strumentale. Il mio linguaggio è abbastanza forbito. Mio padre quando giocavo a pallone mi chiamava “l’esteta”, perché ero un po’ barocco persino in quel caso. Evidentemente questa cosa mi è rimasta: la fissazione per la tecnica. Mi piace quando i calciatori sono molto tecnici. Ho iniziato a suonare la chitarra un po’ di anni fa ma ho smesso subito perché ho capito che non sarei mai addivenuto a quella tecnica che sognavo – nonostante la chitarra mi piaccia moltissimo. Se vuoi parlare bene e vuoi fare dialoghi di un certo spessore culturale devi inserire all’interno della narrazione gente che ha studiato: uno statistico, un neurochirurgo, una scrittrice, una logopedista. Nel primo romanzo, quello inedito, il protagonista era uno scrittore che parlava in maniera quasi barocca. Questo è un limite. Mi dovrei veramente sforzare per parlare di Lumpens o di ubriaconi. Non riuscirei mai a scrivere un romanzo in dialetto.
Secondo questa teoria sarà stato difficile far parlare gli adolescenti.
Far parlare gli adolescenti è stata anche una bella pausa. Qualcuno mi ha rimproverato che gli adolescenti sono troppo intelligenti in Nova. La mia amica Alice Cappagli (il cui ultimo romanzo Ricordati di Bach, 2020, è edito da Einaudi) mi ha telefonato per dirmi: «guarda che Tommaso, per avere sedici anni, non può fare dei ragionamenti così intelligenti». Io ho alzato le spalle. A sedici anni io mi sentivo estremamente sensibile. Quindi ragionamenti complicati sulla natura delle cose me li facevo, mi sembra di ricordare. Dover facilitare è stato anche un momento di pausa. Non è che uno può stare sempre con l’acceleratore a tavoletta per cercare di scrivere dialoghi particolarmente intelligenti. Il dialogo nella parte in cui loro sono al concerto, quello è stato anche uno spasso.
I tuoi romanzi sembrano delle grandi sceneggiature dentro cui sono insufflate topiche narrative. Qual è il tuo rapporto con il cinema e più in generale con la narrativa di genere?
Amo il cinema, così come vengo da una letteratura di genere. Nella letteratura di genere c’è poco tempo per la riflessione o le speculazioni filosofiche. Lì si deve trottare per trovare subito delle soluzioni argute a dei problemi contingenti dei personaggi, quindi sotto questo punto di vista sono una grande palestra. È difficile leggere così tanto materiale di genere senza venirne poi influenzati successivamente. I grandi scrittori che non hanno mai letto queste cose, qualcosa si sono persi. Non credo si recuperi più. Quel gusto per l’azione, per strappare il sonno al lettore per andare a vedere cosa succede… conosci la famosa frase di Umberto Eco – non so se apocrifa o autentica – in cui si dice: «potrei leggere Omero, La Bibbia e Dylan Dog per giorni e giorni»? Questa frase era a esergo a un volume di Dylan Dog. Io ricordo che a diciotto anni leggevo il Nome della rosa – leggevo di sera e in certi casi preferivo la lettura al film serale – e non riuscivo a smettere di leggere. Dicevo: «oddio, ma è l’una di notte, domani devo andare a scuola». Questo è il grande segreto: e quello era Umberto Eco! Un testo che parlava di filosofia medievale, di francescanesimo… e era anche un giallo. Lui aveva capito qual è il meccanismo: il romanzo ha venduto molto non tanto per la filosofia medievale, ma perché era appassionantissimo.
Nova è infatti anche una sorta di thriller.
In questo paese è facile mettere un’etichetta addosso a chiunque. Io voglio farmi mettere addosso meno etichette possibili. Non per spocchia o per snobismo. Non c’è niente di male a essere autore di libri gialli o di horror o scrivere soprattutto romanzi rosa. Però secondo me dopo Benevolenza cosmica si era cominciato a spargere la voce che io fossi uno scrittore umoristico. A quel punto avevo già cominciato a scrivere Nova. Quando ci sono state le prime reazioni a Benevolenza cosmica io avevo già quasi finito la prima stesura del romanzo. Devo dire che quando hanno cominciato a definirmi scrittore umoristico ho pensato che non era male aver completamente invertito la rotta; mi sarei scrollato subito di dosso un’etichetta piacevole ma molto irritante.
Per Benevolenza cosmica non mi sono reso conto di aver scritto un romanzo umoristico fino a quando la mia agente non mi ha detto che si era divertita molto a leggerlo. E io ho pensato: «scusa, ma in che senso?».
In Benevolenza cosmica si insiste su una certa idea di violenza. Nella Londra obliqua in cui il romanzo è ambientato, gli integralisti compiono attentati stando ben attenti a ottenere il minor numero possibile di morti. È questa la teoria del Capro Espiatorio presentata da Renè Girard (anch’egli pubblicato da Adelphi) e sublimata da Roberto Calasso (fondatore, proprietario e direttore editoriale di Adelphi sino alla sua scomparsa, avvenuta a luglio di quest’anno) nel saggio dedicato all’epoca contemporanea L’innominabile attuale (Adelphi, 2017). In Nova l’idea di violenza sembra invece tanto meno simbolica quanto privata. Com’è cambiata la tua idea di violenza nel corso degli anni?
Alla fine tutto serve al fine ultimo della narrazione. La narrazione vuole che io parta da un certo protagonista, lo metta nei guai e poi lo faccia uscire. In Benevolenza cosmica quell’accenno al terrorismo serviva a dare una coloritura di instabilità e follia che ricalcava, rispecchiava, accompagnava il momento di incertezza totale del protagonista. Io ho scritto questo romanzo sotto depressione. Quando una persona è depressa non ha più punti di riferimento. Sì: avevo una compagna amorevole, una famiglia, però avevo perso il lavoro, non stavo bene fisicamente, il mondo mi sembrava quella gabbia di matti che forse effettivamente è: ed ecco allora l’idea di terroristi che facevano quasi il contrario di quello che farebbe un terrorista, cioè fare meno vittime possibile. In Nova c’è il microcosmo del mio protagonista che viene messo a dura prova da fatti circostanziati. Sentivo di aver bisogno di cose meno vaghe. Io non mi sento uno scrittore politico. Uno dei riferimenti maggiori di questo romanzo è Fight Club di Palahniuk. Ma Chuck Palahniuk o quantomeno Fight Club è un romanzo politico. A me non interessa cambiare il mondo. Intendevo semplicemente mostrare cosa può accadere a un uomo quando gli succedono troppe cose che sono contrarie all’estetica che si è creato.
In molte interviste hai segnalato come in Nova pretendevi personificare una dialettica: la macchina perfetta del cervello e la «volgare sbrigatività» (si legge nel romanzo) della violenza. Questa dialettica non sembra tuttavia ben rispettata: si palesano nel corso dell’opera ben più di due prassi, dall’anomalia mentale agli eventi traumatici di marca freudiana. Si tratta di una decisione ponderata?
Mentre scrivevo Nova mi chiedevo: non è che i lettori crederanno che io stia facendo un’apologia della violenza? L’altro giorno ho fatto un’intervista su Fahrenheit. Tra le domande del pubblico, un lettore mi ha detto: «ma allora tu propugni la giustizia fai da te?». Io stavo per rispondere, quando Lipperini ha risposto al posto mio: «non facciamo coincidere il pensiero del protagonista con quello che dice l’autore». Sai bene cosa ha passato Bret Easton Ellis dopo American Psycho. Lo scrittore può scrivere di qualsiasi cosa, a meno che non faccia l’apologia di qualcosa di cui è illegale fare apologia, come nel caso del fascismo. A un certo punto faccio dei riferimenti quasi filosofici alla violenza e ne parlo come connaturata all’esistenza stessa non solo dell’uomo, non solo degli animali, ma anche dell’Universo. L’Universo è nato per lo scatenarsi di gigantesche forze elettromagnetiche su un nucleo originario: quella è violenza. Gesù Cristo l’hanno crocifisso: ci ha salvato – per chi ci crede – con un atto di violenza. La violenza è in tutto. È ovvio che la violenza che salta più all’occhio è quella fisica che l’uomo fa al suo simile. Se avessi scritto un romanzo sulla violenza animale – che so: il Grizzly che uccide le sue prede – non sarebbe interessato a molti. La violenza è una cosa estremamente brutta e spiacevole nella verità, ma estremamente seducente della fiction. Quale film non ha un momento di violenza? Che può essere fisica, verbale, di scontro tra due persone che si vogliono bene. Non volevo parlare di conflittualità politica, perché io non mi sento uno scrittore politico. Mi interessava quella più brutale, quella di cui siamo capaci tutti. Il bambino di sette anni può tranquillamente strozzare un fratellino; l’adulto può indurre qualcuno al suicidio soltanto parlandoci. Quella è la cosa che contrasta di più con lo strumento meraviglioso che ci portiamo appresso: il cervello.
Davide, il mite protagonista di Nova, incontra un maestro, Diego. Si potrebbe definirlo un katéchon su gambe: qualcuno che convoglia a sé tutta la morale del risentimento possibile e, attraverso un freno, le permette di licenziarsi con più oculatezza. Qual è il ruolo di Diego nel romanzo?
Prima ancora che tutti i romanzi fossero nella mia testa avevo cominciato a studiare e a leggere alcune filosofie orientali. Ho seguito per tanti anni la religione taoista, una religione particolarmente orientata alle cose pratiche. Poi mi sono avvicinato alla meditazione trascendentale, poi alla meditazione zen. Quando ho iniziato a studiare per questo romanzo ho letto molti libri zen. Di questi libri ho trasposto l’uno per centomila. Avrei voluto parlare molto di più dello zen, ma non era funzionale alla struttura della narrazione. Questo è un tipo di società cui tutti aneliamo un maestro. Persino chi va a fare yoga ci fa un po’ per stare in forma, un po’ perché ritiene che facendo yoga possa addivenire a una forma di saggezza trascendente o comunque superiore a quella normale. Posso parlare per me: io ho cominciato a fare zen perché ritenevo che l’educazione – e non parlo solo dell’educazione di competenze ma anche di educazione emozionale o sentimentale dei miei genitori, la scuola, i miei amici, la mia compagna – non fosse più sufficiente a rispondere a certe domande. Sì: l’esigenza di ritrovare un maestro è fortemente incestata in questi tempi cupi. Ma i tempi sono cupi da quando esiste l’uomo. Una golden age non c’è stata mai, a meno che non vogliamo fingere che gli anni Sessanta fossero spensierati… spensierati de che? C’era la guerra fredda, conflitti striscianti che avrebbero portato al Sessantotto. Diego ha una funzione narrativa. È un catalizzatore. Le cose che succedono a Davide sono chiare: ha un superiore che sta uscendo di cotenna, ha un vicino di casa pazzoide, ha una moglie molestata da un tizio che gli spiattella in faccia la sua viltà, ma non è sufficiente. Ci vuole un catalizzatore. Quel catalizzatore dev’essere una persona estremamente carismatica. Mi è venuto in mente Diego, la sintesi di tanti e tanti personaggi di estremo carisma che hanno reso divertenti le nostre ore di spettatori televisivi o cinematografici o le nostre ore di lettori. Un po’ Tyler Durden, ma tante altre cose – talmente tante che non potrei nemmeno dirti quante. Non so bene a chi somigli Diego, forse sono riuscito a dargli un identikit abbastanza originale.
Sarebbe stato diverso se Diego, invece che un maestro tutto sommato individualista, fosse stato quello che negli anni Settanta si definiva cattivo maestro? Una figura il cui utilizzo della violenza era in qualche modo legittimato da una solida tradizione politico-filosofica?
Guarda, non so cosa sarebbe successo, ma non sarei stato in grado di scriverlo. Ci sono dei temi, delle storie che ci interessano fino a un certo punto. Io ho letto pochissima letteratura dichiaratamente politica. Non sto dicendo non mi interessi la storia contemporanea, per carità. Ma non sono capace di scrivere cose di genere. Ciò che mi interessa di più è indagare quello che succede a un singolo uomo. In Nova c’è una scena di massa, una scena di follia, panico. Però è un momento estemporaneo, anche questo mi serve per inserire le reazioni di tutti i personaggi in una contingenza totalmente imprevedibile. Però non mi interessa nient’altro: non mi interessa indagare le dinamiche di popoli, di società… se non come accenno. Non so se conosci la distinzione tra teoria New Age e teoria Next Age. La prima dice che il cambiamento è la società anni Sessanta, la Comune, gli Hippy. Poi, visto il clamoroso fallimento, arriva la consapevolezza, più o meno attendibile, che il cambiamento è personale. La rivoluzione è individuale. Inutile andare a creare Comuni o Ashram che seguono il guru ma – stante il fatto che una guida ci vuole – ognuno deve trovare un maestro dentro di sé. Ecco, questo è: sono più interessato all’aspetto Next Age.
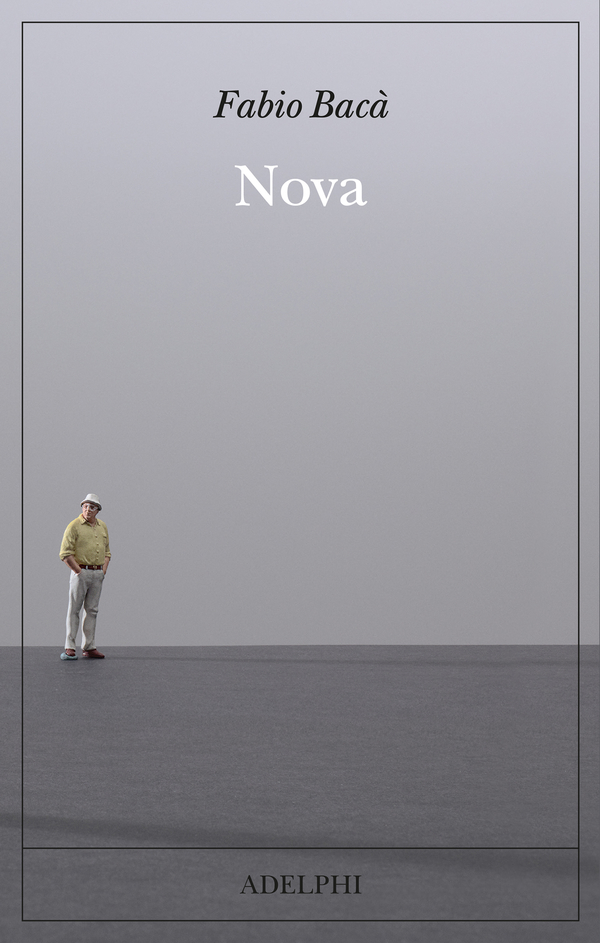
Fabio Bacà, Nova, Adelphi 2021, 279 pp., 19 euro