Pubblichiamo la prefazione di Davide Castiglione all’ultimo libro di versi di Carlo Gregorio Bellinvia, Omissis. Martedì 16 novembre alle 18:30 l’autore presenterà online il libro, insieme e Davide Castiglione e Lorenzo Cardilli. Qui la pagina Facebook dell’evento, con il link per partecipare all’incontro.
Omissis è un’opera che come poche altre nel panorama poetico recente si confronta – e ci fa confrontare – con il trauma, con la violenza, con il senso di colpa del sopravvissuto, con l’impossibilità quasi ontologica, fondativa, di partecipare al commercio del mondo: di essere compreso e di comprendere. Lo fa senza mai apertamente tematizzare queste regioni dell’esistenza, senza sussumerle in un’etica o in un sistema assiologico, perché questo significherebbe già capirle, addomesticarle: trasformarle in contenuto sopprimendole in quanto evento. Al contrario: la violenza viene rappresentata ‘da dentro’, nel suo compiersi, con una naturalezza perturbante. Si prendano i versi incipitari di uno dei vertici del libro, Orsa, diciannovesimo testo della terza e ultima sezione Trenta mandate di chiave:
Forse l’agnello,
mentre lo sforma la bocca
dell’orsa, avverte in un attimo
la pecora che più non sarà,
e forse l’orsa
già sente di ritornare
all’identica orsa
di pochi istanti prima,
così simile al peluche
Sconcerta, in questo testo, la capacità dell’io di incarnarsi a un tempo nella vittima e nel carnefice, suscitando pathos per entrambi pur nella spietatezza della cornice: l’atto elementare del cibarsi, mostrato con crudezza espressionistica («lo sforma la bocca») e ampliato in una vera e propria fagocitazione del forte nei confronti del debole, offre la sponda per un esperimento mentale circa le conseguenze dell’atto sull’identità di entrambe le parti. La disparità non potrebbe essere più atroce: l’agnello, vittima sacrificale archetipica, avverte nell’attimo estremo l’impossibilità della realizzazione adulta di sé, in un annichilimento tanto fisico quanto psichico. Per l’orsa, invece, il pasto è appena uno stato transitorio che non ne altera e a maggior ragione non ne annienta l’identità: essa non sarà in minima parte cambiata dalla violenza che esercita come per coazione, tornando alla sé di poco prima – come iconicamente suggerito dalla ripetizione in epifora di «orsa». L’orsa è istinto puro, infantilismo («così simile al peluche») che si appropria del mondo mediante la bocca, fermandosi al primo grado di sviluppo – quello della fase orale teorizzata da Freud.
Va sottolineato che questa scena allegorica, che ha la forza della parabola, non viene disinnescata in una condanna esterna, antropocentrica, con i portati di amarezza e denuncia che questa comporterebbe. Torna in mente la bambina che schiaccia la mantide in Fortini (Memoria III), con la differenza cruciale che in Fortini resta una speranza di risarcimento in chiave futura (la mantide, nel momento della morte, preserva «i coltelli delle zampe» che «recidevano | aria») che a Bellinvia è negata. Non solo negata: essa sembra risultare perfino inconcepibile, come senza prospettiva e senza finalità appare il presente della generazione alla quale Bellinvia e l’estensore di questa prefazione appartengono. Non c’è consolazione né riscatto; resta la scena come segno che potrà tradursi, nel migliore dei casi, in aumento di consapevolezza e capacità di ascolto – a patto di saper vincere quelle resistenze interne che normalmente ci impediscono di adottare la doppia prospettiva di vittima e carnefice inscritta nel testo.
Un’altra poesia che molto esplicitamente assume su di sé la dialettica fra annientamento e sopravvivenza è Articolo, dove Benjamin, l’ultimo esemplare di tigre della Tasmania (di cui ci resta un breve video d’archivio datato 1935), fu «messa in gabbia», dove «seminava a vuoto», per morire infine «a trenta chili». L’io poetico e biografico, realmente reduce da traumi esasperati da lunghissime degenze («guarito || un decennio dopo || dai miei polmoni»; sulla degenza, si veda anche la micidiale Sarco-), da una parte identifica la propria vicenda con quella della tigre ingabbiata e lasciata morire; dall’altra, tuttavia, riconosce con forte senso di colpa la disparità nell’esito dei rispettivi destini («la fortuna || ha salvato un impostore»: il senso di colpa dei sopravvissuti; e in Corsa si legge che «il vincente | è colpevole come tutti»). Non è un piano potenzialmente intelligibile a decidere delle vite, ma «la fortuna» dalla quale non è possibile difendersi: anche etimologicamente, il caso ci cade addosso. Caso è anche il titolo di un’altra poesia, dove al folle volo dell’Ulisse dantesco in epigrafe si sostituisce il prosaico movimento del padre-babbo Natale, che «da babbo || natale a caso ritirò gli stendini»: nessun immaginifico volo può ovviamente realizzarsi (l’ironia del riferimento pubblicitario «Red Bull ti bette le ali» è quindi molto pertinente); in luogo dell’ardore e dell’esplorazione dell’ignoto, il figlio impara «il peso | dei regali e dei sogni» (corsivo mio). Lasciato solo, l’io si perde, assume la controfigura del «pardo» che «è stato smarrito» (Pardo) – si noti l’uso della forma passiva, che se da un lato è giustificata dalla mimesi della titolistica dei giornali, dall’altro esaspera la mancanza di agenza e volizione del soggetto, ridotto piuttosto a oggetto in balia degli eventi.
Questo senso di colpa rende l’io biografico letteralmente sacro nell’accezione codificata dal grammatico romano Sesto Pompeo Festo, citato in epigrafe alla sezione Trenta mandate di chiave: «Uomo sacro è colui che il popolo ha giudicato per un delitto». In Bellinvia è come se l’ingombro della colpa proiettasse, retroattivamente, un delitto mai compiuto. Questo lo rende particolarmente esposto e vulnerabile al mondo: secondo la legge tribunizia romana infatti, «se qualcuno ucciderà colui che per plebiscito è sacro, non sarà considerato omicida». Il sacro è dunque il paria, il tagliato fuori dal consorzio umano e sociale, colui che può essere impunemente ucciso. Il nodo etico, politico, e sociale che si dirama a partire dal concetto di sacro è stato, come si sa, interrogato da Agamben in Homo Sacer; ma nessun poeta degno di questo nome può cavarsela semplicemente ereditando una densità di concetti elaborati altrove. Il poeta, pur nutrendosi dei saperi odierni e passati, non è infatti sorretto che dalla forza della propria visione e delle proprie costruzioni verbali. Nelle parole ancora attuali di Norhtrop Frye, che valgono anche come monito contro le tendenze extratestuali e culturaliste della critica, oggi largamente maggioritarie: «il primo obiettivo di un poeta è quello di produrre un’opera d’arte, e pertanto la sua intenzione può essere espressa solo mediante una sorta di tautologia»[1] (trad. mia).
Come sono fatte, dunque, le poesie di questo libro? La matrice autobiografica (e traumatica) dell’ispirazione di Bellinvia e l’inadattabilità del soggetto alla società hanno alcune conseguenze formali importanti. Sul piano della lingua, continuano a valere le considerazioni che facevo in altra sede su alcuni testi ora confluiti in questo libro (Scolaro, Scacco, Nome). Scrivevo di uno «straniamento figurale e tonale che non è effetto strategicamente localizzato quanto materia sostanziale della voce narrativa, qualità intrinseca della sua visione»[2]. Componente centrale di tale straniamento è una fortissima sensibilità analogica: per esempio, in CR7, poemetto dedicato al fuoriclasse portoghese e dai versi sfuggenti come un dribbling ubriacante, le «ruspe nette» (si noti per inciso l’aggettivazione inconsueta, ma allusiva per rima al magico numero sette) offrono «una mandibola»: davvero il cassone e la lama delle ruspe possono ricordare una bocca e i suoi denti. L’immagine ne genera altre: dal tentativo metonimico di «mettere assieme una bocca | e una voce» si passa a «qualche dente e fame di terra» (le ruspe sembrano ingoiare terra voracemente), fino a tutta un’isotopia del lessico relativo alla cavità orale (denti, bava, tartaro, placca, lo stesso verbo cavare). La semantica testuale cresce insomma per espansioni metamorfiche interne alla lingua, o più precisamente si lascia guidare da relazioni di somiglianza e/o di contiguità fra le entità che designa, dando vita a contesti alterati, lontanissimi dalla cronaca di eventi esterni. Esemplare, in questo senso, la straordinaria immagine che chiude Sauro, l’ultimo testo del libro: «rincorro i gatti | dalle lunghe cautele, || che terminano certe opere | con quel loro fortissimo || punto interrogativo». La coda drizzata dei gatti assomiglia davvero a un punto interrogativo; eppure Bellinvia, anziché esplicitare questa pur originale similitudine, opta per la costruzione più ellittica di tutte: la metafora a un termine solo, dove il tenore più plausibile (la coda) viene alluso mediante il veicolo esplicitato (il punto interrogativo).
L’ancoraggio narrativo-situazionale sembra istintivamente eluso o quantomeno allontanato in quanto esso è luogo della convenzione e del patto sociale per antonomasia: non sono le sue strutture a orientare il discorso, sebbene in alcuni testi sia possibile leggere una situazione in filigrana (per esempio, il mobbing sul lavoro e le violenze intimidatorie di Scacco). La lingua sembra poter contare solo sulle proprie logiche interne, sconfinate nelle possibilità combinatorie quanto opache al senso comune. Ecco allora i frequenti surrealismi, caratterizzati da antropomorfizzazioni (e animalizzazioni) espressionistiche, così come dal precipitare del concettuale o dell’artificiale nella fatticità biologica del corpo: «la smorfia terribile | del bucato» (Verbo), «le infrastrutture | sempre in corso del sangue» (Orsa), «il sette quasi | cancellò il portiere» (CR7), «vomitai tutte le mie cinque vocali» (Scoria), «un acquario di medici ai vetri» (Sarco-), «in volto | mi cresce una felpa nera» (Sauro), «sull’economia in crisi della bocca» (Sillogismo 1), «agli squali | non rimane che andare a piedi» (Sillogismo 3). Luoghi testuali che hanno precursori illustri, tra gli altri, in Antonin Artaud («il cielo affluisce nelle narici | come un latte nutriente e azzurro»), Amelia Rosselli («la gola della montagna si offrì pulita al | mio desiderio di continuare la menzogna indecifrabile»), Antonio Porta («i peli del sopracciglio moltiplicano in labirinto»), Milo De Angelis («facendo la spola | tra i muri della testa e | una chiamata interurbana») e Cristina Annino («io siedo al bordo dell’orecchio universale»).
Si sa che il surrealismo porta con sé il rischio dell’automatismo (più alienato che liberante), con la sua coercizione a ripetere repertori d’immagini e strutture sintattiche, annacquando entrambi in una sorta di monotona saturazione figurale. Come anche Annino, Bellinvia non cade nella trappola e anzi dribbla l’automatismo e la prevedibilità del dettato con una sperimentazione che rimane inquieta e vigile, proteiforme, lontana dalla replica di pochi moduli preferenziali. Le frequenti unità surreali ed espressioniste s’innestano infatti in numerose altre strategie compositive, che coinvolgono almeno montaggio, argomentazione, narratività (ellittica), inventività sintattica, versificazione. Vediamo ciascuno di questi aspetti un po’ più da vicino.
I livelli del montaggio e dell’argomentazione spiccano nella sezione Sillogismi dell’amore perso, dove elementi concettuali elencati in (pseudo)proposizioni di stampo analitico che sembrano fare il verso al Wittgenstein del Tractatus («certe pietre sono bianche», «le formiche sono divise in tre parti») vengono ripresi e distesi in un discorso lirico più tradizionale, neoromantico («il cielo è una persona | fragile, chiusa, sulla quarantina»; «in autunno stavamo, bosco di querce»). Ne risulta una serie di testi bipartiti, comunicanti fra loro sul piano rappresentativo ma divergenti su quello compositivo: la iper-razionalità che emerge dalla logica ‘oggettiva’ delle proposizioni vis-à-vis l’effusione ‘soggettiva’ del discorso lirico. Una contiguità concettuale (per via del lessico condiviso) e fisica (perché le due parti sono stampate sulla stessa pagina, anche se «tra noi un’interlinea doppia è poca», si afferma lapidariamente in Sillogismo 11) viene fatta dialetticamente reagire con una distanza attitudinale (a causa delle diverse forme del discorso adottate) per suggerire iconicamente l’impossibilità dei due amanti di ricongiungersi: rimane il ricordo di una fortissima sensualità predatrice («hai un corpo dal colpo fulmineo», Sillogismo 2) che fagocita l’io dall’interno, come fa ogni amore tossico («sei una tenia», Sillogismo 7; si confronti questa immagine con quella già analizzata in Orsa). Nell’ultimo sillogismo, una preghiera laica s’incarica di recidere il legame con questo passato («Cose, doni, regali di lei, | io vi prego, bollite nel vostro sangue | freddo, abbiate un’ombra, e basta», Sillogismo 12).
La narratività ellittica è già stata esemplificata dalle parabole di Orsa e Articolo all’inizio della prefazione, ma può essere forse ancor meglio apprezzata nella più scopertamente biografica Scacco, dove il polittoto in «mamma lavorò | lavoricchiava non lavora» tratteggia un anticlimax, un arco discendente dalla pienezza del passato remoto (lavorò) alla precarietà marcata dal suffisso attenuativo (lavoricchiava) di uno stadio successivo, fino al presente negato tanto fattualmente quanto grammaticalmente (non lavora); il normale sviluppo narrativo è insomma promesso al primo verso ma sabotato nei versi successivi, così da rendere iconicamente il drammatico stallo di un presente senza sbocchi (si noti anche la stagnazione suggerita dai verbi stativi all’imperfetto legati all’inoperosità del padre che «sedeva», «mostrava»). Per dimostrare l’inventività sintattica basterà l’esempio di Caso: «Lui applaudì || una mosca, la uccise nel pesto | agli angoli e nella spremuta || sua, e roteata, sui muri». In questo breve giro di versi, (a) alla valenza intransitiva del verbo applaudire se ne aggiunge una transitiva che risulta in una violazione collocazionale e semantica (applaudire una mosca, probabile derivazione paradigmatica di schiacciare una mosca); (b) si ha sostantivazione di un participio incongruo del verbo pestare («nel pesto»); e (c) l’ordine aggettivale viene dislocato, con possessivo e qualificativo entrambi posposti e quindi equiparati nel peso espressivo: sua spremuta roteata à spremuta sua, e roteata.
Se mi sono permesso queste digressioni analitiche è stato per dimostrare le qualità vive, lontane dalla maniera (anche dalla maniera nei confronti della neoavanguardia) del fare poetico di Bellinvia: ogni verso mantiene la propria tensione e il proprio potenziale icastico quasi fosse un microcosmo dell’intera poesia, e sarebbe impossibile anticipare, anche vagamente, le svolte che prenderanno i testi verso dopo verso: la lettura di Omissis è davvero un’esperienza di scoperta continua, e questo avviene – e qui sta il piccolo miracolo di questa scrittura – senza forzature che non siano state completamente naturalizzate, metabolizzate in un formalismo istintivo, viscerale, mai frutto di una poetica programmatica. Contribuisce non poco a questa perpetua tensione la versificazione franta e nervosa, che procede in massima parte per moduli di distici o versi singoli brevi o medio-brevi, spesso caratterizzati da iconicità locale: per esempio, in Pronome, la locuzione avverbiale alti e bassi è risemantizzata mediante una disposizione che ne rispecchia il contenuto semantico: «fra i miei alti || e bassi», dove bassi è collocato due spazi più in basso. I testi appaiono dunque, anche graficamente, scolpiti nel bianco della pagina, come se fossero calchi, materia densa e brutale che tradisce una composizione per frammenti; l’autore ha infatti ammesso di comporre spesso collegando parole fra le quali avverte un legame, non diversamente dal modus compositivo confessato da John Ashbery o da William Sydney Graham. L’abbondante bianco tipografico che circonda i testi, e che sembra anzi infiltrarsi in loro, «non è affatto evocazione simbolista ma contrappunto drammatico, figura dell’omissione violenta che rende impossibile ogni organicità discorsiva»[3].
L’unitarietà di fondo, abbagliante, della poetica di Bellinvia mi ha spinto a mettere momentaneamente da parte la questione dell’organizzazione macrotestuale. La visione d’insieme – tanto esistenziale quanto stilistica – fin qui delineata può essere tuttavia ulteriormente chiarita da alcuni accenni al macrotesto, che in sé riassume i due poli finora visti: ordine e frattura, formalizzazione clinica e sabotaggio del senso comune. Attorno al buco nero del titolo complessivo (Omissis) si coagulano tre progetti in cui la tensione tra ordine e frattura è evidente già dai rispettivi titoli. Il titolo Dubbi grammaticali – la prima sezione composta di sette poesie dedicate ad altrettante parti del discorso – si può parafrasare sia letteralmente come ‘dubbi sulla grammatica’ (ovvero sul codice comune, sulle regole e sulle norme) che metaforicamente come ‘dubbi di tipo grammaticale’ e cioè dubbi fondamentali o addirittura fondativi: la grammatica è lo scheletro della lingua e viene interamente acquisita nelle prime fasi dell’esistenza (con le propaggini estreme delle forme passive con specificazione dell’agente, prodotte tipicamente tra fine dell’infanzia e preadolescenza), mentre il lessico è la sua carne e si può apprendere gradualmente fino all’ultimo giorno di vita. Entrambe le letture sono pertinenti, perché il codice comune è sabotato (come dimostrato dai paragrafi precedenti) e perché il soggetto si interroga sulla propria identità e sulle relazioni che dovrebbero garantirla: la nominazione produce identità, eppure ci sono padri e madri che «non hanno || legato bene i nomi | ai corpi dei figli» (Nome); il pronome è «rimanere | sempre a disposizione» (Pronome) – ma a disposizione di chi?; la congiunzione realizza davvero una fusione fra l’io e «l’acqua della Saia» (Congiunzione). La grammatica insomma è un’impalcatura concettuale che dà ordine al magma psichico, ma al tempo stesso ha anch’essa i suoi buchi – i dubbi dell’io, certo, ma anche quelli della grammatica in sé, che è pur sempre grammatica di lingua naturale, non di linguaggio logico, e quindi esposta a quelli che la linguistica cognitiva chiama fuzzy boundaries: confini sfumati, incerti, porosi.
I Sillogismi dell’amore perso, come già rilevato, sabotano la logica stringente che esibiscono tanto nella controparte lirica, quanto nella disposizione e nelle proprietà delle proposizioni stesse: per esempio in Sillogismo 3, mentre una proposizione come «con la bassa marea non si può nuotare» è empiricamente vera, quella metaforica che precede («il mare ha la sua tasca nel cielo») non è né vera né falsa, ma indimostrabile. Non si tratta nemmeno di entimemi (sillogismi dalle premesse sottintese e la cui verità è probabilistica ma non inconfutabile) o paralogismi (ragionamenti errati involontari) o sofismi (ragionamenti errati presentati come veri): si ha piuttosto un’imitazione sottilmente parodica di quanto appare inconfutabile, secondo un procedimento che fa pensare ancora a Cristina Annino, dove spiccano «molti moduli argomentativi che la poetessa utilizza ma, di fatto, defunzionalizza»[4], nonché a certe opere di Gertrude Stein e Charles Bernstein, un cui libro del 1982 si intitola non a caso The Sophist, il sofista[5]. Insomma, l’ordine viene infiltrato (e liberato) dalla frattura, ma la frattura senza quest’appello all’ordine rimarrebbe inarticolata. È proprio questo rapporto simbiotico a rendere così avvincente il formalismo istintivo (e l’istinto formalizzante) di Bellinvia.
La sezione finale, la più estesa, Trenta mandate di chiave, è una costellazione di anagrammi imperfetti numerati da I a XXX che ricombinano virtuosisticamente lettere dalla parola-chiave «sacro»: in ordine di apparizione CR7, Sbarco, Bianco, Arco, Orca, Raro, Pardo, Fango e molte altre. Si vede dunque come il gioco delle permutazioni formali, eredità degli scrittori di OULIPO (Bellinvia si cimentò, molti anni addietro, anche in sonetti monovocalici) permetta di espandere e moltiplicare, come una ragnatela, le occasioni di creazione e di scavo, che vanno poi a toccare dominii assai lontani tra loro: dal campione del calcio in CR7 alla malattia in Sarco-, dalle allusioni alla pandemia in Fango («le idee a porte chiuse | e qualcuno a morire per strada») al paesaggio marittimo di Sbarco, che allude alla natia Reggio Calabria («nel sollievo | di passati nidi di gazza»). Anche gli anagrammi, tuttavia, come e più dei dubbi grammaticali, costituiscono un sistema imperfetto, potenzialmente illimitato, e la scoperta ‘accidentale’ di nuove regioni del dire implica anche un progressivo allontanamento dal nucleo incandescente del sacro – al quale però si finisce per tornare: Sarco-, venticinquesima stazione di questa vertiginosa serratura (altro che le doppie mandate del linguaggio comune!) è infatti anagramma perfetto della parola «sacro» citata in epigrafe alla sezione, a suggerire circolarità e contrazione del moto espansivo.
Desidero concludere questa lunga presentazione con una sorpresa e un rilancio. L’opera che qui si è introdotta è il primo libro veramente organico e rappresentativo dell’autore; e tuttavia è un libro d’esordio in senso esistenziale, non in un senso stretto: non solo per via delle tre sillogi pubblicate in precedenza (Per i vicoli, macellai di piccioni e spettri di carta, Cicorivolta edizioni, nell’ormai lontano 2006; Il lastrico, Lietocolle, nel 2014; e Domotica del labirinto, uscito per VersiGuasti in ebook nel 2020); ma soprattutto perché il corpus ancora inedito di Bellinvia è la parte sommersa di quella punta di iceberg che è Omissis (per quanto paradossale possa sembrare l’accostamento). Corpus ampio e che è frutto di un percorso dilatato nei tempi in cui il corpo a corpo con il trauma si dispiega nelle ekfrasi allucinatorie dei dipinti di Francis Bacon (fastfood bacon), nella vicenda del poeta greco satirico Ipponatte, irriso dai fratelli perché deforme (Farmaco contro le rondini – uno dei sensi di pharmakon è proprio quello di capro espiatorio: altro riferimento alla violenza e al sacrificio), nell’intervista immaginaria della clinica dei Balzi bianchi del soccorso (soccorso: concetto che ritorna, come visto, in Nome, il testo che apre Omissis) e nella favola atroce di Lascio isola ben arredata con fantasia di navi lontane alle pareti, dove un «cildreno bambi» scopre la vocazione alla scrittura («un cildreno bambi è suonato da un’olivetti della casa accanto») in sequenze di testi titolati da decimali: a suggerire la mancanza all’intero dell’identità. Identità umana e poetica che proprio in Omissis raggiunge questo faticoso intero, irradiato dal talento prodigioso di Bellinvia. La speranza e l’augurio è che anche queste opere, con la loro oltranza allucinata e sorprendente inventività, trovino una loro casa e lettori avventurosi in un futuro non troppo lontano.
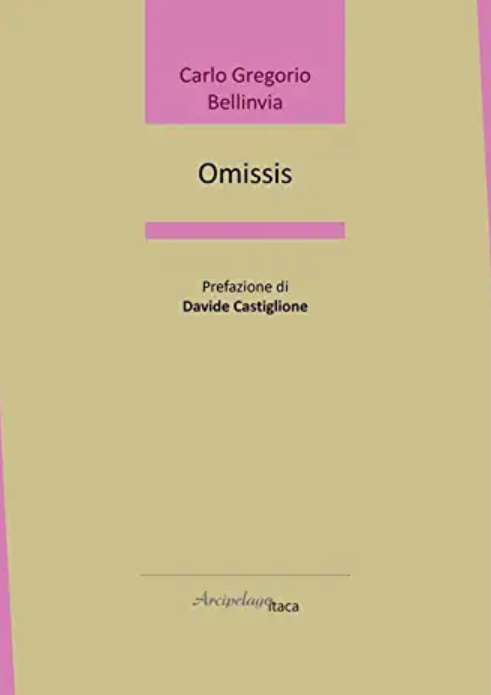
Carlo Gregorio Bellinvia, Omissis, pref. di Davide Castiglione, Osimo, Arcipelago itaca, 2021, pp. 108, €13,5.
[1] Frye, N. (1971 [1957]). Anatomy of Criticism. Four essays. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
[2] Castiglione, D.. Nota a Omissis, di Carlo Bellinvia. Nazione Indiana, 23 febbraio 2020.
[3] Ibid.
[4] Michele Ortore. «Qualcosa dei venti. La poesia in fuga di Cristina Annino». Treccani.it, 18 settembre 2017.
[5] Per approfondimenti in tal senso, mi permetto di rimandare alla mia monografia Difficulty in Poetry: a Stylistic Model (Palgrave 2019), dove tratto del fenomeno in termini di ‘nonsense persuasivo’.