L’omicidio di Luca Varani, avvenuto la notte del 5 marzo 2016 in un appartamento del quartiere Collatino di Roma, è parso da subito più scioccante della media dei delitti che ogni giorno si compiono lontano dagli occhi e dal cuore della folla di noi non-assassini e non-vittime. Quattro anni fa Varani, ventitreenne dalla condotta apparentemente ordinaria e frequentatore occasionale di giri di droga e prostituzione, fu attirato con l’esca di ricevere un centinaio di euro dai coetanei Manuel Foffo e Marco Prato che, chiusi in casa da qualche giorno sotto l’effetto combinato di cocaina e alcol, prima lo drogarono e poi lo uccisero con una sgangherata lentezza, a coltellate e colpi di martello (almeno un centinaio, dalle ricostruzioni della Scientifica). Il fatto era corredato di dettagli inquietanti: un misto di premeditazione confusa (Varani fu l’ultimo di una serie di ragazzi invitati da Prato e Foffo nel giro di un paio di giorni, e il meno fortunato) e violenza disinteressata e astratta come una curiosità (Foffo, un ragazzo di buona famiglia come Prato, dichiarò alla polizia che loro avevano attirato Varani nell’appartamento per vedere l’effetto di uccidere una persona). Le ricadute del crimine, altrettanto drammatiche, resero ancora più fosco il quadro: Foffo, che ha scelto il rito abbreviato, è stato condannato a trent’anni; Prato, dopo aver proclamato la propria innocenza, si è ucciso nel carcere di Velletri, dopo vari tentativi, il 20 giugno 2017. Una storia del genere ci appare d’istinto qualcosa che parla da sè, che mette a nudo l’esigenza difensiva dell’essere umano di dare una causa e una spiegazione al male, di osservarlo, a distanza di sicurezza, come qualcosa che tocca sempre agli altri. Una storia che parla da sola: era il titolo di un breve racconto di Gianfranco Bettin, costruito come un collage di testimonianze e commenti sul delitto di Novi Ligure del 2001, che ricorda il caso Varani per tanti motivi (giovane età dei protagonisti, apparente mancanza di movente e ferocia accanita dell’esecuzione, odio intergenerazionale, preminenza dei padri nel discorso pubblico).
Nella Città dei vivi Nicola Lagioia raccoglie la sfida e decide di ricostruire con un non-fiction novel premesse, svolgimento e lunga coda (almeno fino all’inizio del 2020, dove il discorso per forza di cose si arresta) dell’avvenimento. Il lettore smaliziato potrà cimentarsi a trovare le molteplici ispirazioni romanzesche del libro, perché a pensarci l’uccisione di Varani ricorda vagamente quella di un precedente personaggio fittizio di Lagioia, la Clara della Ferocia (2015), e le atmosfere di una Roma sfasciata e notturna evocano l’horror di Stephen King e un po’ anche un piccolo-grande romanzo come L’animale notturno (2017) di Andrea Piva. Lagioia insiste sul parallelismo, già in odor di adattamento audiovisivo nei pressi di Suburra, fra il delitto Varani e una Roma putrida, infestata da creature senza volto e dall’«onnipresente consapevolezza che tutto è umano e tutto si corrompe». È una città che di eterno ha solo il nichilismo. Non serve neanche un’immersione nel cuore di tenebra per capire la semplicità di una perenne decadenza (perché l’immaginario della Città dei vivi, pur non accogliendo il termine, va lì), L’omicidio Varani ne sarebbe l’emblema:
Nutrire una speranza non era piú vissuto come dabbenaggine ma come un insulto mortale, ciò che restava di vitale attirava l’aggressione, il morso del contagio, e quella piccola barriera rivestita di legno, la porta dell’appartamento di Manuel Foffo – pensai guardando ancora i colli in lontananza –, simboleggiava il capolinea di un lungo processo degenerativo.
Pochi, suggerisce Lagioia, riescono a galleggiare con successo, come il turista sessuale olandese che, in una narrazione parallela, adesca minorenni alla stazione ma riesce a cavarsela senza essere arrestato, mantenendo intatti cinismo e cattiveria: mentre Foffo, Varani e Prato a loro modo sono fragili, caduti di fronte al nulla di cui si sono nutriti e compiaciuti per tutta la loro esistenza. Un verdetto suo malgrado rassicurante, che chiude il romanzo dividendo il mondo fra chi ce la fa (le comparse e le figure sullo sfondo) e i soccombenti (i protagonisti) nella Grande Fogna.
La Roma di Lagioia, sotto le pennellate orride, è farsesca. L’autore chiarisce subito che questa storia non sarà una tragedia, ma un’ennesima ripetizione grottesca, ben al di sotto dei suoi archetipi:
Nessun essere umano è all’altezza delle tragedie che lo colpiscono. Gli esseri umani sono imprecisi. Le tragedie, pezzi unici e perfetti, sembrano intagliate ogni volta dalle mani di un dio. Il sentimento del comico nasce da questa sproporzione.
In effetti, la compresenza di tragico e ridicolo che Lagioia vuole restituire affiora da alcune battute memorabili, come quella di Foffo che ricorda «Anche Anna, la mia cameriera, me lo diceva sempre: Manuel, tu sei un genio incompreso», invitandoci alla diffidenza e a una comprensione ironica dei fatti. Il lettore assimila da frasi del genere la disperazione del killer di buona famiglia, senza il pathos e il trasporto assoluto della tragedia. Altrove, le ultime volontà di Prato prima del tentato suicidio (Varani è appena morto) vengono riportate da Lagioia così come sono: e quel misto di ridicolo, patetico, autenticità esibita e involontaria complessità del documento reale arriva dove lo stile non giunge.
Procedendo verso il racconto del delitto, La città dei vivi migliora. L’evento è il vertice architettonico del romanzo, sul palese modello di A sangue freddo (1966) di Truman Capote. Ne riprende la struttura narrativa a cerchi concentrici, in cui dapprima si mostra la scoperta dei colpevoli (Parte prima, I commensali dell’uomo), poi si ricostruisce il contesto (Parte seconda, Il pelo dell’acqua) attraverso le voci dei testimoni (Parte terza, Il coro), infine si arriva, in un crescendo di tensione, al già noto del delitto, riferito in dettaglio, da vicinissimo, per bocca dei due assassini (Parte quarta, In fondo al pozzo). I primi segnali di un avvicinamento al nucleo incandescente del caso stanno in alcuni notevoli resoconti di ragazze e ragazzi implicati nella vicenda. Nella velocità a volte bruta della trascrizione orale s’intravede una delle possibili cause motrici del fatto di sangue: la frenesia di onnipotenza, che si accompagna all’esigenza di identità cangianti per uscire da un io sociale che non si sopporta più e per illudersi di poter fare, ed essere, qualsiasi cosa. Il desiderio della trasformazione attanaglia esplicitamente Prato (incline al travestitismo: era vestito da donna anche al momento del delitto), ma torna anche in alcuni passaggi su Foffo, come in questo lacerto affascinante del resoconto dell’ex fidanzata Aurora. Manuel è sotto gli effetti combinati di alcol e droghe:
Ma poco dopo, all’improvviso, saltò di nuovo giú sul pavimento, si diresse verso i cassetti dell’armadio e incominciò ad aprirli furiosamente uno dopo l’altro. Apriva i cassetti e rovistava tra i vestiti, cercava i costumi da bagno. Devo trovare un costume da mettermi addosso, altrimenti mi vedono! E io: Manuel, ma chi ti vede? Iniziavo a essere spaventata. Ebbi la sensazione che da un momento all’altro potesse succedere qualcosa di brutto.
Il ritmo veloce si sposa alla preparazione lentissima al delitto (con le varie comparse invitate nell’appartamento da Foffo e Prato, e poi sfilate via) e l’atmosfera si fa progressivamente horror. La paura è percepibile da alcune voci: merita, in particolare, la storia di Alex, con l’interessante paradosso che comporta. Il ragazzo, l’ultimo a entrare nell’appartamento prima di Varani, viene drogato con un vodka lemon “corretto” e arriva a un passo dal diventare vittima. Ma riesce a trovare la forza di andarsene via proprio perché è drogato, non nonostante ciò: la sfrontatezza dell’annebbiamento lo salva dalla tortura, probabilmente dalla morte.
Avvicinandosi alla soglia dell’assassinio, il testo sale di livello, si fa intenso. L’essenziale inspiegabilità della violenza è il segno di una possessione reciproca dei due assassini («Io possedevo lui. Ma era come se lui possedesse me»). I due sono svuotati dalla responsabilità e dalla consapevolezza di ciò che stanno facendo, come chi è in preda a una furia fine a se stessa. Ma anche come chi è innamorato. Sarebbe di cattivo gusto stabilire una classifica, ma uno degli elementi più ardui da tollerare nell’omicidio Varani è proprio l’amore che sottende le azioni dei due. L’attrazione discenditiva fra Manuel e Marco è il carburante per mettersi a nudo (i due si confidano le paure, i desideri più inconfessabili, l’odio verso il padre, la madre, la coscienza dei propri fallimenti), e simmetricamente per chiudersi nel delirio della cocaina, e poi ammazzare. Quando Manuel, infierendo su Luca, chiede a Marco di baciarlo sulla testa «per trovare la forza di strozzarlo, di togliergli la vita», l’omicidio è un racconto a due come in Capote. L’amore non è più fra autore e uccisore, come nel modello statunitense, ma fra i due uccisori: e il più grande pregio del libro è non voler uscire dalla contraddizione che un sentimento positivo (almeno secondo il senso comune) possa legare due persone per condurle a un massacro.
Sfortunatamente, questa strada nella Città dei vivi è abbastanza defilata rispetto al “centro” del discorso prevalente. Le tracce dei fatti sono coperte da uno stile che tende al giornalismo nel senso non esattamente nobile del termine, e una buona porzione del libro è come il suo prefinale: «mentre il cielo stellato si impossessava della scena, rivelato ai nostri sguardi dai complicati principî di rotazione e rivoluzione, la gigantesca macchina che ci fa nascere e ci riduce in polvere» – ossia: belle frasi che, a una lettura attenta, non lasciano molto. Si accavallano sentenziosità («Assolvere è comunque giudicare. Le spalle curve testimoniavano la lotta che in certi periodi della vita sosteniamo per non lasciare che la nostra identità – o ciò che reputiamo tale – venga travolta dalla falsa immagine che gli altri hanno di noi»), similitudini in equilibrio fra l’incongruo e il bislacco («Martina si era fatta incidere la “A” di Alex sulla guancia e tatuare il suo nome sul seno – una moderna Hester Prynne la cui lettera scarlatta, in un sol fuoco, bruciava l’antico fantasma dell’adulterio con il bisogno di protagonismo del XXI secolo»), evocazioni letterarie d’accatto («Roma era un discorso a parte. Sotto la pioggia era il discorso di un pazzo che, come non di rado accade, conteneva squarci di verità» – se due indizi fanno una prova, la trivializzazione di Macbeth, sommata all’Hawthorne di cui sopra, ci dice che Lagioia ha dei conti in sospeso con la letteratura di lingua inglese) e infine definizioni di compiuta insensatezza («cieco vuoto pneumatico»). Non è chiaro a cosa si debba l’impaccio, non limitato a queste frasi. Ma qualche spiegazione si può tentare.
Credo per esempio che una spia del disagio stilistico di Lagioia nella Città dei vivi stia anche nella posizione che l’autore tiene rispetto alla sua materia. Il fatto è avvenuto nel 2016 e il libro esce nel 2020. Ma la storicizzazione (troppo) precoce crea una distanza incongrua dal sapore artefatto, strana da leggere solo quattro anni dopo gli eventi, come nell’incontro con Luigi Manconi che «all’epoca aveva quasi settant’anni» o la rievocazione della candidatura di Adinolfi a sindaco («Ex deputato del Partito democratico, Adinolfi era un cattolico antiabortista, strenuo sostenitore della famiglia tradizionale. In quell’anno di giunte decapitate, Adinolfi si preparava a correre per le elezioni»). È vero che sono passati solo quattro anni, che molte persone implicate sono ancora vive e che, in un libro come questo, era importante ‘stare lontani’ e tutelarsi da conseguenze legali, denunce o anche solo rimostranze di chi magari si è trovato la vita distrutta per sempre: la cautela verso le persone reali è un dovere morale, per chi scrive non-fiction, ma qui non contribuisce a rendere La città dei vivi migliore (che purtroppo sulla lunga durata, quando fra cento anni nessuna persona coinvolta sarà in vita, resta l’unica cosa che conta). Per dire, l’epistolario fra Lagioia e Foffo è menzionato verso la conclusione, ma non c’è traccia delle lettere originali: la disponibilità delle lettere potrebbe essere stata preclusa da mancate autorizzazioni o da sviluppi processuali ancora in corso, ma resta una perdita non da poco per l’economia del romanzo non avere una traccia diretta della versione di Foffo.
Sotto questo aspetto, è lontano un altro modello dichiarato come L’avversario (2000) di Carrère, che affrontava il tema del delitto con un po’ di spregiudicatezza in più, mentre La città dei vivi dà l’impressione di procedere col freno a mano tirato, come se la letteratura non fosse riuscita a dare una sua prospettiva inattesa alla cronaca che affronta. Un’altra differenza da Carrère rinforza la sensazione dell’impaccio di Lagioia nel prendere posizione sul suo argomento: il modo in cui l’autore proietta alcune caratteristiche proprie sull’assassino. Le somiglianze fra Carrère e Jean-Claude Romand sono tutte istituite sotto il segno della finzione e dei suoi effetti imprevedibili: Romand è per Carrère un romanziere mancato, ha inventato per il mondo esterno una vita verosimile che ha fagocitato una vita vera fatta di solitudine, vergogna sociale e squallore; l’autore, ripercorrendo le sue orme, cerca di comprenderlo in un confronto paradossale ‘da collega a collega’ (non tanto diversamente da quanto fa nel Regno, 2014, con la fantasia di approssimazione all’evangelista Luca, romanziere inconsapevole). Lagioia invece mette l’adolescente irrequieto che è stato a confronto con Foffo e Prato:
Questa è la considerazione piú complicata da mettere a fuoco: le mie risorse di allora, voglio dire, erano cosí scarse che non mi avrebbero consentito di uscire senza sregolatezze – e sregolatezze piuttosto pericolose – dal vicolo cieco in cui mi ero ficcato. Ci era voluto piú di uno strappo violento per tirarsene fuori.
Sono stato fortunato […]
La proiezione però non è del tutto limpida. Lagioia confessa di sé cose come un tentativo molto accennato di mettersi nel mercato della prostituzione e un lancio di bottiglia che, fortunatamente, non prese in testa una passante: gesti che avrebbero potuto portarlo dalle parti di un atto crudele (e premeditato) come quello di Foffo e Prato solo con molta fantasia (o meglio, con un sovradosaggio di wishful thinking), o con l’aggiunta di molti step intermedi – in pratica solo se Lagioia avesse fatto un migliaio di cose che però, nella realtà, non ha fatto. Il parallelismo, nobile negli intenti, si affloscia davanti alla constatazione della distanza fra il vissuto di Lagioia e quello degli assassini; nel solco della sproporzione evidente, finisce per tingersi di inconsapevole paternalismo.
La non-fiction più riuscita esaspera qualcosa che soggiace a tutta la fiction ispirata dichiaratamente alla cronaca: è un’ombra lunga che copre il fatto reale, anzi vi impone i suoi contorni alterando il ricordo di ciò che è stato fuori dalla pagina. Questo vale anche per La città dei vivi, ma all’inverso: se il delitto Varani resta una storia che parla da sola, è perché il romanzo non è stato abbastanza potente da imporre la propria versione alla realtà, non ci ha dato una visione che permettesse di cogliere ciò che la realtà non ha saputo confessare a se stessa. Invece il romanzo di Lagioia è una storia tiepida e irrisolta, che non sta del tutto in piedi da sola (e il ricorso frequente, di cui mi accorgo rileggendo questo articolo, a paragoni con opere affini è un sintomo della compulsione del wannabe critico accademico a istituire genealogie e schemi almeno quanto lo è della difficoltà a giudicare il valore della Città dei vivi come opera in sé e per sé, per quello che, in autonomia, sa dire).
Tanto ancora si discuterà attorno a questo romanzo, alle sue ambizioni e ai suoi esiti. Ma ci si potrebbe anche fare una domanda sul ‘fuori’: su come mai un romanziere, che incidentalmente è anche uno degli autori più unanimemente apprezzati da stampa, pubblico di ‘lettori forti’ e critica, oltre che una delle persone più autorevoli dell’attuale panorama culturale e letterario italiano, non dia alle stampe un romanzo davvero bello e convincente da circa sedici anni. Ma a quel punto saremmo nel territorio dei gusti, lontanissimi dall’appartamento del Collatino e dalla sua scia di sangue.
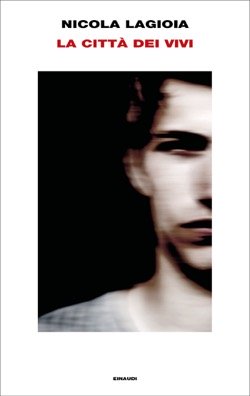
Nicola Lagioia, La città dei vivi, Einaudi, Torino 2020, 472 pp. 22,00€