La recensione fa parte di un progetto di collaborazione fra la rivista “La Balena Bianca” e il Master in Editoria promosso dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e dall’Università degli Studi di Milano nel contesto della quinta edizione del Premio POP – Opera Prima, coordinato da Andrea Tarabbia. A coronare mesi di discussione e lavoro in classe intorno ai libri in lizza per il premio, gli studenti del Master si sono cimentati nel recensire a gruppi i titoli giunti nella cinquina finale. L’iniziativa rispetta a pieno l’intento alla base del Premio POP: permettere un confronto tra (quasi) esordienti nel mondo editoriale e scrittori esordienti del panorama italiano contemporaneo.

Questa recensione è stata scritta dagli studenti Andrea Ghiazza, Aurora Nicoli, Mariachiara Rafaiani, Beatrice Rodigari, Fabiano Scarani.
È stato un piccolo caso letterario del 2020. Finito nella sestina dello Strega, vincitore del premio Libro dell’anno di Fahrenheit-Rai Radio3, ha fatto molto parlare di sé per essere riuscito a porre al centro del dibattito culturale tematiche delicate come l’orientamento sessuale, la malattia, la disuguaglianza sociale. Il suo autore, trentacinquenne cresciuto nella periferia milanese di Rozzano, ora è una star sui social, e ha portato un po’ di freschezza nell’ingessato mondo dei premi letterari italiani, presentandosi alla serata finale dello Strega in giacca nera di paillettes, trucco agli occhi e smalto alle unghie – un alieno, in mezzo a Carofiglio e Veronesi. Stiamo parlando di Jonathan Bazzi e del suo Febbre, romanzo d’esordio pubblicato dall’indipendente Fandango a maggio 2019 ed esploso in termini di vendite ed esposizione mediatica in questo strano 2020, soprattutto grazie alla spinta dello Strega.
L’origine di Febbre, però, va ricercata tre anni prima dell’uscita, ed è molto interessante ricostruire la sua genesi editoriale. Il 1° dicembre 2016, Bazzi pubblica un articolo su Gay.it in cui, con invidiabile coraggio, espone pubblicamente la sua sieropositività. È un coming out atipico, perché di HIV non si parla quasi mai, le malattie sessualmente trasmissibili sono ancora oggetto di stigma sociale e diffusa disinformazione. Bazzi mostra il privato della sua malattia per liberarsi di un peso, per mettere in guardia, per rivendicare la propria esistenza, di corpo malato con cui fare quotidianamente e dolorosamente i conti, ma anche di persona che è altro dalla sigla di un virus. L’articolo ottiene molta visibilità, scatena il dibattito; Bazzi ne scrive altri due su Vice nel 2017, approfondendo il discorso e misurandosi con le reazioni al suo esporsi, con i messaggi di supporto e i numerosi insulti; finché, come fosse inevitabile, il discorso si espande sempre più, include il passato, l’infanzia, i traumi, la convivenza con la malattia, diventa racconto del Sé, sul filo dell’autobiografia: diventa, insomma, un romanzo. Nasce Febbre. Le ragioni del suo successo, anche se relativamente tardivo, sono da ricondurre a precise scelte editoriali: la copertina pop dall’illustrazione memorabile (una mano rossa che tiene uno stelo terminante in due occhi che piangono lacrime di sangue), l’efficace quarta di copertina («Davanti al pregiudizio alzare la posta: meglio tacere? Lo sapranno anche i muri»), il risvolto molto informativo e un’agile scansione interna dei capitoli (50, tutti molto brevi, dalle 4 alle 12 pagine). E alla fama del titolo concorre anche la presenza studiata e capillare dell’autore sui social network: Bazzi non perde occasione per buttarsi con consapevolezza nella mischia del dibattito pubblico, partendo dai fatti di cronaca e attualità per arrivare a riflessioni più ampie sul presente, con l’obbiettivo di scuotere e mettere in discussione il sentire comune e il pensiero per categorie dominanti.
Febbre è, in primis, una confessione; un lungo monologo in cui Jonathan racconta nel dettaglio ogni fase della sua malattia, dalla scoperta della sieropositività, a partire da quella lieve ma persistente febbre che dà il titolo al romanzo («Tre anni fa mi è venuta la febbre e non è più andata via», suona così il folgorante incipit), all’ansia, la depressione, l’accettazione, i percorsi di cura, le visite periodiche in ospedale, il sostegno del compagno, la paura di avere infettato anche lui. Bazzi è accurato, preciso, chirurgico; non tralascia nulla, vuole essere il più trasparente possibile, sia a proposito dei fatti sia a proposito delle proprie reazioni e oscillazioni emotive, espresse con una sincerità disarmante che riesce a tenersi sempre sul filo dell’autocommiserazione, senza mai cedervi. E lo fa con uno stile molto personale, simile a quello dei suoi articoli, fatto di frasi brevi e icastiche, frequenti a capo, sintassi semplice; uno stile che può essere definito banale, poco letterario, da post sui social network, ma che in questo caso è perfettamente funzionale a un romanzo in cui la potenza dirompente del contenuto, il messaggio, l’autodeterminazione prevalgono necessariamente sulla stilizzazione retorica – senza contare che, in ogni caso, uno stile semplice non equivale a un’assenza di stile, e spesso si trascura la difficoltà della semplicità, dell’essere scarni, nudi.
Ma sarebbe scorretto ridurre Febbre a un memoir della malattia, alla cronaca di un’esperienza di sieropositività. Perché il libro è diviso nettamente in due parti che si alternano a ogni capitolo; e se una parte, quella del presente, è effettivamente dedicata all’HIV e al corpo a corpo con la pervasività del morbo nella vita di Jonathan, in un’altra parte quantitativamente ben più consistente, quella del passato, Bazzi racconta tutto ciò che c’è stato prima di quello spartiacque fatale: l’infanzia a Rozzano, una famiglia disfunzionale in cui si confondono amore e violenza, assenza e prevaricazione, l’omosessualità, le prime esperienze sentimentali, il costante senso di esclusione, la voglia di cambiare tutto, il trasferimento a Milano, l’amore. È qui, in questo dipanarsi di una vicenda esistenziale privata che non fa fatica a diventare presto universale, il vero nucleo del libro; è qui che si travalica una dimensione di etichette (omosessualità, sieropositività, malattia) per entrare nella profondità dell’esperienza. La Rozzano di Bazzi è un microcosmo di grettezza, piccole violenze private, sessismo e machismo, come ogni periferia relegata a non-luogo che accoglie gli esclusi e i marginali; per uno come Jonathan, a cui piacciono i giochi da femmina e i vestiti stravaganti, che è attratto dai maschi e dalla cultura (una bestemmia, tra i palazzi popolari rozzanesi), il suo paese nell’hinterland è una prigione, un inferno quotidiano. Febbre è il racconto di una progressiva e conflittuale liberazione da questa complessa situazione esistenziale; e il solo fatto di ripercorrere la propria vicenda tentando di scardinarla attraverso la scrittura è un atto esorcizzante, una scelta ambiziosa di chi prova a giocarsi il tentativo di lasciare il segno nella società in una forma raramente contemplata nella letteratura italiana. Del tutto diverso invece il panorama di altri paesi d’Europa: si pensi alle riflessioni sulla domesticazione dei corpi e sulla sessualità negli scritti di Foucault, figura di riferimento di vita e letteratura per Mathieu Lindon e Hervé Guibert. I due hanno affrontato i propri personali viaggi di crescita sentimentale e sessuale, sotto l’egida del celebre filosofo, rispettivamente in Cosa vuol dire amare (2011) e in All’amico che non mi ha salvato la vita (1990). Per non parlare poi dell’ondata ormai pervasiva di prodotti editoriali (libri e non) proveniente dagli Stati Uniti, in cui da anni ormai si sta trattando in maniera appropriata il tema dell’omosessualità e della diversità (per esempio in svariate serie TV prodotte da Netflix). Tutto questo movimento può essere ascritto a una volontà globale di liberazione sessuale e di nuova consapevolezza dell’identità di genere. È lo stesso Bazzi a esporre la missione della sua narrazione liberatoria, in un brano che potrebbe racchiudere il senso dell’intero libro:
«Le persone non sono soprattutto il loro prendere posizione rispetto a circostanze, fatti e vissuti già dati? Siamo dispositivi vivi, che possono sempre ricombinare le contingenze. Tra gli scatoloni di cemento delle case popolari io sono cresciuto in un’intercapedine, respirando una bolla d’aria diversa. Ho conosciuto lo sradicamento silenzioso, il vuoto della non appartenenza. Mi sono abituato all’idea che dovrei vergognarmi di quello che sono e ho capito che il patto velenoso si può spezzare raccontando tutto. Esporre il copione, il regolamento. Appropriarsi a proprio modo dello spazio dell’esclusione, introdurre una falla nel sistema e stare a vedere».
Ecco, è questo il centro del discorso. Febbre può peccare di qualche ingenuità, avere alcune pagine di troppo, fondarsi su uno stile al limite del banale. E nella lettura la voce di Bazzi a un certo punto risulta ingabbiata dalla stessa struttura binaria del romanzo: nelle parti su Rozzano l’occhio scorre senza intoppi, grazie a una quantità informativa e a una profondità mai abbandonate, mentre nella parte del presente e della malattia, meno efficace della prima, soprattutto nella seconda metà del libro, il controllo dell’autore risulta inferiore, forse per una intrinseca brevità dei materiali e per la necessità avvertita ed espletata di aggiungere estratti argomentativi, abbandonando il sentiero dell’esposizione dell’esperienza. Tuttavia, rimane un romanzo che spezza patti velenosi, introduce falle nel sistema; è un libro oscenamente intimo, spudoratamente sincero. Un libro necessario nel panorama letterario italiano: un atto di coraggio che, proprio poiché fuori tempo massimo, si rivela, oggi, più puntuale che mai.
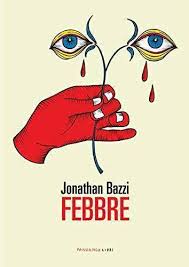
Jonathan Bazzi, Febbre, Roma, Fandango, 2019, 328 pp., € 18,50.