Roberto Abbiati è un artista bizzarro e inclassificabile. Visitando il suo sito web si può apprendere come sia «sostanzialmente un cuoco che suona la cornamusa», ma non è tutto; non è tutto perché Abbiati è uomo di teatro e non solo, perché in effetti sa suonare molti altri strumenti non convenzionali e «poco spendibili», come il banjo, i cucchiai, il bouzouki. È stato mimo al Teatro alla Scala, ha raccontato la storia della prima giraffa di Francia, sotto la regia di Mazzacurati è stato attore cinematografico. Per una serie di circostanze imponderabili si è trovato a lavorare per lungo tempo su Moby Dick, romanzo colossale e complesso, ricavando da quasi seicento pagine di letteratura prima delle statuette di argilla, poi uno spettacolo teatrale che prende vita all’interno d’una costruzione in legno che fa da stiva di nave, infine un romanzo a disegni che ripercorre l’intera, leggendaria storia del Pequod. Viene quasi da non credergli quando dice che s’è trovato a farlo per caso, il più delle volte seguendo il consiglio d’un qualche amico, collega, avventore.
Ho avuto il piacere di parlare con Roberto nell’ambito dell’ultimo Festivaletteratura di Mantova. Così, come per incanto e per qualche manciata di minuti, la città si è fatta ventre di balena.
Il suo romanzo a disegni, pubblicato quest’anno per Keller, narra le vicende di Moby Dick in maniera sintetica, offrendo al lettore una tavola per capitolo. Il prodigio della sua china è quello di sapere per davvero stilizzare una storia simile, in così pochi tratti, scavando a fondo nella sostanza dei personaggi e non dimenticando le parentesi dedicate alla cetologia e alle tipiche pratiche marinaresche. Dice di aver cercato il cuore d’ogni capitolo, di aver sfrondato le parole con attenzione, cercando di ricreare un percorso coerente e compatto. Ne sono uscite centotrentotto tavole d’alto livello e dallo stile personalissimo, confezionate peraltro da un artista che dice di non saper disegnare, o perlomeno di non aver ancora imparato a farlo per bene, come suggerisce l’accademia. Forse è questo che colpisce di Abbiati, che quando disegna lo fa seguendo il tratto fedelmente, senza far bozze in matita e rigorosamente senza cancellare. Non lo può fare d’altronde, perché perderebbe la fedeltà del tratto e tutto andrebbe a catafascio. In questo il nostro baffuto disegnatore di balene è nel senso più profondo della parola un artista, una persona che dalla materia inerte ricava qualcosa di unico e, in certo senso, misterioso; il procedimento non si può ripercorrere o studiare a ritroso. Al pubblico è dato giusto il tempo per osservare la sua penna che si muove elegante, per sentire l’odore del calco d’un pastello se decide di usarlo – e questo lo si può sentire semplicemente sfogliando il suo romanzo a disegni.
Trasporre in un romanzo a disegni un’opera colossale come Moby Dick dev’essere complesso. Dimmi, da dove è venuta l’idea di farlo e come hai pensato al rapporto tra parola e immagine? Insomma, come ti sei avvicinato a questo lavoro? Immagino che avrai dovuto lavorare per sottrazione: parti da un romanzo di grandissima estensione e arrivi a qualcosa di ridotto, a un corpo minimo.
Ho incontrato il Moby Dick leggendolo e appassionandomi, poi è stata una cosa fortunata. Cominciai a fare delle piccole opere con la creta che rappresentavano le varie scene del romanzo e da questa cosa è nata una specie di installazione. Il direttore di un festival mi disse: «da qui devi fare uno spettacolo». Io non volevo assolutamente farlo, non mi interessava, ero ostile. Però era il direttore di un festival e io, per non essere scortese, dissi che lo avrei fatto, ma che lo spettacolo sarebbe durato un quarto d’ora e solo per dieci persone. Lui disse: «lo produco», allora l’ho fatto ed è questo Moby Dick (ndr, lo spettacolo si chiama Una tazza di mare in tempesta): ho raggiunto più di mille repliche, lo faccio da dieci anni e in diciassette minuti racconto Moby Dick per ventidue persone alla volta in una stiva di nave. Già quella è una riduzione: quel che mi sorprende è che, per quanto io abbia fatto il lavoro umilmente, sperando che funzionasse, tutti mi dicono che lì c’è tutto Moby Dick. In diciassette minuti. Non so, forse è perché c’è anche la cetologia sintetizzata… Poi ero in Francia a fare lo spettacolo e in contemporanea c’era una fiera del libro. C’era un editore francese che ha visto lo spettacolo e quando lo ha visto, non so per quale motivo, si è fatto l’idea che potessi disegnarlo e mi chiese se avrei voluto farlo. Io come al solito non volevo farlo, non mi interessava. Però… l’unica possibilità era avere un’idea, perché Moby Dick lo hanno disegnato tutti. L’idea era di sintetizzare ogni capitolo con una tavola: la presunzione è che uno, sfogliando il mio libro, possa avere l’immagine di tutto il romanzo, spoglio di qualsiasi parola. È stato un lavoro molto faticoso, perché era il mio primo libro illustrato, non ho mai illustrato o fatto il disegnatore. Ho dovuto leggere e rileggere ogni capitolo per capirne il cuore e legarlo con il capitolo precedente e il successivo. Non so se sono capace di disegnare, ma ci sono stato sopra per un anno e mezzo, non sul disegno ma sul pensiero. Il testo l’ho fatto sparire, ma il rapporto è comunque intenso: io tendo sempre a ridurre tutto a un racconto. Vedo una fotografia, la capisco se la riduco a un racconto. L’idea, con questo romanzo, è che un racconto faccia il procedimento inverso.
Continuo su questa scia e ammetto che mi hai preceduto: mi ero preparato una domanda in cui ti dicevo che il rapporto tra te e la balena bianca è evoluto nel tempo, perché ho avuto l’opportunità di leggere il libro di Codignola (Un tentativo di balena, Adelphi 2008), illustrato da te. Anche grazie a lui e al vostro libro ho saputo dei tuoi lavori precedenti, dello spettacolo e dei personaggi costruiti con la creta. La domanda che avevo in mente diventa un po’ bizzarra, perché tu mi hai fatto notare come sia arrivato qui, al romanzo a disegni in maniera rocambolesca, ma a questo punto e a posteriori: ti viene da pensare a queste espressioni di Moby Dick come a diverse immagini del romanzo, oppure ripercorri sempre lo stesso filo, la stessa interpretazione?
Allora, è un romanzo che ha già una sua ricchezza, la ha dentro. La grandezza di un romanzo, di qualsiasi cosa che sia un’opera d’arte, la si vede quando si lascia trasformare. Se tu pensi che ci sono delle cose che non puoi toccare, non puoi trasformare, non ti dà nessuno spunto, la faccenda è morta lì, è fritta lì. La grandezza del Moby Dick è che se ne possono fare di cose, moltissime. Sto lavorando alla Commedia, ora. La sua grandezza è questa: quante note sono state fatte alla Commedia, su ogni parola? Contrarie, ostili, uno che ce l’ha con l’altro, vuol dire questo e quest’altro, ma è la grandezza dell’opera che permette questa cosa qui. Io dico che Melville permette questa cosa, permette il cinema, la musica, i disegni, il fumetto, la riscrittura, perché Moby Dick è una grande opera. Sono messo così, insomma. Domani, ti venisse in mente di fare un’opera musicale, la si può fare. Volessi fare delle pitture, una riscrittura, ritradurlo, si può. Pavese cosa ha fatto? Non abbiamo mica Melville, con Pavese. Cioè, si è permesso delle cose che… ma Melville glielo permette: leggi Pavese e dici cazzo, eh. Ci ha messo giustamente del suo.
Hai scelto di usare il bianco e nero, e nel bilanciare il rapporto tra i due colori ti sarai trovato giocoforza di fronte alla famosa bianchezza della balena. La tavola relativa al capitolo in questione è intonsa, bianca. Di questo bianco si parla come di un colore «venerabile e sublime» e allo stesso tempo capace di «incutere più panico all’anima del rosso che atterrisce nel sangue». E però ricordo delle tue tavole scure che sono riuscite a ghiacciarmi il sangue, che nel nero mi hanno ricordato l’abbagliante bianchezza della balena. Penso all’ultima porta d’Inferno, al capitolo Il Pequod incontra la Rachele. Quindi, tirando le fila, puoi dirmi qualcosa sul rapporto tra bianco e nero?
Io ho fatto grafica e sono stato fortunatissimo, perché ho avuto un professore di grafica, A.G. Fronzoni, un grandissimo. Disse una cosa che ho scoperto nel tempo esser vera, disse che tutto quello che è in bianco e nero può diventare a colori. Se progetti in bianco e nero si può arrivare ai colori. Tutto quello che progetti a colori, invece, non è detto che si possa trasporre in bianco e nero. Sembrerebbe il contrario, perché tu dici: «faccio una foto a colori, diventa subito in bianco e nero». Ma se fai una foto a colori e l’hai pensata a colori, col bianco e nero ti diventa tutta grigia. Basta che due colori abbiano la stessa intensità e vedi il grigio, lo stesso grigio. Se invece fai una foto in bianco e nero e vuoi colorarla aggiungendo, hai qualcosa di più. Io dico, nella fotografia ma in generale, che se hai la ricchezza del minimo tutto può arrivare a qualcosa in più, ma se parti in un certo modo non puoi tornare indietro. L’idea di questo bianco e nero allora parte proprio dalla bianchezza della balena, cui si aggiunge il nero di tutto il resto. Ha funzionato tantissimo essere deciso su queste cose ed esser subito deciso, non avere mezze misure. La pretesa che ho ed è un’altra presunzione, perché non sono neanche un disegnatore, è la pretesa che uno veda il colore quando io ho fatto il bianco e nero. Nel libro, sfogliandolo, uno deve avere la sensazione chiudendolo che ci siano dei colori. Poi, se torna a controllare, non ci sono. Questa è la presunzione massima degli artisti.

Andiamo avanti: riguardo al tuo stile di disegno, nel tuo lavoro hai qualche riferimento, qualche artista o illustratore da cui trai spunto? Aggiungo una cosa: leggendo il tuo romanzo a disegni sono stato colpito dall’attenzione ai ritratti. Ripercorrendo il ritratto di Queequeg, per esempio, ho ritrovato tutto Queequeg, quello che è nel romanzo. Quella tavola si è come estesa, vedere gli occhi di Queequeg per come li hai disegnati mi ha dato l’idea che ho di lui, che probabilmente hanno in molti – e non è un’idea semplice, non è banale.
Davvero? Son felice, è quello che voglio fare (ndr, Roberto lo dice subito, mentre io articolo la domanda, senza attendere la fine delle mie parole). Allora, sto cercando di imparare a disegnare. Mi impegno molto, ho fatto della grafica ma non ho studiato disegno, mi accanisco a cercare di imparare. Cercando di imparare, mi piacerebbe che qualcuno mi insegnasse davvero anche solo come si fa, a disegnare. Ma nell’aver sbagliato tutto io ho fatto una cosa: quando vedi i disegni non c’è e non c’è stata una cancellatura, non posso permettermi di cancellare. Io, ad esempio, so che di solito va fatta la matita e poi si va sopra con la china. Io vado subito con la china, parto con le biro, faccio un errore. Bisognerebbe lavorar meglio, ma io parto e arrivo. Sbaglio in partenza, insomma, però nel disegnare guardo molto. Mi ha ispirato tantissimo Schiele, perché Schiele ha l’efficacia nel segno. Cioè, quando guardi una cosa devi guardarla nel suo insieme, ma se ti soffermi… se vai a guardare, in Schiele c’è l’efficacia nel segno, puoi vedere un segno e quel segno è già narrativo. Non hai solo come uno ha fatto un disegno, ma vedi come lo ha affrontato la mano, che entra dentro con l’energia e poi rallenta, poi ancora si velocizza. Schiele, ma anche Pollock: sono quelli in cui tu puoi risalire al gesto. A me interessa tantissimo quello, sento che tanti me lo riconoscono, che oltre ad avere il disegno che funziona c’è nel particolare qualcosa di narrativo. Un ultimo nome è quello di un italiano misconosciuto, Sergio Toppi. Un fumettista, ha fatto delle cose da paura: ce lo invidia il mondo e non sappiamo cosa ha fatto. Ha disegnato molto e ha inventato uno stile di fare fumetto, incastra le cose, fa una cosa spaventosa. Sono loro che mi hanno ispirato, se devo pensarci: Schiele, Pollock, Toppi.
Una mia curiosità, per chiudere. Quando hai dovuto illustrare tutto Moby Dick c’è stato un momento in cui hai pensato di aver trovato un nodo del romanzo, una tavola che sentivi e senti come più intensa, significativa?
C’è una cosa che mi è stata chiara quando ho iniziato questo libro, un chiodo risolutivo. Era questo: quando ho pensato questo libro ho pensato al capitolo più corto del Moby Dick, che son tre righe, è il centoventidue, quello in cui si annuncia l’arrivo della tempesta. Ho avuto chiaro che avrei dovuto fare il disegno di un boccale da cui esce la tempesta, perché loro (la ciurma, ndr) chiedono il grog. Sapevo che la grafica dalla parte opposta, una sintesi filosofica del capitolo, doveva essere una cosa al contrario, dovevo mettere la tazza a rovescio. Ho avuto chiaro che doveva essere al contrario (Roberto la trova, la indica, ndr) e di fatto è stato ciò che mi ha condotto per tutto il libro. Tutte le cose hanno dentro il senso, il corpo adoperato. La prima che è nata, quella in cui ho detto «devo fare questa cazzata esagerata» è questa qui, al contrario. Tant’è che qualcuno mi scrive dicendo che il libro è perfetto, ma una pagina è al contrario. Se leggi il capitolo, eh, capisci perché è al contrario, c’è una tempesta in arrivo…
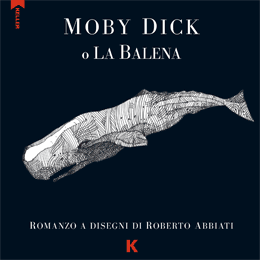 Roberto Abbiati, Moby Dick o la Balena. Romanzo a disegni, Keller, Rovereto 2018, 288 pp. 23,00€
Roberto Abbiati, Moby Dick o la Balena. Romanzo a disegni, Keller, Rovereto 2018, 288 pp. 23,00€