La narrazione della criminalità non implica l’esercizio di un potere dall’alto verso il basso, ma consiste nella circolazione di un discorso che si muove al confine tra diverse sfere (culturale, politica, sociale) e media (letteratura, cinema, giornalismo, televisione, podcasting). Raccontare il modo in cui il discorso sul crimine è alimentato e disseminato oggi in Italia è precisamente lo scopo di Tu uccidi. Come ci raccontiamo il crimine (effequ 2023), libro scritto a quattro mani da Antonio Paolacci e Paola Ronco, due autori che, dopo una carriera da solisti, hanno debuttato nel mondo del crime fiction nel 2019 con Nuvole barocche, il primo libro della serie dedicata al vicequestore Paolo Nigra. Questo non è, e lo sottolineano immediatamente gli autori, un libro che cerca di «sviscerare delitti reali per cercare di capire chi li ha commessi», né un testo che ha la presunzione di elaborare «spericolate teorie criminologiche, sociologiche o psicologiche sul perché le persone si ammazzino tra loro dalla notte dei tempi» (20). Vuole essere, invece, un’analisi attenta e puntuale delle modalità in cui il crimine è narrato oggi in Italia e delle loro implicazioni sociali, elaborata allo scopo di «capire molte cose del nostro tempo, e non solo» (21).
Tu uccidi è un libro circolare che prende avvio, nell’introduzione, da quella che possiamo genericamente chiamare narrativa criminale, e dagli stereotipi e luoghi comuni che l’accompagnano – la funzione apparentemente consolatoria e il paradosso, per alcuni versi tutto italiano, che associa delitto a intrattenimento – passando, nella parte centrale e più ricca del volume, attraverso la narrazione mediatica del crimine, per poi tornare, nella sezione conclusiva, alle possibilità e alle funzioni del romanzo. Da come si può intuire, Tu uccidi è un testo ambizioso, che si muove in multiple direzioni e tenta di dare ordine e senso a una materia complessa e sfaccettata. Il risultato, però, è molto ambiguo e altalenante. Alcuni degli aspetti sui quali si sviluppa il racconto del crimine in Italia, descritti in numerosi brevi capitoli introdotti rispettivamente da un caso più o meno recente di cronaca nera, sono esplorati con cura. Alla questione del razzismo, ad esempio, e al problema della rappresentazione dell’immigrazione e degli immigrati nei media è dedicato il giusto spazio, e gli autori sono bravi nel ricostruire le dinamiche sociopolitiche che nell’ultimo decennio circa hanno contribuito alla creazione di una narrazione (sull’immigrazione incontrollata e la mancanza di sicurezza nelle città) che elude ogni riflessione politica e socioeconomica (il crescente divario di classe, per esempio) e che ha lo scopo di creare sensazionalismo e alimentare un clima di panico e terrore su cui la destra populista ha banchettato con particolare gusto.
Nel complesso, però, Paolacci e Ronco vogliono fare troppe cose, affrontare un numero spropositato di argomenti diversi, il che avviene inevitabilmente in modo approssimativo, spesso parziale, che genera in ultima istanza confusione e frustrazione. Molte delle tematiche analizzate dagli autori – dalla dimensione storica (e non universale) della criminalità alla cultura giustizialista italiana, dal processo di alterizzazione del delinquente al problema dell’istituzione della polizia, sino agli stereotipi di genere con cui sono rappresentate le donne nella narrazione mediatica del crimine – contengono idee e spunti interessanti, ma sono investigate con eccessiva brevità, finendo per ridurre la complessità e quindi banalizzare fenomeni e meccanismi che meriterebbero, se non un volume a parte, quantomeno un’analisi più ordinata e coerente. C’è un problema in particolare su cui vorrei soffermarmi.
Riguarda quello che gli autori considerano uno dei temi fondamentali del libro, ovvero la sovrapposizione tra finzione e realtà nel racconto mediatico del crimine. Il saggio si interroga su come «il giornalismo nazionalpopolare» sia andato, quantomeno a partire dagli inizi degli anni Duemila, oltre il suo scopo informativo, adottando «un sistema propriamente narrativo» (41) che, oggi, troviamo anche in televisione, in radio, e nei podcast, dove giornalisti, commentatori e opinionisti di vario tipo «raccontano il crimine reale cercando di interessare, di avvincere, perfino di far appassionare a vicende narrate in modo accattivante» (48). Accade spesso, gli autori scrivono, «che la realtà venga interpretata e commentata come fosse fiction», cioè come una serie di storie in cui «i personaggi sono tagliati con l’accetta, le colpe sono totali e ben assegnate al mostro di turno, gli eventi si spiegano con facilità» (229). Questo approccio, che «punta sempre sulla retorica del caso isolato» (204), circoscrivendo e sensazionalizzando in modo del tutto arbitrario il singolo evento criminale, impedisce spesso l’inserimento dei vari ‘casi’ all’interno di un clima culturale, sociale e politico che, al contrario, permetterebbe uno sguardo d’insieme più ampio e fruttuoso. Il problema nasce quando Paolacci e Ronco, nel criticare questa narrazione, celebrano figure apparentemente virtuose come quella di Stefano Nazzi, giornalista e creatore del podcast de ‘Il Post’ Indagini e ad oggi la personalità più famosa e influente del true crime in Italia, senza porre alcun accento sull’enorme problema che l’Italia ha con questo tipo di narrazione. Se è indubbio che Indagini sia un prodotto virtuoso se paragonato al resto della concorrenza – che produce mostruosità come Demoni urbani o Non aprite quella podcast (che no, non andrebbe aperta) – è altresì vero che non sfugge del tutto a quelle dinamiche tossiche che gli autori denunciano in queste pagine. Laddove il racconto del singolo caso di cronaca nera non consista in giornalismo d’inchiesta (come Veleno di Pablo Trincia e Alessia Rafanelli), non sia usato per gettare nuova luce su casi il cui esito è ancora controverso (come Polvere. Il caso Marta Russo di Chiara Lalli e Cecilia Sala, il più grande podcast true crime in lingua italiana), o ancora, non rappresenti uno strumento per portare a galla dinamiche criminali fino a quel momento rimaste sopite (penso all’episodio dedicato al caso Elisa Claps proprio di Indagini), esso finisce per essere nient’altro che un racconto sensazionale, che genera ansia e curiosità spasmodica, non lascia nulla tranne il disgusto e impedisce quello sguardo d’insieme auspicato da Paolacci e Ronco. Il delitto di Desirée Piovanelli, uno degli ultimi raccontati da Nazzi in Indagini, è emblematico: non solo la vittima è sostanzialmente invisibilizzata, ma il clima culturale che si cela dietro il crimine rimane ai margini della narrazione, che è invece quasi esclusivamente occupata dal racconto del delitto nei suoi minimi, freddi, terrificanti, inascoltabili dettagli. Un episodio logorante e difficile da sostenere, che alla fine porta a chiederci: e dunque? A cosa è servito tutto questo? Una volta terminato l’ascolto, cosa ci raccontiamo? Oggi la narrazione mediatica della criminalità vede nel true crime una delle sue manifestazioni più importanti e influenti; la sua assenza, in questo libro, rappresenta una grave mancanza.
Tu uccidi, in conclusione, cerca di fare troppo e tutto insieme, in modo convulso e poco sistematico, perdendo di vista alcuni nodi fondamentali. Quel che più colpisce, alla fine, è che a mancare del tutto sono alcune possibili risposte ai problemi sollevati. Se «l’informazione sembra vivere di falsificazioni culturali molto più della narrativa di finzione», gli autori ci dicono nella conclusione, allora è solo il romanzo che può avere impatto sulla narrazione della realtà, grazie alla sua capacità di «andare a fondo» e «scavare nelle personalità» (275). In che modo la narrativa criminale italiana contemporanea fornisce queste risposte, però, resta inespresso.
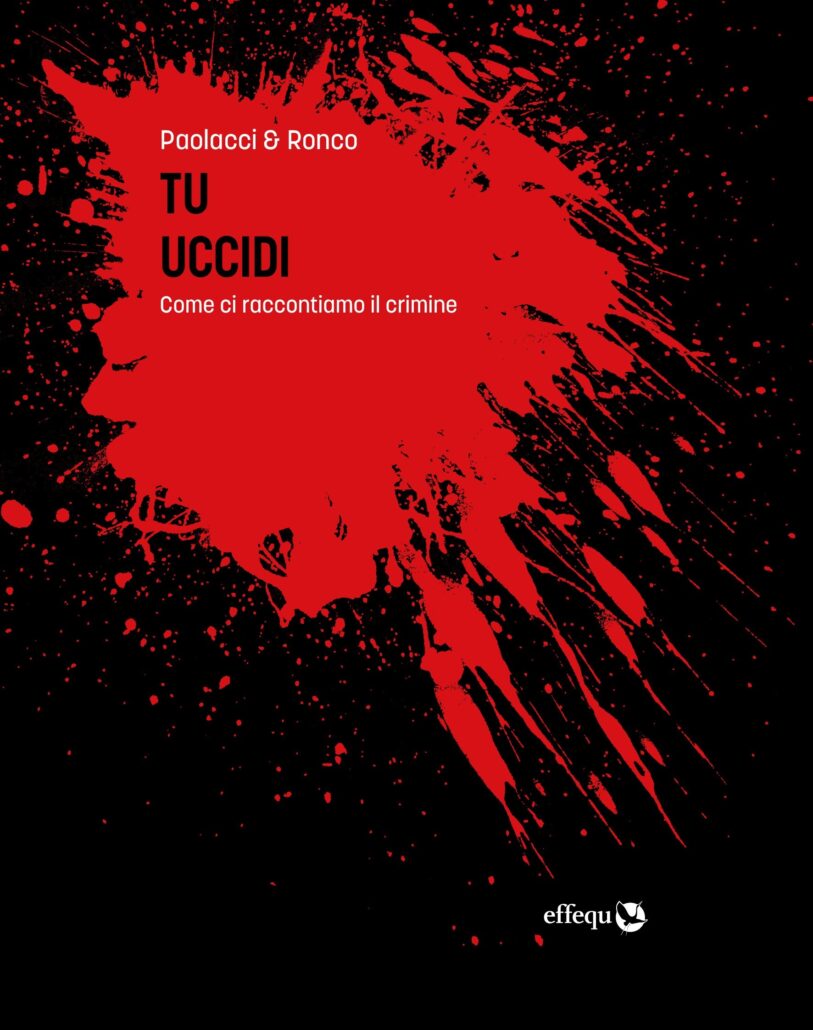
Antonio Paolacci e Paola Ronco, Tu uccidi: Come ci raccontiamo il crimine, Firenze, effequ 2023, 18 €, 291 pp.