Prosegue la presentazione dei libri finalisti del Premio Narrativa Bergamo 2024. Gli incontri con gli autori si tengono alla Biblioteca Tiraboschi di Bergamo per cinque giovedì di fila alle ore 18. Dopo Marco Rossari e L’ombra del vulcano, tocca domani a Tiziano Scarpa.
Ho scoperto Tiziano Scarpa durante gli anni dell’università e in particolare intorno al 2008-2009. In rete, dove da qualche tempo cominciavo a frequentare siti e blog letterari, era da poco esploso il “caso” del New Italian Epic, il memorandum con cui Wu Ming 1 dalle pagine di Carmilla aveva avanzato un tentativo di storicizzazione e raggruppamento critico di autori e autrici degli anni Zero, per individuare tratti comuni di alcune scritture. Si parlava di ucronie, di uscita dal romanzesco puro, di oggetti narrativi non identificati, di cultura convergente e di ritorno alla realtà dopo le sbornie postmoderne: l’attentato alle Torri Gemelle e i fatti di Genova avevano imposto agli scrittori e alle scrittrici di tornare a cimentarsi con la Storia, seppur con nuovi strumenti, con uno sguardo obliquo. Ne era sorto uno dei dibattiti più ricchi e validi che la storia letteraria recente possa annoverare in Italia, e si era svolto principalmente in rete, tra i post pubblicati dalle varie riviste e anche negli spazi dei commenti. Nel 2009 quel memorandum era diventato un libriccino per Einaudi, un pamphlet fatto in realtà di tre saggi distinti (dove prendeva la parola anche Wu Ming 2), e in maniera inaspettata il dibattito ne era stato in qualche modo rilanciato.
Proprio a seguito di quella pubblicazione, Tiziano Scarpa – già membro del gruppo fondatore di Nazione Indiana e poi tra i fuoriusciti fondatori del Primo amore – aveva pubblicato un lungo intervento di critica alle posizioni (e ai debiti non riconosciuti) di Wu Ming 1. Nel titolo di quell’intervento campeggiava una parola, parresìa – ovvero la necessità irrefrenabile di esprimersi e pronunciare la verità – che da quel tempo io sempre ho associato alla scrittura e alla postura autoriale di Tiziano Scarpa. Scarpa rimproverava a Wu Ming 1 di non aver colto un aspetto fondamentale di Gomorra e del lavoro di Roberto Saviano, che non aveva tanto a che fare con l’io autofinzionale di alcuni capitoli del libro, con le incongruenze narratologiche di alcune parti del racconto, quanto con il fatto che quell’io Saviano l’aveva poi portato nella realtà, trasformando la propria scrittura in un’azione concreta, mettendoci il nome, il cognome, la voce e il corpo, andando a dire le stesse cose che aveva raccontato nel libro nelle piazze e in televisione. Aveva letteralmente fatto un atto di parresìa, e in questo consisteva l’originalità e la grandezza del suo lavoro. Anche perché, secondo Scarpa, la portata di quel gesto era superiore, ed era figlia di un tempo nuovo.
Io penso (e lo sostengo da anni) che, nel momento storico in cui un enorme numero di persone si affaccia per la prima volta, grazie alla rete, alla possibilità di non solo esprimere opinioni, commentare l’attualità, fare controinformazione ecc., ma soprattutto compiere veri e propri atti linguistici, “fare cose con le parole”, dire la verità in faccia al potere, correndo un rischio nel gridare parresiasticamente che il re è un ladro, un criminale, un assassino, ebbene, in un momento simile è importante sostenere e potenziare il valore del coinvolgimento personale nel linguaggio attraverso i dispositivi che abbiamo per farlo, vale a dire i nostri nomi e cognomi (ed eventualmente, se e quando servono, le nostre facce e voci e immagini, e i nostri corpi fuori dalla rete, negli altri media e nel medium della comunicazione in presenza, dal vivo, faccia a faccia), pur essendo consapevoli di tutti i limiti e difetti e trappole che questi dispositivi contengono.
Per chi già conosceva Scarpa, non si trattava di posizioni sorprendenti. Fin dal suo romanzo d’esordio, Occhi sulla graticola (1994),e dal successivo Kamikaze d’Occidente (2003), Scarpa aveva sfruttato il dispositivo romanzesco per sviluppare riflessioni intorno al potere della rappresentazione (figurale e linguistica), alla sua performatività, alla sua capacità cioè di creare conseguenze, di generare azioni. E non è forse un caso che Stabat mater (2009), il suo libro più famoso – oltre che il più premiato – abbia goduto letteralmente di una seconda vita nelle letture pubbliche, nella sua mise en scène, attraverso una traduzione della parola scritta in parola recitata che è, per Scarpa, un ritorno all’origine più pura e più vera della parola e della letteratura.
Ce lo dice nelle pagine del suo ultimo romanzo, La verità e la biro (2023), dove rivela che la visione di un teatro risveglia in lui un sentimento dell’origine, provoca
un brivido alla radice neuronale di me stesso, dove ciò che sono si riconduce alla sua sorgente, la letteratura, il teatro, la parola scenica: la parola che prima è stata soppesata in solitudine, severamente vagliata, per essere, in seguito, condivisa; la parola intima ed esteriore, sia intima che esteriore, la parola in cui coincidono il massimo artificio e la massima autenticità (23).
E in effetti La verità e la biro è il libro in cui, più che mai, Tiziano Scarpa saggia il potere parresiastico della parola, a partire dal fatto che affida al libro stesso il compito di definirsi, di dire al lettore cosa abbia tra le mani. Non solo perché una serie di brevi capitoli che lo compongono descrivono le situazioni pragmatiche in cui Scarpa ha scritto effettivamente le pagine del libro (Da dove sto scrivendo), ovvero una breve vacanza estiva nell’isola greca di Kos insieme alla moglie; ma anche perché tra i capitoli del libro si trova anche una serie, minoritaria ma comunque significativa, intitolata Che cosa sto facendo in questo libro, e perché nelle ultime pagine troviamo una definizione affidabile e definitiva di quanto è stato squadernato lungo le pagine della Verità e la biro.
Che libro bizzarro ne uscirà. Non ho mai scritto niente di simile. Anche questa è una prima volta, oltre al nudismo e alla pietra pomice. Voglio proprio vedere come farò, rielaborando questo brogliaccio, a tenere insieme i tre fili che si intrecciano: l’ambientazione in vacanza, i ricordi di persone veridiche, le mie riflessioni. Fino a che punto potrò inoltrarmi senza sconfinare nell’astrazione? Voglio ricavare leggi generali ma senza annoiare, si deve sentire che resto sempre agganciato all’esperienza (210).
L’esperienza di cui parla l’autore in questo passo è quella autobiografica: quella relativa alla vacanza in Grecia, ma anche quella di numerosi episodi della sua vita privata in cui ha avuto a che fare con persone che hanno detto la verità (in un excursus che porta dagli incontri infantili con un prete potenzialmente pedofilo o con le matrone che si facevano fare il vestito dalla nonna, passando per l’esuberanza sessuale delle partner degli anni universitari, fino ai rapporti professionali della vita di scrittore). Perché La verità e la biro è un libro sulla verità («Il libro è cominciato. Di che cosa parla? Della verità», 4), sull’impossibilità di dirsi la verità, sugli artifici che spesso architettiamo per dire o per camuffare la verità, ma anche sulle situazioni in cui surrettiziamente la verità si impone. È a queste considerazioni che è dedicato il terzo filone del libro, quello più propriamente saggistico e che bilancia l’andamento aneddotico (seppur sempre virtuosisticamente riflessivo) delle altre due parti. Qui si discute la differenza tra attori e gladiatori nell’antichità (e si individuano gli eredi contemporanei dei gladiatori, parresiasti per eccellenza, poiché mettevano il loro vero corpo e la loro stessa vita nella messa in scena); qui si citano Leopardi, Molière, Savinio o Pavese; ma si ragiona anche – come detto – intorno all’essenza stessa del libro. Intorno al suo genere d’appartenenza.
Autobiografia o autofinzione? Da un lato, questo libro dichiara la propria sincerità, a partire dalla voluttuosa schiettezza con cui Scarpa ci racconta dettagli intimi e talvolta scabrosi della propria vita, mettendosi letteralmente a nudo e accettando di mettere in discussione la propria reputazione di fronte ai lettori:
La scrittura autobiografica, se è onesta, fa sì che l’autore si offra come zimbello collettivo, disprezzando ogni rispettabilità, che è il fondamento dell’impostura. Denigrando sé stesso, rovinando la propria reputazione, lo scrittore autobiografico manca di rispetto alla società (65).
Dall’altro lato, la letteratura occidentale degli ultimi vent’anni ci ha insegnato come, proprio trasformandosi in personaggi scandalosi, gli scrittori siano riusciti a conquistare l’interesse dei lettori, suggerendo loro che i fatti inventati che stavano leggendo potevano, in ultima ipotesi, anche esser veri; facendoli piombare cioè nel dubbio costitutivo dell’autofiction. Ma basta in realtà molto meno per ammettere un pur minimo grado di finzione, o almeno di invenzione che ogni scrittura presunta autobiografica si porta con sé.
L’autofinzione, lo riconosco, è inevitabile perché non c’è mai una verità completa: la finzione sta nel fatto che ogni inquadratura ritaglia e lascia fuori molte cose: ogni inquadratura è, per ciò stesso, un’esquadratura, una estromissione di tutto il resto. L’autofinzione consiste non tanto nell’inventare cose mai successe, ma nella quantità di reticenza che ogni dicitura contiene, nelle informazioni che tralascia (76).
Ci stiamo avvicinando al nocciolo duro di questo libro, al suo punto di collasso. Dire la verità sembra impossibile: lo scrittore che voglia affrontare i propri demoni, ma salvaguardare anche l’incolumità dei propri cari, rivelerà verità indicibili sotto mentite spoglie, e facendo così mentirà; chi invece limita il raggio d’azione della propria scrittura, semplicemente escludendo dal racconto alcuni aspetti della sua vita sta, automaticamente, ricostruendo una realtà di comodo che non corrisponde alla verità completa. Forse, suggerisce Scarpa a un certo punto, il desiderio inconscio di ogni lettore, ma anche di ogni scrittore, è «che a scrivere sia la realtà stessa; ci si aspetta che sia il mondo a esprimersi, e che le parole parlino da sé, senza un autore che le piloti e le dirotti a suo piacimento» (104). Perché, come nel principio di indeterminazione di Heisenberg, chi procede alla misura (in questo caso lo scrittore che rendiconta la realtà) ne altera necessariamente i parametri con il proprio intervento, rendendo così la misurazione quantomeno parziale.
(Già nel Brevetto del geco, del 2015, Scarpa aveva cominciato a inoltrarsi lungo questa china affidando il ruolo di narratore a un feto mai nato, «l’Interrotto», che compensava la mancanza di esperienza della vita attraverso un’attenzione smodata ai dettagli, anzi diventando i dettagli stessi, in una completa sovrapposizione tra chi racconta e le parole che raccontano).
Se nessuna narrazione autobiografica potrà essere completamente vera, allora, la verità che tanto sta a cuore a Scarpa sarà da cercare altrove, non nella dimensione referenziale, bensì in quella linguistica, o meglio scritturale. Il vero oggetto di questo libro, potremmo quindi dire è la verità della scrittura, la verità tracciata dalla biro, come ci dice il titolo. E con ciò torniamo alla questione della parresìa e al potere della parola di “fare delle cose”. Procedendo per via aneddotica, frammentaria, scomposta, il discorso di Scarpa si avvicina lentamente al suo orizzonte: i diversi episodi di rivelazione epifanica della verità, il passaggio attraverso le verità desiderabili e quelle grottesche (dalla studentessa di filosofia che candidamente ammette che non capirà mai il membro maschile fino al caporedattore che altrettanto candidamente confessa a Scarpa di non poterlo assumere perché sta riservando il posto di redattore per il figlio), così come i tanti flash autoriflessivi dalla vacanza in Grecia (ovvero le sedute di scrittura ai tavolini dei bar o sulle sedie a sdraio, fino alle illuminanti sequenze di autoscopia del pene durante una giornata in una spiaggia per nudisti) rappresentano le tappe di un percorso necessario a mettere a fuoco qualcosa che l’autore ha sempre saputo ma che ora comincia a comprendere.
Rincorrevo il pensiero con la scrittura; pensavo, e il mio pensare procedeva alla velocità della scrittura; e tutto ciò lo tematizzavo: ho scritto a mano innumerevoli pagine sviscerando l’argomento a mano. […] Non si scrive alla velocità del pensiero, è impossibile. Semmai si pensa col pensiero che va alla velocità della scrittura, e mentre lo si fa si scopre quanti altri pensieri paralleli si producono in quel mentre; tutti i pensieri simultanei all’unico che sto scrivendo adesso (96).
La scrittura, soprattutto quella praticata a mano, serve a sintonizzarsi con il ritmo dei propri pensieri, a catturarne il battito e a inseguirlo per vedere dove porta. La verità della scrittura consiste in un «procedere dentro un paesaggio che si inabissa in un dimenticatoio» (97); ma da questo paesaggio la scrittura permette di riemergere, perché illumina quel che rimane solitamente nelle periferie oscure della mente, interpellato da lontano, chiamato a dare risposte generiche, fioche.
fosse per me passerei le giornate a raccontare ciò che vivo, ciò che vedo, ciò che imparo, ad analizzarlo, anche perché scrivere è il modo in cui io conosco le cose, le capisco solo così. Se mi limitassi a pensarle mi accontenterei di vaghe intuizioni, magari anche acute, ma scriverle mi dà molto di più, perché mi costringe ad articolarle e ramificarle, e soprattutto perché scopro i miei pensieri mentre li scrivo, grazie al fatto che li scrivo. Scrivo per sapere che cosa ne penso del mondo. Ma interessa, al mondo, sapere che cosa ne penso di lui? (193).
L’unica verità possibile, quindi, è quella del momento in cui si scrive, quella che consegniamo istantaneamente alla pagina; ed è una verità che si rivela scrivendo e che prima non possedevamo. È l’unica verità perché non può essere sottoposta alle inquadrature e alle esquadrature della narrazione, ai calcoli di un discorso argomentativamente efficace, al pudore o all’impudicizia delle scritture autobiografiche. Si tratta di una verità completa e però intima.
La domanda su cui si chiude la citazione precedente («Ma interessa, al mondo, sapere che cosa ne penso di lui?») non è banale, perché contiene una perplessità che può toccare il lettore di questo libro e che interpella Scarpa, scrittore malizioso, ma anche onesto e consapevole. Poche pagine prima, ragionando intorno al Misantropo di Molière, egli osservava come la commedia ci mostri che dire la verità, come il protagonista Alceste, allontana le persone, isola ed emargina. Dire la verità porta alla solitudine e così finisce che «Chi ama la verità odia gli uomini. Amare il genere umano significa odiare la verità» (184).
Senza perdere il proprio spirito provocatore e teppistico (attraverso un linguaggio sempre esuberante, sorprendente per come coniuga inventività e puntualità), Scarpa ci consegna un libro anomalo, frammentario, antiromanzesco e illuminista nel suo didascalismo, sterniano in qualche senso, attraversato dall’ossessione di tenere il passo della vita, di raccontare ciò che si è e ciò che si fa in ogni momento – o almeno in certi momenti – per verificare le potenzialità della scrittura. Ma a poco a poco le trovate, gli espedienti utili ad arpionare la curiosità del lettore – le ricorrenti incursioni nelle lande dell’erotismo e della corporeità, gli aneddoti utili a suggerire la potenzialità del racconto – lasciano spazio alla nuda anima del libro. Il desiderio di usare la scrittura come sonda per esplorarsi, ma anche la paura di ritrovarsi soli alla fine del viaggio.
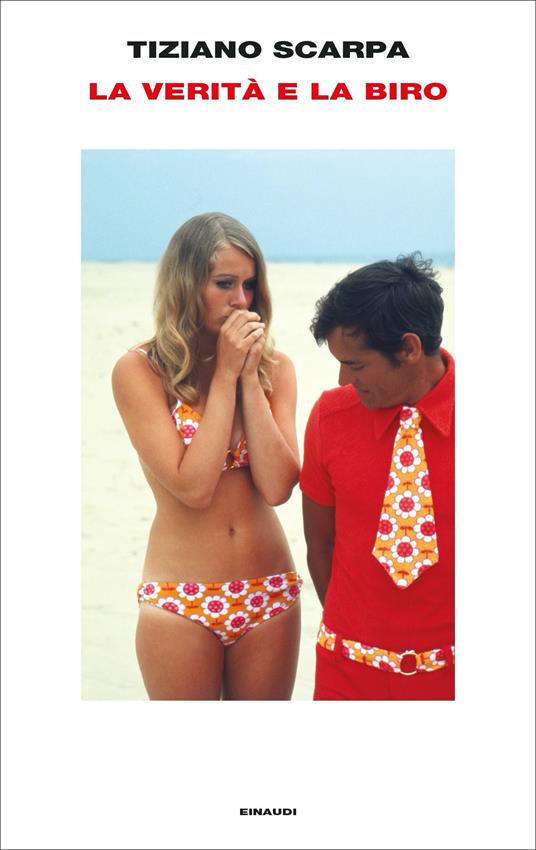
Tiziano Scarpa, La verità e la biro, Einaudi, Torino 2023, 232 pp. 18,50€
