Questa storia comincia come una poesia con una intuizione nella testa di uno scrittore. Siamo negli anni Quaranta, in Italia. La testa poggia su Elio Vittorini: dal momento che non può recarsi in America, sarà l’America a venire da lui. Come ogni buona intuizione, è infiammata dalla febbre. «Sto leggendo tre volumi al giorno: per l’antologia» scrive a Bompiani (5 maggio 1940). Al lavoro, accanto a Vittorini, c’è una intera schiera di traduttori a «12 lire a pagina»: Giansiro Ferrata, Enrico Fulchignoni, Piero Gadda Conti, Carlo Linati, Eugenio Montale, Alberto Moravia, Umberto Morra, Cesare Pavese e Guido Piovene. L’impresa è gigantesca: proporre ai lettori trentatré scrittori americani, alcuni dei quali ancora inediti, per un totale di quarantotto testi. Purtroppo però nemmeno una squadra così composta poteva evitare la squadriglia censoria della «Commissione per la bonifica libraria». Quando la raccolta è pronta, Alessandro Pavolini, ministro della cultura popolare, ferma Bompiani: «Resto però del mio parere, e cioè che l’uscita – in questo momento – dell’antologia americana non sia opportuna. Gli Stati Uniti sono potenzialmente nostri nemici; il loro Presidente ha tenuto contro il popolo italiano il noto atteggiamento. Non è il momento per usare delle cortesie all’America, nemmeno letterarie. Inoltre l’antologia non farebbe che rinfocolare la ventata di eccessivo entusiasmo per l’ultima letteratura americana: moda che sono risoluto a non incoraggiare» (Roma, 7 gennaio 1941).
L’antologia Americana, appena ripubblicata da Bompiani (2023) nella sua veste originale e con tanto di copertina d’epoca, arricchita da un contributo di Giuseppe Zaccaria e da un interessante epistolario in appendice che evidenzia gli scambi principali di questa vicenda, uscirà mutilata in accordo col regime solo nel 1942, aperta da una introduzione dell’accademico d’Italia Emilio Cecchi in sostituzione delle introduzioni critiche di Vittorini a ciascuna sezione. Che non erano solo una parte del libro, ma il suo senso. La voce nel coro. L’edizione ritirata invece circolerà clandestinamente riuscendo comunque a influenzare i pochi addetti ai lavori, per cui si potrebbe parlare di due facce dell’Americana, una pubblica e una radicata, se così scriveva Cesare Pavese: «Caro Vittorini, ti sono debitore di questa lettera perché penso ti faccia piacere sentire che siamo tutti solidali con te […] e tutto il pregio e il senso dell’Americana dipende dalle tue note. In dieci anni dacché sfoglio quella letteratura non ne avevo ancora trovata una sintesi così giusta e illuminante. Voglio dirti questo, perché certamente quando le tue note correranno il mondo in Piccola storia della cultura poetica americana, salterà su chi rileverà che esse sono estrose sì ma fantastiche» (27 maggio 1942, p. 12).
Per capire come mai il vero obiettivo della censura del regime fossero le note di Vittorini, basta aprire il libro e leggerne le prime righe:
«Anche in una storia della letteratura americana la prima parola che ci venga in mente, e si fermi davanti a noi, e ci fermi, è quella stessa della terra. Come, pressappoco, se si trattasse di storia politica. E di più, forse. Perché mentre una storia politica non ha in sé, di solito, la storia della letteratura, una storia della letteratura ha sempre in sé la storia politica, è quella, questa, tutte insieme le storie, e, insomma, la storia per eccellenza dell’uomo nell’una o nell’altra cornice prescelta di spazio e di tempo. Dunque è America che diciamo» (p. 23).
Idea di una indipendenza impegnata questa che Vittorini custodirà anche nella diatriba con Togliatti negli anni del «Politecnico». Facciamo però un passo indietro. Alla fine degli anni Trenta, quella tra il curatore e Bompiani nasce come collaborazione occasionale. È l’editore a farsi avanti, pur sapendo Vittorini occupato alla Mondadori, chiedendogli alcune traduzioni dagli States «ma dando precedenza ai libri di valore che a quelli di successo» (Milano, 25 aprile 1938). C’è una stima reciproca che si evince in ogni lettera e che porterà il primo ad appoggiare il progetto del secondo, pur sapendolo pericoloso. Emilio Cecchi, dal canto suo, pure invitato a collaborare occasionalmente, così punzecchiava Bompiani: «Ma il fatto è che da noi i libri da tradurre vengono scelti con criteri talmente curiosi» (Roma, 31 ottobre 1938). La risposta è una lezione di editoria: «Accade talvolta che i critici attribuiscano a sé stessi delle opinioni e all’altra parte soltanto dei criteri d’affari (che è un modo tanto pericoloso quanto gratuito di considerare il lavoro altrui» (Milano, 16 novembre 1938). Ancora nessuno sapeva che presto avrebbero avuto ciascuno bisogno della voce dell’altro.
Cecchi e Vittorini non potevano avere uno sguardo più diverso sulla letteratura americana. A spaventare l’accademico d’Italia è il pericolo dell’imitazione, anche se bisogna ammettere che su alcune rare questioni stilistiche lo sguardo critico fosse stato predittivo, come quando lamentava che «I guai, per esempio, che doveva combinarci il capriccioso “dialogato” di Hemingway». In generale però, l’invito alla lettura di Cecchi non è affatto invitante ed è chiaro come mai il regime avesse preferito una direzione simile:
«Trenta anni fa era stato abdicato all’ineffabile dell’anima slava; ora si abdicava all’ineffabile dell’anima americana. Ed incominciava un nuovo baccanale letterario. Perché da incontri così bagordi e banali, è impossibile poi che non scoppi e si propaghi la scarlattina dell’imitazione. Il male, come abbiamo accennato, non era tanto che vennero tradotti troppi americani contemporanei; ma che furono tradotti disordinatamente, senza scelta; e spesso troppo all’ingrosso […] E se ne produsse, fra l’altro, un influsso di cotesta prosa d’America su taluni strati della prosa nostra: un influsso tutto al peggio; cosicché a volte non sai se ridere o piangere. Se ne produsse, in racconti e novelle, una sorta di scrittura spaesata, astratta, nevrastenica, improbabile; che sembra anch’essa a sua volta tradotta, malamente, da una qualche cattiva letteratura di paesi ambigui, dove ogni cosa, anche il linguaggio e la poesia, nasca di seconda mano» (p. 1258).
Vittorini invece, che peraltro l’America non l’aveva mai vista, ne costruisce una poetica:
«L’America, in questa leggenda, è una specie di nuovo Oriente favoloso, e l’uomo vi appare di volta in volta sotto il segno di una squisita particolarità, filippino o cinese o slavo o curdo, per essere sostanzialmente sempre lo stesso: “io” lirico, protagonista della creazione. Quello che nella vecchia leggenda era il figlio dell’Ovest, e veniva indicato come simbolo di uomo nuovo, è ora il figlio della terra. E l’America non è più America, non più un mondo nuovo: è tutta la terra. Ma le particolarità vi giungono da ogni parte, e vi si incontrano […] e dà la prova estrema di come la letteratura americana, carica ormai dell’istinto di ogni razza, sia una letteratura universale in una lingua sola» (p. 1162).
Sebbene l’antologia accolga testi narrativi – perlopiù racconti, ma anche romanzi brevi come Billy Budd di Melville o addirittura stralci tagliati da romanzi come nel caso di John Fante – il fatto che quella americana non sia una letteratura nazionale, ma universale e in grado di raccontare a nome di tutto il mondo, per via della mescolanza di popoli che la abitano e della vastità del continente, porta Vittorini a considerare ogni scritto che attraversa l’Oceano come poesia. Una posizione pregiudizievole in un continente preda dei regimi come quello europeo. Per di più, con una beffa finale per il regime: l’antologia si chiude con John Fante, figlio di un emigrante italiano, che simboleggia al meglio la continuazione della «leggenda».
Sebbene nella sua versione originaria sarà pubblicata solo nel 1968, Americana è stata il primo vero ponte che ci ha attraversato e che abbiamo attraversato verso la letteratura statunitense, e i giudizi critici di Vittorini hanno pesato sulla critica successiva per molto tempo. Una testimonianza personale: mi sono imbattuto per la prima volta nell’antologia quando lavoravo a F. Scott Fitzgerald e l’Italia (Ladolfi, 2018). Vittorini considerava Fitzgerald come uno scrittore minore, perché negli Stati Uniti era da molto tempo dimenticato, tanto da inserirlo nella cornice degli «Eccentrici, una parentesi» assieme a Evelyn Scott, Kay Boyle e Morley Callaghan. È Hemingway invece lo scrittore che incarna al meglio la leggenda. Fitzgerald sarà riscoperto solo da Cesare Pavese e soprattutto da Fernanda Pivano, che ne tradurrà quasi integralmente l’opera. Eppure… eppure durante la stesura della monografia mi sono imbattuto in alcuni articoli come Un giovane americano non inferiore a Hemingway (Luigi Berti sulla «Fiera Letteraria», 1953) scoprendo che tutta la critica italiana intorno a Fitzgerald per esistere ha avuto prima bisogno di smontare il giudizio critico di Vittorini. Ancora alla fine degli anni Quaranta, Pavese rifletteva sull’eredità di quell’esperienza: «La fama americana di Vittorini ti ha fatto invidioso? No. Io non ho fretta. Lo batterò sulla durata. In fondo Vittorini è stato la voce (anticipata – questo è il grande) del periodo clandestino […] Ha presentito l’epoca e le ha dato il suo mito» (29 dicembre 1949, da Il mestiere di vivere, Il Saggiatore, 1974). Proprio come aveva fatto Fitzgerald, con l’età del jazz.
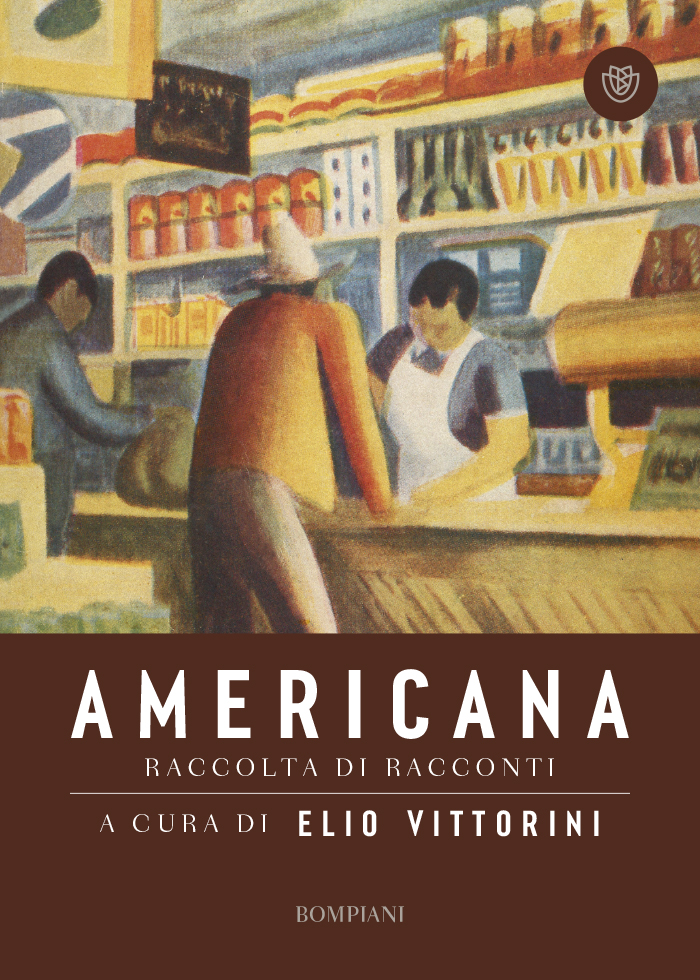
Elio Vittorini (a cura di), Americana: Raccolta di racconti, Milano, Bompiani, 2023 [1941], 30€, 1296 pp.