Per quanto pervasiva possa essere la penetrazione della cultura pop americana nell’immaginario collettivo in Italia, ogni appassionato di storie “made in USA” si trova occasionalmente a doversi confrontare con elementi dissonanti, se non addirittura alieni. Come fa la gente a cenare alle quattro? E non si annoiano, quando giocano a baseball, a stare tutto il giorno fermi sotto il sole?
Tra le differenze culturali che separano Stati Uniti e Italia – paesi per altro, in altri ambiti, estremamente affini – una che ho sempre trovato difficile da comprendere è il fascino di cui è avvolta, nella cultura pop americana, la figura del gangster. Il mafioso, come d’altronde il pistolero del Far West prima di lui, è spesso rappresentato come un antieroe che, per quanto spregevole, è impossibile non ammirare. Una persona (ma in realtà quasi sempre un uomo) che ha saputo ritagliarsi una fetta di successo ignorando i dettami della società, plasmando il mondo come più preferisce. La rappresentazione estrema, spietata, ma anche più completa, del sogno americano.
La figura del mafioso in Italia appare invece priva di quest’aura di glamour. (Una parentesi necessaria andrebbe dedicata all’esplosione della musica rap negli ultimi dieci anni e alla popolarità, all’interno di questo genere, di poetiche che rimandano al mondo del crimine – poetiche importate, per altro, spesso verbatim dagli Stati Uniti). La mafia nella narrativa italiana è spesso investita di connotazioni mostruose che la identificano come parassitaria e predatoria rispetto alla società: un’attitudine, questa, paradossalmente puritana e non priva di problematiche specifiche, quali il livellamento del piccolo spacciatore col criminale di carriera, o il presupposto, quantomeno ingenuo, che il crimine organizzato sia un fenomeno del tutto estraneo allo Stato.
Le storie di gangster americane sono inoltre spesso contraddistinte da una forte carica etnica. Il criminale è il più delle volte parte di una comunità ancora legata alle proprie origini transatlantiche (si veda l’immenso filone dei film e serie TV di successo sulla mafia italo-americana), o è membro di comunità afroamericane o latine. In tutti questi casi, il gangster si trova ad esacerbare certi pregiudizi radicati sui non-bianchi, o almeno non-WASP (White Anglo-Saxon Protestant): l’idea di fondo che queste persone siano meno civilizzate dell’America più “pura”, e incarnino quindi modelli di vita più violenti, disonesti, viscerali. Un’ideale che inevitabilmente affascina, proprio come la figura stessa del gangster, in proporzione diretta a quanto repelle.
La trilogia di Harlem di Colson Whitehead – comprendente per ora Il ritmo di Harlem del 2022 e Manifesto criminale del 2023, entrambi editi in Italia da Mondadori e tradotti da Silvia Pareschi – ha molto da dire su queste due dimensioni (quella del self-made man e dell’elemento razziale) così fondamentali per il genere del romanzo criminale. Whitehead è maestro nello scrivere romanzi all’apparenza bene inseriti in uno specifico genere (dall’apocalisse zombie di Zona uno al fantasy surreale della Ferrovia sotterranea), ma che usano le regole di questi generi per sorprendere il lettore e per commentare determinate attitudini e pregiudizi propri sia della letteratura che della vita più ampia. Un “judo letterario” simile a quello per cui brillano, tra tanti autori, Jennifer Egan, Jonathan Lethem, e Michael Chabon.
Invece di concentrarsi su grandi e spietati criminali di successo, la trilogia di Whitehead si focalizza su una manciata di personaggi obbligati a confrontarsi con il mondo del crimine all’interno della propria comunità: la Harlem anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, affamata ed espansiva ma anche ammorbata da violenza, povertà e degrado. Protagonista chiave della trilogia è Ray Carney, proprietario di un negozio di mobili: una professione non certo eccitante, ma trasformata in vera e propria vocazione dalla passione e dalla serietà professionale di Ray (chiamato sempre Carney dal narratore, come a prenderne le distanze nella chiave ironico-procedurale tipica del noir). Nei suoi dialoghi con i clienti – tutti membri della comunità di Harlem – Carney non sembra voler vendere loro solo un divano o una poltrona, ma un intero ideale di vita: una misura di comfort e dignità in un mondo altrimenti ingiusto e umiliante.
Ma Carney, come d’altronde pressoché tutti i personaggi che popolano la Harlem di Whitehead, conduce una seconda vita nascosta dietro alla prima, una che segue regole non scritte, ma ferree e ineluttabili come quelle del mondo straight, onesto. Carney è un ricettatore, abile nell’aiutare ladri e svaligiatori a liberarsi della propria mercanzia. È un ruolo che compie con un misto di esitazione e orgoglio: un lavoro a cui è costretto temporaneamente, dalle circostanze, ma che svolge con la stessa professionalità con cui gestisce il suo negozio di mobili. Di certo Carney non si considera un criminale come suo cugino Freddy, a cui è molto legato, o come suo padre, “Big Mike”, figura burbera e violenta scomparsa da molti anni la cui ombra non è però mai lontana dai suoi pensieri.
Sia Il ritmo di Harlem che Manifesto criminale sono divisi in tre parti ciascuno, con ciascuna sezione costruita a tutti gli effetti come una storia noir autoconclusiva. Gli stessi personaggi ricompaiono in diverse “storie”: oltre a Carney ritroviamo Pepper, veterano del crimine (e della Seconda Guerra Mondiale) e vecchio socio di Big Mike; Zippo, un piromane con aspirazioni artistiche la cui mente e le cui ossessioni sono esplorate da Whitehead in alcuni dei passaggi più virtuosistici, e più toccanti, della saga; Munson, poliziotto corrotto e spietato ma con uno strano quanto distorto codice morale.
Tutti gli ingredienti, insomma, per un racconto di qualità, mescolati sapientemente da Whitehead per creare avventure avvincenti, mozzafiato e soprattutto esilaranti: impossibile leggere certi passaggi e dialoghi senza scoppiare a ridere. I personaggi della trilogia di Harlem vedono i propri piani sfuggire di continuo al loro controllo, ritrovandosi in breve tempo in situazioni disperate da cui solo un miracolo, o un magistrale colpo di scena, riuscirà a salvarli.
Mettendo da parte il piacere, per altro mai da sottovalutare, che deriva da una storia ben orchestrata, la trilogia di Harlem potrebbe all’apparenza sembrare uno sforzo “minore” per Whitehead. Un tentativo di mettere il freno dopo due romanzi come La ferrovia sotterranea e I ragazzi della Nickel che hanno entrambi ottenuto un enorme successo di critica (tra i numerosi premi ricevuti ricordiamo il Pulitzer vinto da entrambi), e che, pur non essendo privi di momenti di tenerezza e persino ironia, si occupano di argomenti macabri e devastanti: nel primo caso, la schiavitù nell’America del diciannovesimo secolo; nel secondo, la storia vera, e ben più recente, di un riformatorio giovanile in Florida, sede di numerosi episodi di violenza, razzismo istituzionale e soprusi. Whitehead stesso, in un evento a cui ho avuto modo di assistere a Bristol, ha riconosciuto come in molti potrebbero obiettare (e hanno infatti obiettato) all’idea di far seguire due romanzi “seri” con una trilogia di genere. Lo scrittore ha ammesso che la trilogia di Harlem, originariamente pensata come un unico romanzo, gli ha permesso di indulgere alla sua passione per la comicità, che ha avuto necessariamente poco rilievo nei suoi lavori recenti.
Sarebbe tuttavia sbagliatissimo bollare la trilogia come frivola. Il tono di questi romanzi, infatti, non è mai spensierato e i loro momenti di leggerezza sono quelli che si concedono i personaggi in un mondo in cui il loro paese – tramite il razzismo sistematico di polizia e istituzioni – può toglier loro la vita in qualsiasi momento: un piacere, per sua natura, sempre sospeso e dolceamaro. L’umorismo di Whitehead è quello tipico della tradizione noir, potente perché irriverente, e irriverente poiché conscio dell’ingiustizia e corruzione intrinseche alla vita e alle istituzioni moderne.
La grande differenza tra Il ritmo di Harlem e il suo seguito è che nel primo romanzo Carney fa del suo meglio per restare a galla in un mondo in cui il crimine è impossibile da evitare: i suoi cari, primo fra tutti il cugino Freddy, lo trascinano di continuo in trame losche e pericolose, quando non ci pensano le forze dell’ordine a costringerlo a pagare il pizzo. Già a tratti, in questo romanzo, si notano i primi accenni dell’orgoglio di Carney: una traccia, forse, del padre Big Mike nel suo carattere altresì mite. Ma i suoi obiettivi primari rimangono sopravvivere, far crescere il suo business (legittimo), e migliorare le condizioni di vita della sua famiglia.
Del tutto diverso il tono di Manifesto criminale, la cui prima parte, “Ringolevio”, vede Carey reimmergersi di sua spontanea volontà nel mondo criminale dal quale era rimasto fuori per qualche anno, per altro con successo: un bell’appartamento in una zona bene di Harlem, un business avviato, un intero edificio acquistato come proprietario. Il motivo del suo ritorno? Ottenere a tutti i costi un biglietto per il concerto dei Jackson 5 al Madison Square Garden, tanto anelato da sua figlia.
Amore paterno a parte, la storia della ridiscesa di Carney è tanto avvincente quanto ben nota. È la storia di una persona arrivata al successo dal niente, e ormai incapace di accontentarsi del proprio status. È questo, generalmente, il punto in cui le storie di crimine arrivano a quella specie di cortocircuito morale che molta narrativa di crimine americana affronta col tono sprezzante accennato in apertura. Se è facile simpatizzare con un uomo costretto dalle circostanze a una vita disonesta, è possibile fare lo stesso quando queste scelte derivano da avarizia e sete di potere?
Manifesto criminale è conscio di questo dilemma, e mette a confronto Carney con le conseguenze di alcuni degli schemi criminali più comuni in città: ad esempio quello degli incendi appiccati ai palazzi in disuso per riscuoterne l’assicurazione. Incendi, questi, spesso non privi di vittime: senzatetto e disperati nascosti negli edifici in rovina, o bambini accampati per gioco al loro interno. Questa nuova cognizione delle vittime innocenti che il crimine si lascia inevitabilmente alle spalle spinge Carney a indagare sul suo passato, o meglio su quello del padre, anch’egli occasionale piromane “a pagamento”. Ciò che emerge dall’indagine è un mondo fumoso in cui ciascuno si tiene stretto il proprio codice morale, disprezzando chiunque non segua le stesse regole. Un modello, insomma, molto americano – individualista e diffidente di qualunque istinto collettivo – ma che Whitehead non sfrutta nel nome di facili fantasie di potere, quanto piuttosto espone in tutta la sua parzialità e fragilità.
Manifesto criminale si conclude dunque in una posizione chiave nella parabola di Carney: il momento in cui abbraccia il potere di cui può usufruire nel mondo criminale di Harlem, e al contempo si rende conto del terribile impatto che tale potere inevitabilmente esercita sulla vita della sua comunità. Spetterà al terzo capitolo della saga, ambientato negli anni Ottanta, concludere la trilogia e porre l’ultima parola sull’evoluzione del suo protagonista. Dopo aver concluso Manifesto criminale è impossibile non provare un grande appetito per questa conclusione: non soltanto per l’ovvio piacere narrativo che ogni libro di Whitehead assicura, o per gli accenni, sottili quanto inquietanti, con cui il romanzo getta le basi per il suo sequel, con riferimenti alla nascente industria elettronica e alle nuove droghe che si preparano ad invadere le strade cittadine. Il finale della saga si fa attendere come decisivo perché, inevitabilmente, darà una chiave di lettura all’intera parabola di Ray Carney. Finirà come un Macbeth di Harlem, un eroe corrotto incapace di accontentarsi del suo potere? Sarà schiacciato da quelle forze più grandi di lui dalle quali è finora riuscito a salvarsi, anche se per il rotto della cuffia? E che tono darà, tutto questo, ai grandi temi della vicenda – la corruzione della vita cittadina, l’ingiustizia inevitabile che vede i potenti sempre vincitori, la necessità di obbedire a un codice morale interiore in mancanza di un ordine stabile (e in presenza anzi di un ordine costituito apertamente ostile)?
Le storie di crimine rimangono un genere di grande successo anche perché toccano alcuni dei temi “difficili” dell’esistenza: dalle disparità sociali all’ingiustizia, fino alla grande questione del Male. Come sempre davanti alla complessità, l’istinto più immediato è quello di trovare una spiegazione semplice e facilmente digeribile, come il modello, abbracciato da tanta narrativa americana, del criminale come grande anti-eroe (o il perbenismo ipocrita di molta fiction televisiva italiana). Spetta all’arte, anche e soprattutto popolare, andare oltre le semplificazioni, e gettare luce sulle innumerevoli contraddizioni dell’esistente, oltre che sui motivi (insieme comprensibili ed egoistici, naturali ed imperdonabili) che possono spingere un mite commerciante di mobili verso la vita di crimine dalla quale si era ripromesso di fuggire.
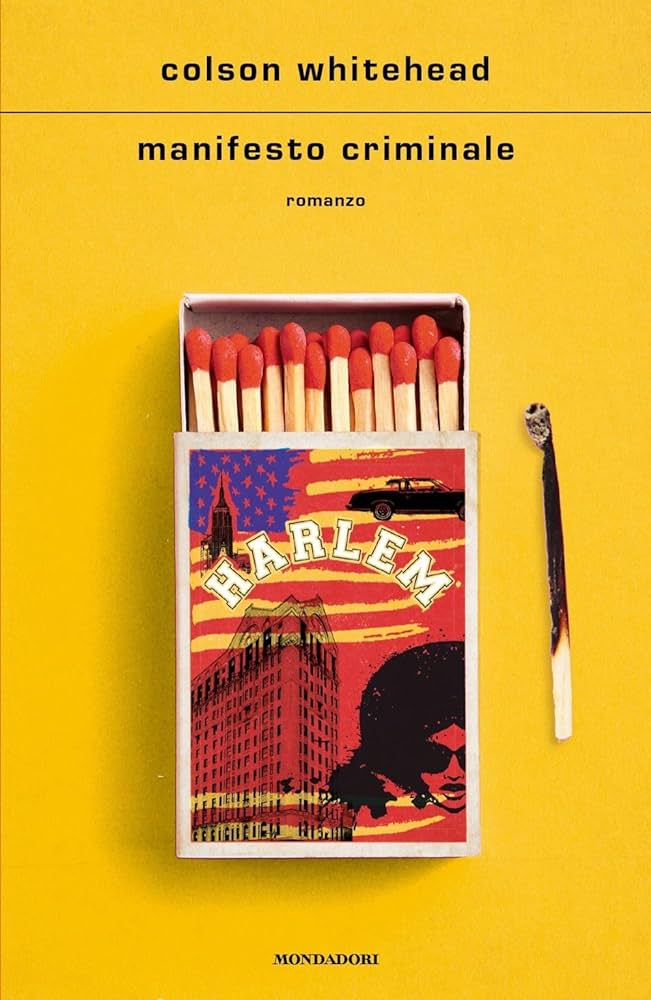
Colson Whitehead, Manifesto criminale, traduzione di Silvia Pareschi, Milano, Mondadori, 2023, 22 €, 384 pp.