Guardando agli esiti più recenti del percorso poetico di Massimo Gezzi, tra Il numero dei vivi (Donzelli, 2015) e Sempre mondo (Marcos Y Marcos, 2022) sembrano manifestarsi coerenza e continuità di sguardo e di pensiero: questa rilevazione, mi pare, trova una possibile conferma nei primi due dei cinque versi affidati all’evidenza della quarta di copertina dell’ultima raccolta di Gezzi: «di nuovo tentano gli altri || di esistere, di affrancarsi dal silenzio […]». Il testo menzionato è quello che chiude il volume (elemento, questo, che già di per sé ne lascerebbe supporre il peso specifico nell’economia complessiva del lavoro). È indicativo che, subito oltre il lacerto citato, agli altri (anzi: in relazione agli altri) subentri subito un noi. Il testo, peraltro notevole, è articolato con una strategia sapiente – ammesso che di strategia si possa parlare: con un progressivo restringimento dell’obiettivo, Gezzi muove dal generale al particolare, dall’universale («il male [che] | | incrudelisce poi passa») ai destini di creature comuni, che sono “tutti” anche restando anonime. “Altri” che, peraltro – a proposito di possibili continuità – assomigliano al “voi” cui Gezzi si rivolgeva in un testo de Il numero dei vivi (Discorso ai nuovi vicini): figure prossime, quotidiane. Là erano visualizzate «[…] nel rito | del risveglio sotto un unico | tetto che sembra casa e non lo è», qui vengono còlti all’inizio di un nuovo giorno, mentre tirano su una tapparella. Insomma: lo zoom si approssima al vivo di una vicenda qualunque del quotidiano di individui qualunque. Ma la narrazione non è interamente impersonale e distanziante: c’è un noi che spera, che partecipa alla vicenda di quelli che «spariscono in un vuoto che speriamo || duri sempre pochissimo». Un elemento centrale della poetica di Gezzi, dunque, è la dimensione corale. Non credo certo di porre attenzione ad un dato inedito, essendo già stato, altrove, precedentemente messo in risalto, sia in relazione a Il numero dei vivi che all’ultima raccolta. Vorrei, però, riflettervi calandolo in una valutazione più estesa.
Leggendo Gezzi con attenzione, viene da pensare che il poeta marchigiano abbia oltrepassato – riarmonizzandolo, e non certo ignorandolo – il problema del peso e del ruolo dell’esperienza autobiografica all’interno della propria scrittura poetica. Com’è noto, quella del posizionamento (frequentemente auspicata secondo un indice di ridimensionamento e di decentramento) del soggetto è una delle questioni sempre attuali del discorso critico sulle scritture poetiche, contemporanee e non. Soffermandomi su Sempre mondo,è piuttosto intuibile, anche per un lettore esterno rispetto all’orizzonte privato di Gezzi, che persiste frequentemente una coincidenza tra l’autore del testo e il soggetto che prende parola nel testo. Ma questo tratto non desta imbarazzo, perché non si dà come elegia privata, ma come testimonianza di ciò che viene effettivamente visto, ascoltato, esperito: se c’è un tu che parla c’è un io che ascolta. Se c’è un tu che domanda, c’è un io che tenta una risposta. Se c’è un voi o un loro ad abitare un tempo-spazio (sia esso prossimo e immediato, o storico), c’è un io che ne certifica l’esistenza. La naturalezza dell’operazione è garantita (nella maggior parte dei casi) da una postura lucidamente inquieta. Ecco la coralità possibile: la figlia giovanissima, gli studenti, i vicini di casa, le vittime della storia, sono il mondo inquieto che Gezzi, dalla molteplice prospettiva di individuo-padre-docente-scrittore, restituisce al lettore. In tal senso sono rappresentativi molti testi della prima sezione del volume (“Un’educazione sentimentale”): le parole e le domande degli studenti sono trascritte con apparente fedeltà, senza eccessive trasfigurazioni, così che la loro voce si inserisca con naturalezza nel dettato poetico complessivo («Me lo dà, lei, | il permesso di sbagliare, | di perdermi in un sogno?»; «È più scuola | o galera, secondo lei, questa qui?»). Il mondo di Gezzi, dunque, non è poetizzato né ideale: è un mondo che sembra quasi delegittimare la domanda sulla possibilità di “abitar(lo) poeticamente” – (si veda, a tal proposito, un testo emblematico de Il numero dei vivi, a p. 77) –, ma di cui la poesia tenta quantomeno, e nel caso di Gezzi non obbligandosi a particolari stratagemmi opacizzanti, di recare traccia.
Quella di Gezzi è una coralità inquieta, e la scrittura tutta mi pare animata da costante inquietudine – seppur talvolta sottile, o nascosta, o mitigata. Persiste, mi sembra, un equilibrio auspicato ma non sempre raggiunto tra due poli: da una parte una spinta riconciliante (intima, spesso sussurrata), dall’altra una lucidità di sguardo che, al contrario, sembra non ammettere illusioni. Questa dialettica non risolta si attiene, se vogliamo, al piano dei significanti, non impattando in maniera decisiva su quello della lingua e della forma: qui Gezzi mantiene intatta una voce già stabilmente conquistata: una lingua di matrice “alta” che procede, tramite diminuzione e sottrazione, fino ad una pronuncia piana, lineare, che non cerca scarti vistosi rispetto alla lingua quotidiana. Ma che non sembra dover rinunciare – e mi pare, questo, segno di piena libertà espressiva – alle possibilità del “grande stile”, ai frutti della lezione, filtrata senza manierismi, della grande lirica novecentesca (cito un bel passo del testo che apre il volume: «E pomeriggi di fatica, | di ossessioni che intorbidano e stancano | i pensieri, dissolte per un attimo | dal tintinnare della tenda per gli insetti | oppure da una frase attesa a lungo | e infine pronunciata, se la sera | promette l’allegria poi dà il torpore»). Ma vorrei tornare all’inquietudine, alla tensione non risolta.
Se nelle “Quattro lettere di Paul Signac a Émile Verhaeren” (terza sezione) – suggestivo mascheramento di un dialogo con il poeta marchigiano Antonio Santori, scomparso nel 2007 – Gezzi mette scopertamente in scena il primonovecento, con gli orrori della guerra alle porte (in cui la «marcia infernale di macchine | e delirio» fa da sfondo ai «giorni di lutto» del pittore francese), altrove l’inquietudine che anima Sempre mondo si consuma in una proliferazione di interrogativi aperti («Ma quando torneremo cosa salda | sapremo riconoscerci, | saremo ancora veri?»). La presa di parola del poeta – pur animata da una speranza di fondo – non può che arrendersi al reale. La speranza più viva di Gezzi sembra infatti essere quella di diventare “tutti”, di «essere in comune». Ma né la parola né il semplice “esserci” nel mondo bastano: «Questi contorni, queste voci qui sotto | la città con il suo sonno, il suo rumore | d’acqua vasta, mentre tutti nelle stanze | disintegrano il giorno nello scrigno | del letto – tutto questo non basta | per essere in comune». L’essere nel mondo degli uomini e delle cose non garantisce altro che il loro stesso esserci. Tornare a una poesia de Il numero dei vivi potrebbe essere (retroattivamente, se vogliamo) esemplificativo più di qualsiasi ulteriore digressione sui due “motivi” (coralità e inquietudine) scelti per articolare le riflessioni qui proposte: «Il presente è una speranza che contraddice se stessa, bene e male | che si elidono, il sospetto di non potere, | non sapere, non volere | se non essere. Siamo?».
Ecco che la presenza del Rilke delle Duinesi, convocato da Gezzi nel titolo (e nell’esergo: Immer ist es Welt, dall’ottava Elegia), potrebbe riemergere via via, in nuce, anche nella dimensione di un’inquietudine che sembra non ammettere, in ultima istanza, riposo e pacificazione. Parafrasando, più o meno liberamente: è sempre mondo, ma (prima Elegia: Bleibend ist Nirgends)non c’è luogo dove restare.
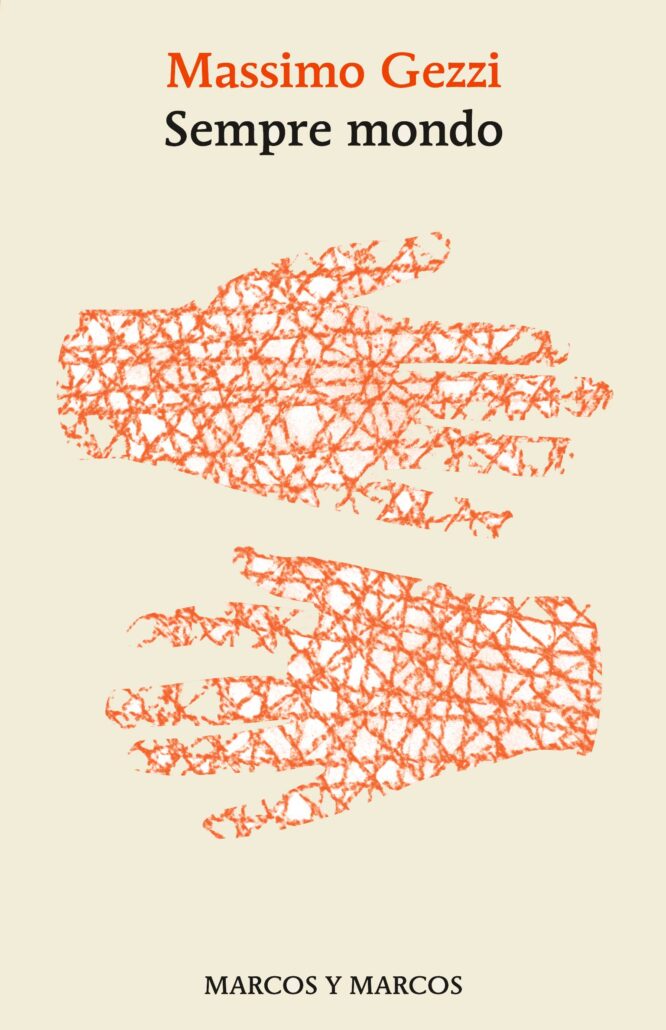
Massimo Gezzi, Sempre mondo, Marcos y Marcos, Milano 2022, 150 p., 18 euro.