Da qualche tempo il genere del memoir si è imposto su quello dell’autobiografia, soprattutto nelle scritture femminili. Lontano da qualsiasi ambizione enciclopedica o documentaria, questo genere non aspira a restituire verità assolute o fatti oggettivi, anzi: cosciente della sua più intima natura – quella di ricordo o insieme di ricordi – inciampa spesso in riflessioni sulla propria fallacia e inattendibilità. Con Niente di vero Veronica Raimo si inserisce in una tradizione di voci che – a partire da Simone di Beauvoir fino ad Annie Ernaux e Claudia Durastanti – hanno riportato l’attenzione sulla memoria come strumento narrativo e sull’episodio come forma della narrazione.
Quello del memoir è un tipo di scrittura frammentario, fatto di esperienze a pezzi e cucite insieme, dove il montaggio è fondamentale per la restituzione di un senso, sia agli occhi del lettore che a quelli di chi scrive. Spesso tale genere è stato associato alla rielaborazione di esperienze traumatiche o comunque determinanti per il soggetto che ricorda. Nel caso di Raimo questo aspetto è molto ben nascosto, ma è certamente presente. La struttura episodica dei brevi capitoli il più delle volte riesce infatti a trasformare micro-traumi in aneddoti divertenti, come quello – determinante – di essere cresciuta insieme a un fratello maggiore geniale. La posizione di secondogenita è anche per la protagonista una posizione da outsider che la solleva dal compito di dover primeggiare a tutti i costi, e le permette di fare ironia su se stessa proprio come strategia di sopravvivenza. Veronica racconta nella prima parte del memoir aneddoti legati alle dinamiche di casa, come i giochi cervellotici inventati dal fratello maggiore, o le paranoie di sua madre Francesca, le cui telefonate riuscivano a raggiungerla a casa di qualsiasi persona si trovasse. Ci sono poi i dettagli dei primi innamoramenti, come quello per un giovane poeta russo o per un ragazzo di nome Bra che la lascia a Roma per andare in Irlanda con un’altra. Di fatto, Niente di vero è la storia di una vita ordinaria che diventa straordinaria per il modo in cui la voce narrante riesce a rileggere gli eventi già nel loro svolgimento. Spesso capita che l’autrice sospenda il racconto per dare spazio a una riflessione sull’atto stesso del narrare il proprio vissuto:
“La maggior parte dei ricordi ci abbandona senza che nemmeno ce ne accorgiamo; per quanto riguarda i restanti, siamo noi a rifilarli di nascosto, a spacciarli in giro, a promuoverli con zelo, venditori porta a porta, imbonitori, in cerca di qualcuno da abbindolare che si abboni alla nostra storia. […] La memoria per me è come il gioco dei dadi che facevo da piccola, si tratta solo di decidere se sia inutile o truccato.” (p. 161)
Raimo abita con consapevolezza il proprio ruolo di narratrice. Sa che spetta a lei e solo a lei dare o meno dignità a un certo evento, promuovendolo come parte di una storia. Ciascun episodio è caratterizzato da una forma di ironia che nasce da un’opposizione spiazzante: un ricordo può essere “inutile” – e quindi non degno di essere recuperato – oppure “truccato”, manipolato a sufficienza perché riesca a trovare “qualcuno da abbindolare”. La verità non è mai contemplata. Questo assunto costituisce un punto importante per affrontare la lettura di un memoir che, proprio per il suo rapporto con l’idea di finzione e manipolazione, non si fatica a considerare anche un romanzo. Per Raimo, verremo a sapere, l’idea della scrittura come truffa ha avuto inizio molto presto, negli anni dell’infanzia. È infatti in quel periodo che l’autrice ha iniziato a muovere “i primi passi nell’impostura” (p. 154) attraverso un diario in cui annotava falsi aneddoti per ingannare sua madre:
“Anche se non sentivo ardere il fuoco sacro della scrittura, da bambina per un certo periodo ho tenuto un diario. Non mi interessava conservare a futura memoria i miei patimenti infantili ma depistare mia madre. Sapendo che lei l’avrebbe letto – cosa che infatti faceva – le regalavo una versione di me a suo uso e consumo.” (p. 153)
A differenza di Annie Ernaux che utilizza vecchi diari non al fine di rievocare, ma di abitare quanto più possibile la propria storia con fedeltà, Veronica Raimo attinge a un passato già compromesso, contraffatto sul nascere a vantaggio della protagonista stessa, che nella sua menzogna cresce e si autodetermina come soggetto e come donna.
Se la pratica della scrittura del sé nasce come ricerca di protezione dalle intromissioni di una madre troppo apprensiva (e un po’ impicciona), negli anni dell’adolescenza diventa una possibilità di fuga percorribile in alternativa all’altra fuga, quella reale verso Parigi, tentata maldestramente dalla protagonista dopo aver rubato un milione e duecentomila lire dall’armadio del padre. Fallita l’impresa, la menzogna diventa per Veronica una forma di riscatto da una realtà insufficiente e certamente troppo stretta (“Ogni volta che mi sono sentita chiusa in una cameretta, […] non ho provato a fuggire, ma […] a immaginare cose finte, a dirle, a provocarle, fino a crederci”, p. 18).
L’impostura – l’atto cioè di mentire per il solo gusto di farlo, per puro intrattenimento personale – invade anche il campo dell’amicizia, quando in quarta liceo la migliore amica di Veronica parte per la Germania per un programma di scambio. Da quel momento le ragazze iniziano a mandarsi lettere firmate con nomi fittizi, uno stratagemma sufficiente a incoraggiare ancora una volta le manipolazioni di un’autofiction sempre più orientata verso la sua parte di finzione. Rievocando quegli anni di francobolli e fotografie esotiche dalla Germania dell’Est, la protagonista arriva ad ammettere che proprio quell’accumulo di fogli scritti a mano potrebbe essere oggi considerato il suo primo romanzo: “esistono almeno due versioni del mio quarto anno del liceo: quella più o meno reale di cui non ricordo quasi nulla, e quella scritta per Cecilia, di cui ricordo quasi tutto.” (p. 140)
In questo memoir che gioca a farsi romanzo la ricerca dell’effetto comico giustifica la menzogna e al tempo stesso aiuta a stemperare i momenti più drammatici, che non scadono mai nei toni del patetico, ma si mantengono su un equilibrio dolceamaro.
Gli episodi, inseriti come tappe che accompagnano una serie di uscite (quella dall’infanzia, quella dall’adolescenza), sono spesso tutt’altro che comici: Raimo affronta la questione del lutto rievocando la morte del padre e quella di un nonno, racconta di un aborto, rievoca la fine di varie storie d’amore e quella di un’amicizia. Il sorriso che l’autrice ricerca nel corso della narrazione si impone come filtro, crea distanza, e se da un lato agisce come crema lenitiva sul dolore, dall’altro aiuta anche a sublimarlo, trasformandolo in intrattenimento nel senso più letterale della parola: quello di tenere il lettore il più lungo possibile a sé, come antidoto al silenzio e alla solitudine. La tenerezza è la cifra di questa scrittura che nella manipolazione del tempo narrativo trova l’antidoto alla mancanza di affetti che non ci sono più: i personaggi che hanno lasciato la protagonista per sempre ritornano – eludendo la loro stessa uscita di scena – con episodi giustapposti uno accanto all’altro per associazione, come succede davvero quando ci si abbandona a una catena dei ricordi.
All’indomani dalla sua pubblicazione la carica comica del libro di Raimo è diventata l’aspetto più sottolineato dai recensori. L’elemento paratestuale più evidente, la fascetta rossa con il blurb firmato Zerocalcare, anticipa la quarta di copertina nel prefigurare al lettore un tipo di scrittura divertente fino alle lacrime, una definizione piuttosto iperbolica che tende purtroppo ad appiattire uno stile ricco di sfumature, come appunto quello di Raimo.
Niente di Vero si appropria della tradizione del memoir contaminandola con i toni della stand up comedy femminile degli ultimi anni, tenendosi più vicino al territorio di Hannah Gadsby che a quello di Katherine Ryan. Mentre quest’ultima fonda la sua vena comica su una spregiudicatezza che non rinuncia al dettaglio volgare o al politicamente scorretto, Gadsby sfrutta invece il trauma della propria identità queer per un effetto comico che non è mai puro abbandono alla risata. Similmente a Gadsby, la comicità di Raimo mette in luce l’incapacità di aderire a un’obsoleta narrazione di genere come quella del romanzo di formazione femminile.
“Siamo arrivati al paradosso” ripeteva costantemente il padre della protagonista, e in quel paradosso Veronica Raimo ha trovato la sua forza, abbracciando nella sua prosa tutto quanto di goffo e sbilenco poteva entrarci, in un atto di ribellione punk contro la grazia. La protagonista rende il lettore partecipe dei suoi problemi di stitichezza, descrive la sua frustrazione legata all’insonnia e ammette senza troppi problemi di intenerirsi più facilmente davanti a immagini di cuccioli animali che di bambini. Se da un lato questi scorci di vita “imbarazzante” sembrano stilare un patto di sincerità con chi legge, dall’altro la dichiarata impostura attiva – come per dispetto deliberato – un corto circuito in cui distinguere la realtà dalla finzione diventa del tutto impossibile.
La prosa di Raimo non è impreziosita da subordinate o metafore ricercate, ma è snella e diretta come lo sono i testi destinati alla lettura ad alta voce. Il racconto, per quanto indisciplinato nel suo slittare avanti e indietro sulla linea del tempo, ha una sua coerenza interna che si percepisce al livello di ciascun paragrafo. La voce narrante procede per affermazioni a effetto. Frasi come: “Mio fratello muore tante volte al mese” (p. 4); “Ho imparato a leggere a quattro anni” (p. 8); Amo vivere nelle case degli altri” (p. 40); “Non ho mai ricevuto un’educazione sessuale” (p. 96). Poi le scioglie giocando a snocciolare dettagli, uno alla volta, facendo bene attenzione alle pause, come in un monologo teatrale. Il risultato finale è una voce inedita e fresca che sta lì a ricordare come gli eventi delle nostre vite, proprio come le nostre identità, siano tanti quante le storie che scegliamo di raccontarci.
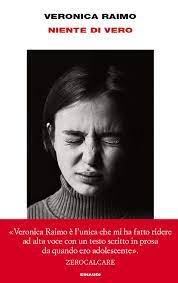
V. Raimo, Niente di vero, Einaudi, Torino 2022, 176 pp., € 18,00.