Con Camere e stanze, uscito per Ponte alle Grazie nella seconda metà del 2021, è stata raccolta l’intera produzione breve di Francesco Pecoraro, che con i racconti di Dove credi di andare (Mondadori 2007)aveva cominciato – tardi – il suo percorso di scrittore. Un percorso proseguito poi attraverso altre forme di scrittura: quella sul blog tashtego, in cui per anni ha pubblicato brani di vario tipo – tra il narrativo, lo speculativo e il descrittivo – poi raccolti a loro volta nel bel volume Questa e altre preistorie (Le Lettere 2008); quella romanzesca, culminata in due libri importanti per l’ultimo decennio letterario, La vita in tempo di pace (2013) e Lo stradone (2019); e infine quella poetica, “riemersa” lo scorso anno con il poemetto Nodulo (Tic edizioni 2021), dopo la prima raccolta Primordio vertebrale (Ponte Sisto 2012).
Pecoraro è dunque scrittore dai molteplici volti e che però in tutte le strade espressive che ha praticato mantiene una costante, che potremmo definire nei termini di una frammentarietà generativa. In un’intervista, comparsa su queste stesse pagine, avevamo provato a definire il procedimento di composizione di Pecoraro come “modulare”. L’autore stesso ha riconosciuto che i suoi romanzi hanno in comune con le scritture nate in rete un processo di aggregazione di brani poi sistematizzati in un momento successivo per raggiungere una forma narrativa ad ampia campata («Lo stradone invece è più una palla di pongo. Il procedimento di scrittura a brani si estremizzò fino al punto che non credevo di poterne fare un libro»). In questo senso Camere e stanze si presenta come un libro molto importante, poiché ci offre per intero la produzione breve di un autore che ha sempre fatto della brevità il suo primum creativo. Rispetto alle prose “webbiche” (per usare un termine che gli è caro) e alle lasse narrative che riempiono l’intelaiatura dei due romanzi, inoltre, i racconti ci mostrano Pecoraro alle prese con una forma chiusa della narrazione; non a un caso lui stresso aveva ammesso che «solo i racconti di Dove credi di andare, e nemmeno tutti, nascono da uno schema, un progetto, un’intenzione precisa, un piano di lavoro», rispetto a un modus operandi definito altrimenti caotico.
Un primo livello d’osservazione, allora, potrebbe riguardare proprio la struttura narrativa di questi racconti, che coprono per intero l’arco temporale dell’attività scrittoria di Pecoraro. Un elemento di forte continuità è l’assenza di veri e propri sviluppi d’intreccio: fedele a un modello novecentesco di novella, Pecoraro predilige concentrare l’attenzione intorno a un unico evento, talvolta esteso, talvolta invece minimo, che fa da referente per una ricostruzione a posteriori della storia dei personaggi. Accade con il bellissimo racconto d’apertura, che dà il titolo alla raccolta, dove, dopo un minimo innesco in cui la fidanzata del protagonista lo convince a organizzare una festa per i suoi cinquant’anni, assistiamo allo svolgimento di quest’ultima, che si trasforma rapidamente in una tragica invasione da parte di una folla di giovani che nessuno sa chi abbia invitato e che rapidamente mettono a soqquadro la casa dell’uomo. Fedele alla “teoria del Recinto” – l’unica conquista teoretica del protagonista, ordinario di Sociologia dello spazio –, la casa viene vista «come una sorta di vagone, di pullman, di roulotte spazio-temporale a bordo della quale attraversare l’esistenza in modo abbastanza confortevole. Racchiusi. Separati. Confortati e riscaldati, all’asciutto». La violazione dello spazio domestico da parte dei “nuovi barbari” significa allora la progressiva distruzione dei nuclei di memoria custoditi nelle stanze, degli oggetti-feticcio intorno a cui si organizzavano passioni e ricordi, l’apertura dei confini e lo sbalzo dell’individuo nell’esterno straniero. Che in Pecoraro si configura sempre in termini di una modernità incognita e selvaggia, di cui non si conoscono le regole, scritte o non scritte.
È quello che capita anche al protagonista di Vivi nascosto, amministratore pubblico ormai in là con gli anni che si ritrova improvvisamente estromesso da quegli accordi silenziosi, da quelle intese trasversali che aveva sempre saputo “agganciare” e che avevano fatto la sua fortuna professionale. Il trauma che sta dietro le vicende di molti dei protagonisti di questi racconti è quello della fulminea, inattesa frattura di quel cosmo corrotto e sbagliato, ma pur sempre ordinato, in cui avevano imparato a muoversi e comportarsi. La trasformazione richiede nuove attitudini, impone nuove prassi e soprattutto una capacità di adattamento che questi uomini, borghesi che hanno superato la mezza età, non sono più in grado di sviluppare. E il raggiungimento di questa consapevolezza può produrre le reazioni più diverse e inconsulte.
Qualcuno arriva addirittura a suicidarsi quando realizza di essere arrivato a un’impasse: «Insomma, mi suicido perché resto indissolubilmente ancorato al modernismo novecentesco che, dopo tutta la fatica fatta per capirlo accettarlo amarlo, adesso è lì che sprofonda nel trascorso della storia, e io con lui» (Mi suicido per via dei miliardi di anni). Qualcun altro invece accetta con rassegnazione anche compiaciuta questa brutale espulsione, magari provando a pilotarla in qualche modo, come l’impassibile e ammirato manager protagonista di Uno bravo, che anticipa in qualche modo il momento dell’esclusione autosabotandosi: il tatuaggio che progressivamente prende forma sul suo volto, fino a trasfigurarlo, è un modo per mettere alla prova un “sistema” in cui non si riconosce, ma è anche una condanna indirettamente firmata contro la propria carriera e contro la propria posizione nel mondo.
Che per Pecoraro la vita sia una questione di posizionamento lo dicono molti dei racconti di Camere e stanze, che offrono più di un momento in cui lo scrittore esibisce – come già aveva fatto nei romanzi – tutta la sua fede nella sociologia (e in quella à la Bourdieu, verrebbe da dire) quale strumento più efficace per definire la divisione della società, la sua composizione in classi e gruppi, le traiettorie predefinite che ogni individuo percorre convinto di esserne l’artefice e non la vittima. Spesso il meccanismo narrativo di retrospezione estesa e articolata ha proprio la funzione di dispiegare per intero lo scenario sociale e antropologico del racconto, distribuendo i ruoli, attribuendo posture e propensioni, definendo schieramenti e appartenenze. Nessuno scappa al gioco del riconoscimento sociale. Neanche chi si colloca volontariamente al di là di ogni legge e norma, come Bilal, l’uomo che prende in mano la penna in Tecnica mista. La sua è una lunga lettera di confessione in cui ricostruisce la sua vita di emigrato «anglo, italo, libanese» dalle ambizioni artistiche e il suo progressivo avvicinarsi al fondamentalismo islamico, fino al grande attentato che l’ha portato in cella in qualche carcere americano di massima sicurezza (Guantanamo?). Destinatario della confessione non è però qualcuno che potrebbe perdonare o scagionare Bilal per le sue azioni, ma l’unico – a suo dire – che possa «davvero capire» la valenza del suo gesto, ovvero un critico d’arte italiano. Nel delirio di Bilal c’è la pretesa di qualificare il suo attentato come un’opera d’arte totale, in cui «far coincidere totalmente l’arte con la vita», in cui raccogliere «ogni mezzo tecnico e ogni linguaggio».
Com’è facile intuire, Tecnica mista si fonda su un’invenzione inverosimile, che potremmo definire (come molti altri racconti di questa raccolta) “massimalista”, poiché si cura meno dall’attendibilità referenziale di ciò che è narrato e più della validità speculativa delle riflessioni dei personaggi, oltre che del valore allegorico delle loro vicende. Se l’identificazione dell’attentato con «l’Opera» è solo il punto d’arrivo della confessione di Bilal, a occupare il cuore delle sue lettere sono le sue riflessioni sul sistema dell’arte, raccontato da chi ha tentato in tutti i modi di affermarsi in un contesto sociale che svaluta le ambizioni sfuggenti in nome del buon senso pragmatico. E arriviamo così a quello che è uno dei temi distintivi della narrativa breve di Pecoraro: l’arte.
Sono almeno tre i racconti che vedono per protagonista un artista (ma diversi altri trovano nell’arte un motivo secondario, come in Lenzuola fresche, improfumate e nel già citato Camere e stanze): oltre all’attentatore di Tecnica mista, troviamo il pittore professionista di Il match e quello amatoriale di Rosso Mafai. In realtà è proprio questa seconda qualifica, “pittore”, che dovremmo adottare per tutti e tre, anche per il fondamentalista performer di Tecnica mista, che si forma in una scuola d’arte inglese come pittore e per anni cerca la propria strada attraverso quella forma espressiva, prima di capire, nel momento stesso dell’attentato, che quella «era l’Opera, la mia Opera», l’unica che contenesse «tutto ciò che è possibile inventare». Potremmo addirittura dire che la distinzione tra artista e pittore è il fil rouge concettuale di questi tre racconti. «Così mi definisco, pittore: cioè non artista ma pittore, vale a dire colui che dipinge, che stende i colori su supporti di varia natura», dice il protagonista di Il match, ossessionato dal “problema del rettangolo” e che decide di provare a superarlo accettando l’invito-scommessa di un suo amico gallerista, che gli propone per la prima volta di allestire un’intera stanza di un nuovo spazio espositivo, mettendo alla prova la sua pittura al di fuori della dimensione della tela. Per tutti questi personaggi la pittura è innanzitutto una questione di materia – le dimensioni delle tele, lo spessore o la consistenza delle setole dei pennelli, la direzione delle pennellate, e soprattutto il punto di colore. Dipingere è una pratica costante, tra il rituale e il maniacale.
Il protagonista di Rosso Mafai, ad esempio,è un ingegnere che decide di mollare moglie e lavoro, chiudersi nella casa al mare e dedicarsi asceticamente alla realizzazione di un «Progetto».
L’obiettivo sarebbe stato di produrre un numero imprecisato di tele rettangolari, tutte uguali, contenenti stesure complesse di colore, fatte in modo da mostrarsi da vicino in ogni singola pennellata e da apparire a una certa distanza come una superficie continua e, come si diceva spesso, vibrante.
La vocazione a dipingere suona naturalmente “datata” in un sistema dell’arte che ha ormai marginalizzato la pittura; ma per questi personaggi si tratta di una questione di fede. E forse anche per il loro autore. Non è casuale, credo, che i tre artisti si definiscano integralmente votati all’informale, a quell’espressionismo astratto che negli anni Sessanta segnò uno scarto – culturale, ma anche geopolitico (la nuova egemonia artistica americana) – nel sistema artistico internazionale: «Non c’è pittura-pittura più pittura dell’espressionismo astratto» afferma Bilal. La pittura di colore è il richiamo all’età dell’oro della pittura novecentesca, è il sintomo di un desiderio regressivo ma anche l’unica possibilità di proiettarsi fuori da un presente che ha decretato l’inattualità della figurazione: «niente valeva più la pena di essere rappresentato, riprodotto, in pittura. Altri, con altri mezzi, infinitamente più potenti e invasivi, lo facevano meglio e soprattutto lo facevano di continuo e massicciamente».
Quanto più è disperato e viscerale il tentativo di riscatto, però, tanto più radicale sarà la reazione di fronte al fallimento. E infatti i tre artisti – praticamente gli unici personaggi della raccolta che cercano di invertire l’inerzia della propria vita, attraverso un progetto, un atto creativo che ridefinisca il loro ruolo nel mondo – subiscono in maniera più tragica la sconfitta a cui inevitabilmente vanno incontro: la follia, il suicidio tentato o vagheggiato, sono le uniche exit strategy per chi ha visto fallire anche l’ultimo, disperato tentativo di superamento creativo del trauma.
I racconti dell’ultima sezione della raccolta, Altre forme, che raccoglie testi inediti o editi in varie sedi nel corso degli anni, presentano una natura meno omogenea rispetto a quelli delle altre due sezioni – a partire dalla misura, che qui si fa in alcuni casi anche molto breve – ma presentano diversi spunti interessanti. Alcuni testi sembrano deviare rispetto al set classico della narrazione di Pecoraro – imperniato sulle vicende di un protagonista maschio, borghese, in età avanzata e ampiamente disilluso dalla vita – per puntare l’attenzione su quella che potrebbe essere l’infanzia e l’adolescenza di quegli stessi personaggi. Racconti come Non so perché, North American P-51 Mustang, Nosferatu, Il Fregno o Il Bove ci portano direttamente dentro le dinamiche oscure e spietate dell’adolescenza, tratteggiando scenari che potremmo immaginare anche come materiali preparatori per alcune parti della Vita in tempo di pace. Ma i racconti che colpiscono di più sono quelli in cui Pecoraro si cimenta in tentativi di immaginazione distopica del futuro.
Se già alcuni testi della prima sezione avevano mostrato come la forma breve si presti all’introduzione di elementi inverosimili nella narrazione, utili a suscitare straniamento e liberi dalla necessità di trovare una legittimazione referenziale come capita più facilmente nel romanzo (pensiamo allo scenario onirico di Happy hour), qui Pecoraro si spinge oltre, affrontando la fatica di costruire interi mondi alternativi, seppur in maniera frammentaria e, soprattutto, scopertamente allegorica. In La città indiscussaviene raccontata la giornata tipo in una società interamente controllata dalla tecnologia e dal capitale privato: non esiste la proprietà dell’individuo, che può solo guadagnare attraverso impieghi cambiati quotidianamente e reimpiegare i soldi guadagnati per affittare quotidianamente vestiti, pasti e abitazioni, in uno scenario che vede le differenze di classe ulteriormente esasperate. Nella Tavolata invece ci troviamo di fronte alla grande metafora di una vita spesa interamente a tavola, in conversazioni futili tra commensali che non si conoscono e che, di tanto in tanto, si alzano per andare in bagno (dove avviene tutto ciò che non è ammesso a tavola), ma che non possono mai abbandonare il loro posto, se non al momento della morte, che coincide con l’assegnazione di quel posto a un’altra persona. È l’incubo di un mondo-banchetto interamente sottoposto al controllo di una potenza oscura (qui la Samsung), che concede qualche vizio per sottrarre agli uomini ogni libertà. In queste pagine Pecoraro non teme il rischio dell’eccesso, la sua immaginazione è audace e a tratti anche grossolana, ma coerente con il suo millenarismo disperato, che trova in questi racconti vie espressive più radicali rispetto ai racconti realisti e alle narrazioni romanzesche, pure impregnate del medesimo sentimento.
Non ricordo più quanto e come—e nemmeno perché, cioè soprattutto non ricordo il motivo, la forza che mi indusse a farlo—mi sedetti alla Tavolata.
L’incipit della Tavolata si può definire emblematico di tutti i racconti di Camere e stanze, non solo di quelli onirici e distopici. Condensa un’idea condivisa da tanti altri protagonisti, increduli e sgomenti di fronte alla scoperta che qualcosa è accaduto, un trauma si è consumato ma non è possibile elaborarlo, perché non si può dire esattamente cosa l’abbia scatenato. Non si può far altro che accettare le conseguenze di quella che ha le fattezze di una trasformazione globale, antropologica e sociale. E il compiacimento cinico e nichilista con cui alcuni di questi personaggi vanno incontro a un destino di subordinazione e umiliazione è forse il messaggio più forte che ci lasciano i racconti di Pecoraro, lo scrittore più bianciardianamente incazzato che la nostra letteratura possieda oggi.
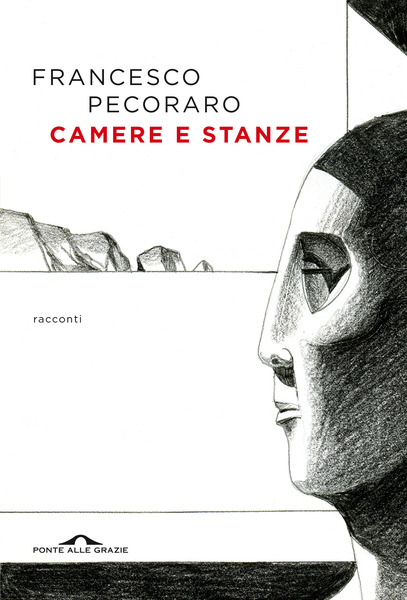
Francesco Pecoraro, Camere e stanze, Ponte alle Grazie, Milano 2021, 480 pp. 19,00€