La voce di Simone Biundo nella sua opera d’esordio Le anime elementari (Interno Poesia, 2020) ricorda quella di un bambino che la morale di paese definirebbe cattivo, impunito. Non a caso uno dei libri con cui in qualche modo dialoga la raccolta, come si legge nella nota finale, è proprio Pinocchio; ma tutte le citazioni usate come epigrafi alle varie sezioni del libro contribuiscono al riverbero. La raccolta è piuttosto eterogenea, sembra un coro di più voci ed età – anche solo immaginate e presagite – che emergono dal bardo, ma a percorrerla in tutta la sua estensione resta lo sguardo di certi bambini cresciuti in campagna, orrendamente autentici, fino a risultare dispettosi, come la voce di ogni verità che ci colpisce. È uno sguardo che ricorda quello che Luigi Meneghello, in Libera nos a Malo, riservava alla natura, secco e infantile.
Questo è un libro pieno di piante e di frutti, come li può vedere un uomo-figlio del suo territorio. Le “anime elementari” che danno il titolo alla raccolta sembrano proprio le anime dei luoghi e degli abitanti che li incarnano. Il passo – che pare percorrere quella spirale logaritmica (mirabilis) tanto presente in natura e il cui centro è irraggiungibile – è scandito dai nomi di località, strade, edifici, per poi perdersi e ritrovarsi, stavolta in una dimensione più ampia, evocativa: Valle Gesso, Terrasanta, La casa dei ciechi. La parola, avvolgendosi intorno a questi spazi, compie così la sua grande magia: produce atmosfere, percezioni. È una parola sospesa, che in alcuni studiati momenti precipita verticalmente, una visione zenitale, col sole a picco – anche quando parla dell’inverno o della notte. Evoca cortili secchi di case di campagna sgraziate, esistenze qualsiasi – nessuno è diverso, nessuno è indispensabile o insostituibile – erbacce.
C’è un dialogo tra queste presenze vegetali e l’uomo e le sue forme, a volte un bisticcio – tra la società e la natura in cui si insedia – che spazza via ogni possibile retaggio New Age. Leggendo «la migrazione delle piante è tratto | silenzioso, si spostano bendate | sullo stretto controllo militare | la traccia frontaliera, il reticolato | urbano, l’eterna esposizione | al sole, alla pioggia e all’erosione | ma guai se attecchiscono sul tetto | guai se il seme fiorisce nel giardino», penso alla cura solerte della propria casa, come entità che resiste al fluire del tempo, a differenza delle altre forme di vita. Questo grande tema è stato affrontato recentemente in prosa da Raffaele Riba in La custodia dei cieli profondi (66thand2nd, 2018), da Francesca Manfredi ne L’impero della polvere (La Nave di Teseo, 2019) e, prima ancora, nel 2014, al cinema da Alice Rohrwacher ne Le meraviglie; ma rimanda anche a un’altra favola importante, quella del Piccolo principe e della paura di vedere il suo pianeta infestato dai Baobab. Non è un caso d’altronde se arrivano tanti eco dalla prosa, perché questa è una poesia che la accarezza, nel suo narrare con precisione quasi giornalistica piccoli fenomeni, apparentemente prosastici, pure restando tenacemente poesia.
L’idea del giardino e della casa come idolo di resistenza e sopravvivenza agli accidenti del mondo, a patto di un imperituro lavoro di cura, è ingenua e commovente, perché pur continuando a conservarla nel nostro immaginario sappiamo quanto sia foriera di tristezza e destinata a fallire. Nei suoi confini ci identifichiamo – penso all’erba grassa mai attecchita nel vialetto di accesso di una certa casa in Revolutionary Road; ma penso anche a mia nonna, trasferitasi in un bell’appartamento di città dalla campagna, che ha sempre odiato appassionatamente le “rughe” (i bruchi di Litosia), che possono infestare al pari delle piante sottotetti e muri esterni, oltre a rappresentare un pericolo per le coltivazioni. La civiltà del boom, delle villette, dei recinti, della casa per tutti – a patto che sia di proprietà – tradisce la terra che l’ha cresciuta, pur portandosi dietro i suoi insegnamenti, e questo scarto irrimediato commuove, è davvero la separazione tra l’infanzia e una certa vita adulta, che strappa quelle piantine che una volta l’avevano meravigliata, che in un bruco vede il pericolo della fame e non una farfalla. Soffocare il dolore scaturito dall’aver reciso le radici appare necessario per potersi adeguare ai valori del nuovo mondo di cui si desidera far parte.
Mi stupisce leggere che Simone Biundo è del 1990, perché dalla sua scrittura potrebbe avere qualsiasi età. Per questo, quando a un certo punto appare un unico riferimento a Instagram, sembra che esploda una bolla, si torna a leggere per essere sicuri di aver inteso bene, ci si ricorda di essere nel 2021. Questo riferimento al virtuale stride e viene immediatamente reinglobato dalla natura, che sembra restare aggrappata all’inconscio del soggetto manifestandosi in continuazione, ma solo attraverso minime e costanti epifanie, che in alcuni tratti appaiono quasi come un assedio. Questo inconscio ci prega di emergere ma, a volte, pur assumendo la forma dell’apparizione ne smarrisce qualsiasi senso, come se ci venisse chiesto troppo e troppo in fretta, e fossimo stanchi, abbagliati. «Ci sono tante tracce | e non ne riconosco nessuna». Ci si sforza allora di ricordare, ma non si ricorda niente, si cerca qualcosa che non c’è mai stato, si crede di essere appartenuti a dei luoghi, ma non è così, e forse anche questa è solo una credenza, uno scherzo giocato dalla propria età anagrafica. «Si annuncia un’assenza» e così si compie questa poesia ligure – aggettivo sensoriale più che geografico – intrisa di quella saudade che quella terra condivide – insieme a molti suoni – col Portogallo.
Simone Biundo trova allora la sua massima espressione quando i luoghi si mescolano ai simboli e alla storia collettiva, e ciò accade soprattutto nelle ultime tre poesie, che riescono a toccare una sfera infantile e intima, sociale e pubblica al tempo stesso, senza alcun sacrificio, ma solo una grande, alternativa, pienezza. Il soggetto si espande accettando di essere il frutto di un mondo e di un’epoca, e come tale accoglie il passato, nel bene e nel male, nella sua identità, che ne esce così arricchita, non tanto “cresciuta” quando “accresciuta”, come se egli stesso fosse uno degli alberi che ha e lo hanno osservato.
Croce di Creto
la prestazione dell’agricoltore
è staffetta al vento, all’incostanza
il muro, il secco e più lontano il mare
la febbre della terra, la neve che non scende
e l’albero che secca, l’erba tutta bruciata
vincono le piante bene armate
le più morbide anche d’estate
Favale di Màlvaro
c’è un albero di uomini
che affonda le radici
in cielo
è come un baobab e contiene
più di 120 mila litri
d’acqua e sangue
nel suo tronco
è l’albero al contrario
e chi lo cura è un verbo
impersonale
piove
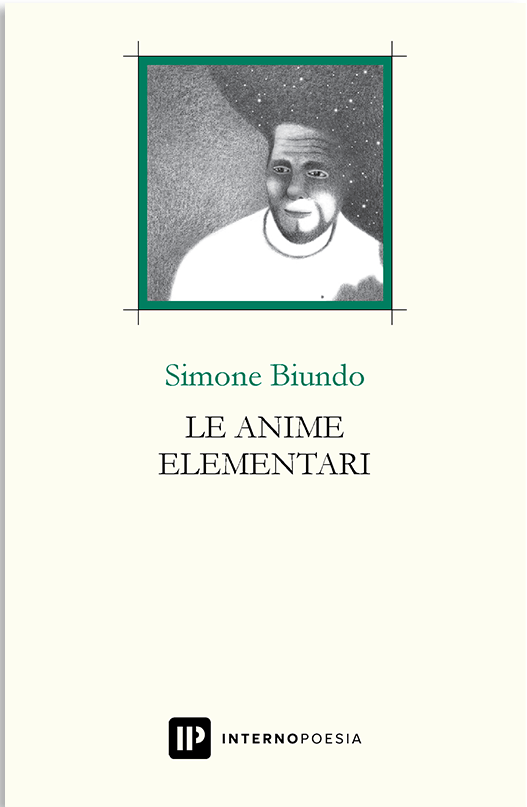
Simone Biundo, Le anime elementari, Latiano, Interno Poesia, 2020, pp. 104, € 11.