Leggere aiuta in tempo di quarantena, siamo d’accordo. E se il tempo di quarantena a sua volta aiutasse a leggere? Se desse un nuovo punto di vista dal quale (tornare a) riflettere e il tempo per farlo davvero, a fondo? Si potrebbe rispondere che bisognerebbe innanzitutto far parte della categoria privilegiata di coloro che rimangono a casa e che, soprattutto, stanno bene. Ebbene, giù la maschera: appartengo con mia fortuna a questa schiera. E proprio l’imbarazzo che accompagna questo privilegio mi impone di provare a comprendere i confini e le ragioni delle mie prerogative, a pormi quesiti che travalichino le mura a tratti opprimenti, ma senza dubbio sicure, da cui leggo e scrivo.
Tra le domande di questi giorni, eccone un paio: è forse individuabile una questione di genere dietro al rifiuto, o quanto meno alla difficoltà, di rimanere a casa anche a fronte dei battenti appelli quotidiani? Non sarà che la casa, simbolicamente e strutturalmente identificata come spazio materno, femminile, destinato a un lavoro non retribuito e non direttamente riconosciuto dal sistema capitalista, faccia in fondo un po’ paura a una società ancora fortemente patriarcale? Provocazioni, più che domande. È inevitabile che in una condizione estrema come quella in corso i fattori dietro l’insofferenza per l’immobilità siano molteplici: fisici tanto quanto emotivi, generali o personalissimi, fisiologici o intellettuali. Ma se, come insegna Jeffrey Weeks, i confini tra il politico, il sociale e l’intimo sono da tempo mobili, perché non provare a interrogare in ottica politica la sfera privata a cui tutti siamo oggi costretti?
Qualche risposta a tali questioni può essere trovata in un libretto, anzi un manifesto, scritto dalle accademiche Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya e Nancy Fraser e pubblicato simultaneamente in più di venti lingue nel 2019 (in Italia per la collana Tempi Nuovi di Laterza, tradotto da Alberto Prunetti): Femminismo per il 99%. Un manifesto.
Si obietterà che non è il momento di pensare al femminismo, con una delle crisi sanitarie peggiori degli ultimi secoli a colpire il globo intero. Ma silenziare le lotte per i diritti sull’altare di presunte cause di forza maggiore sarebbe non solo ininfluente, ai fini della risoluzione dell’emergenza, bensì dannoso per il presente e per il futuro che proprio questa contingenza impone di ripensare. Quale momento migliore per immaginare una nuova società se non quello in cui la società stessa, insieme all’economia, sta rallentando come mai prima nella storia del capitalismo? Femminismo sia, dunque, accompagnato da una solida base di critica al capitalismo.
Come notato in un articolo apparso su «The Atlantic» il 19 marzo scorso, nel ricordare che Shakespeare ha composto il Re Lear durante l’epidemia del 1606 e che Newton ha elaborato le proprie teorie ottiche durante la grande peste del 1665-6, bisognerebbe anche accennare al fatto che nessuno dei due doveva badare, in quelle circostanze, alla cura di figli o a responsabilità familiari. E qui emerge lampante la questione del “lavoro riproduttivo”, attorno alla quale gravitano molte delle riflessioni di Femminismo per il 99%.
Il capitale, in effetti, pur dipendendo largamente dall’enorme lavoro legato al dare alla luce, curare e mantenere in vita altri esseri umani – il “lavoro riproduttivo” appunto, a fortissima, benché non esclusiva, predominanza femminile – non accorda a esso pressoché alcun valore economico. Come analizzato nella Postfazione al libro, il lavoro salariato che crea profitto non potrebbe esistere in assenza del lavoro non salariato che crea persone, eppure di quest’ultimo il capitale ha sempre disposto liberamente, come di un plusvalore aggiunto al plusvalore di cui persino la critica marxista più avvertita ha fatto fatica a mettere in luce l’ingiustizia.
Le autrici del Manifesto ricordano come il “lavoro” legato alla generazione della specie umana sia chiaramente sempre esistito, legato per questioni fisiologiche alla figura femminile. Quel che è arrivato soltanto con l’avvento del capitalismo è stato il netto iato tra produzione remunerata (agita nelle fabbriche, nelle miniere o negli uffici, considerata in termini economici e per questo stipendiata) e riproduzione pretesa a titolo gratuito (relegata allo spazio familiare, femminilizzata, semantizzata in termini di “cura” in opposizione al “lavoro”, di “amore” in opposizione al “denaro”).
Il movimento femminista per il 99% mette in luce con forza questa contraddizione social-riproduttiva, sistemica al pari della contraddizione ecologica e di quella politica, ma forse non altrettanto discussa. L’assurdità di un’economia alla ricerca di una crescita illimitata in un pianeta dalle risorse limitate è lampante. Così come è più o meno acutamente criticato un sistema finanziario che pretenda politiche sempre più autoritarie e disposte a piegare la società alle regole del mercato. Ma dell’accumulazione e dell’illimitato sfruttamento del lavoro riproduttivo, altrettanto cannibalici e ingiusti, non si parla abbastanza – avvertono Arruzza, Bhattacharya e Fraser.
Da qui l’idea di proporre un manifesto in 11 tesi che richiami e integri quello di Marx e Engels, che faccia luce su un capitalismo molto più globalizzato di quello del 1848, su un paesaggio politico più eterogeneo e su nuove faglie di sistema. E che al tempo stesso faccia propria la consapevolezza di quanto il capitalismo stesso, nell’ultimo secolo e mezzo, sia diventato pervasivo, camaleontico e capace di cooptazione e coercizione più o meno subdole. È proprio a questa consapevolezza fondamentale, in effetti, che si riferisce il 99% del titolo.
Quello del 99% è ormai diventato un simbolo numerico efficace per denunciare la sperequazione economica su cui si basa il sistema capitalista. Il problema che le autrici del Manifesto affrontano apertamente è che dall’1% – e in generale dalla porzione dominante del sistema economico e finanziario – vengono fatti stillare appelli femministi apparentemente munifici, ma a ben vedere tesi a ratificare quello stesso sistema di cui le diseguaglianze di genere sono una componente strutturale. Il femminismo liberale vorrebbe far credere che basterebbe avere più donne ai vertici delle multinazionali, delle società, dei sindacati, per avere una società più giusta dal punto di vista dei diritti di genere. O che basterebbe porre l’accento sulla meritocrazia per aprire alle donne strade finora precluse – come se a determinare il merito e il talento non contribuissero anche una serie di vantaggi sociali, economici e culturali di partenza. Ebbene, questa variante progressista del neoliberalismo non è meno dannosa della controparte reazionaria, apertamente misogina. Certamente non è a questa identica, ma non si può negare come le due facce del sistema economico dominante si sostengano a vicenda: il progressismo liberale ha creato le condizioni per l’ascesa del populismo reazionario e si posiziona oggi come (finta) alternativa a esso stesso. Come le autrici notano nelle prime pagine, la sconfitta di Hillary Clinton alle elezioni americane del 2016 è al medesimo tempo la riprova di questo meccanismo perverso e la dimostrazione delle sue falle.
Qualcuno potrebbe obiettare che è pur sempre meglio che le donne siano unite in una singola battaglia femminista piuttosto che andare tanto per il sottile. Ebbene, purtroppo il sottile è spesso quanto una fetta che includa il 99% della popolazione mondiale, quindi forse tanto sottile non è. Il filosofo francese Alain Badiou, con lucidità e coraggio non molto comuni, invita in più di un suo scritto a riconoscere chi sono i nemici e chi gli amici in ambito politico e ideologico. Il neoliberalismo capitalista è, per i motivi fin qui esposti e come approfondito nelle tesi 2 e 3 del Manifesto, un nemico del femminismo, anche quando a farsene portavoce siano delle donne.
Gli alleati potenziali sono altri, e le autrici li individuano chiaramente. Sono i movimenti transnazionali, che stanno reinventando l’arma dello sciopero nei termini evidenziati nella prima tesi, millenni dopo la Lisistrata di Aristofane ma con simili presupposti. Sono, in base alla tesi 8, l’antirazzismo e il discorso critico postcoloniale, da portare avanti con pari costanza nel Sud e nel Nord del pianeta, dal momento che minoranze etniche e di genere affrontano ostacoli simili quando a dominare sia un interesse economico elitista. L’ecosocialismo della nona tesi, che vede migliaia di donne nel mondo battersi contro la privatizzazione di acqua e sementi, e per la preservazione della biodiversità (Vandana Shiva tra le figure di spicco). I movimenti LGBTQI+, in relazione ai quali la normatività sessuale subdolamente intrinseca al femminismo liberale rivela tutte le sue contraddizioni (per fare un solo esempio tratto dalla settima tesi, riconoscere i diritti delle persone transgender non basta se il sistema non è disposto a supportare i costi della transizione).
Tutte queste battaglie possono e devono essere unite. Che sia possibile l’ha dimostrato, già nell’Inghilterra del 1984, il fondamentale supporto che la comunità omosessuale offrì a uno dei più grandi e sofferti scioperi dei minatori: una storia di solidarietà anti-tatcheriana raccontata con grande garbo dal regista Matthew Warchus nel film Pride, del 2014. Le differenze tra i gruppi chiamati in causa, allora come oggi, sono rilevanti: disparate le situazioni strutturali, le esperienze e le sofferenze; specifici i bisogni, i desideri e le rivendicazioni. Ma riconoscere le specificità deve essere il primo passo per poi avviare una lotta comune che non si accontenti di equivalenze finché non si ottenga uguaglianza, non di diritti legali in assenza di giustizia, non di libertà individuali finché la libertà non sia per tutti. Per il 99(+1)%, per l’appunto.
Ripensare il ruolo sociale, politico e economico della donna offre insomma una chiave per trascendere con forza le pastoie del domestico di cui tutti, uomini e donne, percepiscono di questi tempi l’asfissia. E che sia importante ripartire dal microcosmo casalingo lo dimostrava già uno dei testi fondamentali del pensiero femminista, postulando la necessità di ritagliare, all’interno della casa, Una stanza tutta per sé, da cui la donna possa evadere almeno intellettualmente dalle “schiavitù femminili” (definizione quanto mai dritta al punto di Simone de Beauvoir, che se ne è sempre dichiarata quasi del tutto al riparo).
Bisogna riconoscere che l’isolamento e la convivenza forzata di questa strana contingenza stanno esacerbando le tantissime relazioni disfunzionali presenti all’interno delle famiglie, e con esse le diverse forme di violenza di genere che la prossimità costante impedisce persino di denunciare. Ma se è possibile vedere un’opportunità propositiva in questa stessa crisi, la si potrebbe rintracciare nel tempo oggi a disposizione di uomini e donne per condividere, finalmente alla pari, responsabilità familiari e impegni domestici, affinché alla fine della quarantena si torni a lavorare fuori e dentro casa con un riconoscimento reciproco dei ruoli, dei diritti e dei doveri. E se si volesse condividere anche qualche lettura, si potrebbe partire da Femminismo per il 99%. Un manifesto.
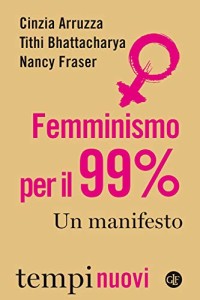
Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, Nancy Fraser, Femminismo per il 99%. Un manifesto, Laterza, 2019, 88 pp.