La voce di Grouper, al secolo Liz Harris, nella canzone, di appena cinquanta secondi, che apre il suo ultimo album, sembra provenire da un spazio remoto, echeggiare liturgicamente in una qualche cattedrale di marmo in rovina, persa in una temporalità indefinita. Questa prima impressione si conferma inequivocabilmente dopo l’ascolto dell’intero opus, composto da soltanto sette titoli, della durata complessiva di 21 minuti. Si è come trasportati in un mondo fatto di rovine, dove tutto è già successo e non resta nient’altro che l’eco di quello che è stato fatto e di quello che non sarà mai. Restano il sussurro e il mormorio, delle melodie appena accennate che paiono dissolversi nel momento stesso in cui prendono forma.
Accompagnate soltanto da un pianoforte dal forte riverbero, le linee vocali di Liz Harris si elevano in modo etereo e rarefatto al di sopra del mondo sensibile, si dispiegano e si diffondono senza essere al centro della composizione.
Viene da dire che nella musica di Grouper tutto è periferico, al punto che gli intervalli tra una nota e l’altra, lasciati risuonare a lungo nel vuoto, assumono la stessa importanza delle note. Le canzoni sono così sostenute da un’impalcatura sonora quasi traballante, prive di centro. A questo dissolversi armonico, si aggiungono i rumori di fondo, il respiro della cantante, un suono un poco sporco, un fruscio quasi continuo che sottostà a tutti i pezzi. Del resto, l’album si conclude con il rumore di fondo che invade interamente il campo sonoro. Un treno che solca un’eliotiana terra desolata, fatta di frammenti e di malinconiche parole appena pronunciate. Lo sfondo diventa primo piano, l’umano scompare, come nel finale de L’Eclisse di Antonioni. Non si sa bene di cosa parli Liz Harris nelle sue canzoni. Si coglie qua e là qualche parola, qualche segmento di discorso, come nel primo titolo: «Smells like rain / It is raining / The races». L’indeterminatezza dei testi, la loro quasi incomprensibilità accentuano la senzazione di trovarsi in un mondo post-umano, al di là della storia, qualche tempo dopo la catastrofe.
A quanto pare, l’album è stato registrato quattro anni fa, in una settimana e mezza, durante una residenza dell’artista alla Ucross Foundation, immersa negli sconfinati paesaggi del Wyoming. La registrazione fu interrotta dalla malattia di Liza Harris, intervento quasi ultraterreno a sigillare un album caratterizzato da una disturbante delicatezza e da una malinconica fragilità.
Grid of Points s’inscrive nella traiettoria del suo straordinario precedente lavoro, Ruins, del 2104, nel quale Liz Harris aveva abbandonato la chitarra e l’accumularsi di strati sonori creati dall’intersecarsi di diversi effetti a pedale. Con questo suo ultimo album, prosegue il suo lavoro minimalista, intensifica la sua volontà di procedere per sottrazione, concentrando tutto su un solo strumento, sull’intrecciarsi di due o tre piste vocali, e lasciando sempre più spazio ai suoni e ai rumori che provengono dal suo ambiente di registrazione.
È difficile parlare in modo specifico dei singoli pezzi. Le sette canzoni costituiscono un unicuum sonoro estremamente suggestivo, una testimonianza labile e frammentaria di ciò che forse siamo stati o che saremo. Ma questa, badate bene, è soltanto la mia personale sensazione.
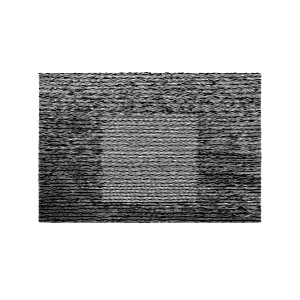 Grouper, Grid of Points – Yellow Electric (2108)
Grouper, Grid of Points – Yellow Electric (2108)