Genova è un modo di essere, mi dicevi. La forma del mio pensiero, mi spiegavi, dipende da questa città, e con il tempo lo avrei scoperto. Oggi la ritrovo come allora, come la ricordo: lunga e parallela al mare, protetta dai monti.
Nell’incipit c’è subito la città, come entità protagonista più che puro oggetto della narrazione; il chi racconta, a raccogliere un dolce ma gravoso lascito; il “tempo”, che tutto amplifica o riduce; e una descrizione, asciutta e scevra di lirismi, quasi fosse un’istantanea patinata, quella di sempre.
A ottobre scorso è uscito in libreria Genova Macaia. Un viaggio da Ponente a Levante di Simone Pieranni, per i tipi Laterza, collana “Contromano”. Il libro, in coerenza con il contenitore che lo ospita, ha un impianto ibrido, ossia innerva la realtà biografica e documentaria con elementi di pura finzione, romanzandola quindi o, forse, accrescendone la veridicità. Al tempo stesso, e come per l’esordio dell’autore, è un’opera la cui cifra, rispetto al panorama di oggetti narrativi simili, conserva delle sue ormai nette specificità quali: il dinamismo dell’autofiction; la dialettica tra il letterario d’antan e una certa fiction di genere a cui tende; la consapevole convergenza di sguardo politico e atto creativo.
Genova Macaia è un profondo scandaglio della capitale ligure, operato attraverso l’io narrante dell’autore – alternato a una serie di voci altre, attinte da un serbatoio biografico e insieme fittizio –, condotto lungo una traiettoria scelta che, come recita il sottotitolo, si muove da “Ponente” a “Levante” e cioè da ovest a est passando per il centro cittadino, e cadenzato da un continuo dialogo con la storia – sia remota, sia del recente più convulso – della città. Pertanto, definire il libro di Pieranni come una semplice mappatura letteraria di un capoluogo sarebbe riduttivo, e illusorio.
L’itinerario nei meandri genovesi comincia con un Ritorno, capitolo d’apertura dove l’io narrante confida che il rientro nel suo luogo natio, dopo varie peregrinazioni in lontanissimi altrove quali l’estremo oriente – l’autore ha vissuto e lavorato da giornalista in Cina, prima di rientrare a Genova –, coincide con il momento in cui la città presenta il conto, salatissimo da saldare per chi se n’è andato. Soprattutto se le sue origini risalgono a ovest, Bolzaneto.
Rieccomi dunque […] in quel percorso che ha contraddistinto la mia vita, da ovest a est, da occidente a oriente […] A ritrovarti nei luoghi, a chiudere questa partita fatta di non detti, di storia racchiusa in poche parole, quelle che troverò adesso. […] A Bolzaneto sono cresciuto e ho imparato a gestire le prime paure, perché un immediato «pericolo» si ergeva poco lontano da dove abitavamo. Lo spauracchio aveva un nome, accresciuto dai vostri timori di genitori. Era poco più in là di casa nostra, una quindicina di minuti a piedi, e si chiamava via Giro del Vento. Si diceva fosse una via pericolosa, piena di legere. Di gentaglia pronta a tutto: rubare, rapinare, uccidere. Si diceva perfino che i poliziotti non volessero andarci e che quando una macchina della polizia si affacciava, tutto piombasse nel buio più totale. Silenzio e nero assoluto. Nessun lampione a rischiarare quella «periferia».
Mentre torna a guadare le strade, i vicoli e le piazze in cui è cresciuto, inumiditi dalla macaia genovese che può irradiare malinconia o mitigare l’animo, vecchie voci familiari – un padre, una nonna, uno zio – riecheggiano chiare e scortano le rimembranze su un nastro temporale che si svolge e riavvolge, di continuo. E i ricordi – siano essi innocenti, come il fanciullesco scorrazzare per il quartiere, o spettrali, come i vicoli, gli slarghi e i palazzi più bui – lo incalzano ovunque. Alcuni di un buio pesto, la cui lunghissima ombra risale al 2001, G8 di Genova.
Poco vicino al campo rom, poco vicino a quella che un tempo era via Bertelli, c’era lei. La caserma Nino Bixio, «la caserma», oggi ormai solo e semplicemente: «Bolzaneto». «Bolzaneto» io la conoscevo bene. Nel senso del luogo e della caserma. Uno pensa di vivere in un posto che se non è noto per la sua bruttezza, è quanto meno sconosciuto. Invece improvvisamente quel posto diventa il simbolo di qualcosa di più grande e clamoroso. Un luogo che da piccolo percepivi dai discorsi dei grandi, nei quali ogni tanto faceva capolino «la caserma»; un posto che poi si cominciava a sbirciare provando ad avvicinarsi, giocandoci a calcio quasi di fronte.
Paure ancestrali, vecchie ferite. Ma anche preziose reminiscenze: una nonna che, mentre impasta tortelli, tramanda il suo passato partigiano e operaio; un ragazzino che, prendendo a pallonate i muri e l’asfalto, sogna la sua iniziazione allo stadio. Eppure non c’è modo di abbandonarsi soltanto alla propria “leggenda privata”, perché afferrare la città pulsante e portuale che è Genova, attraente e ostile, fitta di scorci beati e luoghi oscuri, significa addentrarsi altrove: infilzare il centro cittadino, stretto tra il mito romantico di essere «il più grande d’Europa» e una gentrificazione in atto che ne rimodella l’essenza; poi ancora per i caruggi, «le strade strette con le case a strapiombo», pullulanti di botteghe, dicerie e movimenti d’ogni sorta; quindi il porto, industriale, con le gru e i muri di container che si stagliano dalla darsena, e antico, quanto l’effigie orgogliosa ma ormai consunta della Repubblica marinara che fu; infine la sopraelevata, che sorvola l’urbe col suo traffico imperituro e pennella una futuristica skyline.
Scorci beati e luoghi oscuri. Luoghi oscuri. Perché Genova, simile all’irriducibile Marsiglia di Izzo, ha un rovescio affatto consolatorio, forgiato nella storia banditesca e sottoproletaria che, per secoli, ne è stata un tratto distintivo. Attraversandola si respira, come direbbe Noodles di C’era una volta in America, “la puzza della strada”, intensa e inconfondibile. E del resto c’è stato un momento in cui molti Noodles italiani d’oltreoceano, proprio approdando a Genova, si sono ricongiunti alla loro terra d’origine. «Umbre de muri, muri de mainé / dunde ne vegnì, duve l’è ch’ané», cantava De André.
Giancarlo Fusco ha scritto un libro dal titolo «Gli indesiderabili». […] Il volume racconta le vite di tutti i gangster che nel Secondo dopoguerra furono restituiti dagli Stati Uniti all’Italia. […]. Dire “indesiderabili” negli Usa è come dire, una volta tornati, “inutili” in Italia. […] Fusco li aspetta a Genova. […] Arrivano con le navi: gli “indesiderabili” sono poveri, vecchi, hanno braccia secche, mani con le dita come artigli e soprattutto non hanno una lira. Hanno solo un passato discutibile che evidentemente risulta ormai fuori tempo massimo. Sparavano, sì, ma vivevano intorno a un business che non è più quello del periodo nel quale si vedono restituiti. E si ritrovano in un paese di cui non conoscono nulla.
Tra le varie “voci” altre della narrazione, prende allora parola anche “il Ghedda”, personaggio ambiguo, che si muove in una doppia zona d’ombra: da una parte il limbo tra verità e finzione – rientra davvero nel serbatoio biografico dell’autore? –, dall’altra la sua rocambolesca esistenza, dopo aver “rinnegato” le nobili origini ed essersi dato ai traffici illeciti che animano il milieu genovese. Di padre libico, da cui il soprannome, e di madre genovese-israeliana, il “Ghedda”, come egli stesso dichiara, è la voce attraverso cui leggere la storia dalla parte «dei meschini, dei farabutti, dei senza virtù, dei disperati». Si presenta come un sodale di F., il fratello del padre dell’autore, ma il suo vero ruolo nell’impianto della narrazione è quello di una figura mediana, una specie di cerniera sociale del centro cittadino che, riavvolgendo le sue attività di contrabbando – il mercato nero delle sigarette, del gioco d’azzardo, della droga e della prostituzione – demarca e al tempo stesso unisce i quartieri bene delle famiglie altolocate a quelli delle legere, dei farabutti e delle puttane. Due mondi che risultano tanto distanti quanto vicini, resi interdipendenti dalla legge più antica del mondo: quella della domanda e dell’offerta. E il “Ghedda”, scandagliatore di vicoli e irriducibile faccendiere, sceglie il secondo versante, con tutte le contraddizioni che vi esplodono dentro.
La mia conoscenza del porto, delle navi e la mia capacità di capire quanto poteva essere richiesto dal mercato derivava proprio dalla mia condizione esistenziale: sono nobile, sono nato ricco, ma ho saputo mischiarmi e trovare un mio posto nel mondo. Ho dovuto fregare qualcuno, blandire altri, ma ho sempre considerato le mie attività una missione, l’unico modo di sentirmi a tutti gli effetti un abitante di questa città. Ho finito, a costo di poter apparire un fanfarone, per personificare Genova.
Personificare una città. Al punto di renderla protagonista del racconto. Per assolvere tale intento, sembra essere la dichiarazione poetica dell’autore, non bastano gli strumenti classici del romanzo. Si deve ricorrere a qualcos’altro. Sulla scia di Ermanno Rea, prima, che ha fatto scuola con Mistero napoletano (1995), e Antonio Pascale, dopo, con La città distratta (1999), anche la prosa messa in campo da Pieranni si fregia di stilemi e dispositivi che vanno ben oltre la semplice descrizione paesaggistica e, quindi, la concezione del territorio urbano alla stregua di un mero fondale per la rappresentazione.
Di qui il ricorso a una molteplicità di mezzi narrativi, che vanno dall’archivio storico alla toponomastica e sono vivificati da un impianto polifonico che vede alternarsi l’autofiction a una serie di voci. Quattro, per la precisione: #La madre di mio padre; #F., il fratello di mio padre (bolañana è la riduzione del nome per esteso a una lettera e la sua ricomparsa in altre opere, in questo caso il libro precedente); #Il Ghedda; #Mio padre, tutte segnate da una dialettica generazione che non è mai solo intima né anagrafica e, come spesso accade nella vita reale, dall’aporia tra materia biografica e artefatta.
L’autofiction, infine. L’utilizzo che Pieranni ne fa, ben lungi da un ripiegamento intimistico, tiene fede all’obiettivo di conferire protagonismo a Genova, attraverso il dinamismo e l’azione effettiva dell’io, che non si limita a riflessioni e digressioni personali rispetto ai luoghi natii, ma si muove e trascina il lettore per le vie e i cantoni, in lungo, in largo e in obliquo, in maniera simultanea e progressiva rispetto al tempo e allo spazio della città.
Sono quasi all’altezza del vicolo più stretto di Genova. Poco prima ho percorso via San Luca, Fossatello, via del Campo, caruggi noti a qualsiasi genovese. Da via Prè ho preso alcuni vicoli, stretti e scuri: qua e là africani in gruppetti indaffarati a osservare, fare, disfare. Qualcuno gioca con un pallone, altri fumano. In altre vie, in quella parte del centro storico dove sembrano vivere solo i residenti e completamente esclusa dai percorsi turistici e da quelli di molti genovesi, alcune entrate sono bloccate dalla spazzatura ammassata, in altri casi l’aria è densa di tensione. Non so se è una mia sensazione, di uno ormai poco abituato a certi sentieri cittadini; è pomeriggio di un giorno feriale. Poco prima ho percorso vico dell’Argento, salita dell’Oro, vico della Croce Bianca, via San Pietro della Porta, via dei Conservatori del Mare. In quelle vie cercavo alcuni momenti del passato, persi tra ricordi e odori: fermarci davanti ai negozi di spezie, cercare la focacceria migliore, rovistare tra le bancarelle dei libri…
Il corpo impatta con il presente, vivo e tangibile, la mente con la storia che attiva memoria individuale e collettiva, nello strenuo confronto tra vissuto proprio ed esperienza comune, che è il duello d’una vita.
Nell’incipit di Settantadue, l’esordio narrativo dell’autore, comparivano alcuni versi dalla Love song of J. Alfred Prufrock di Eliot. Accanto allo scarto di maturità, allora, in Genova Macaia ritroviamo la vena poetica – le pennellate descrittive sono intarsiate di versi e rimandi in cui il lettore più accorto riconoscerà De André e Fossati, tra i tanti – ma soprattutto il coerente e incessante bisogno di misurarsi con la materia narrativa. Pieranni, infatti, mette in gioco tanto la sua esperienza giornalistica quanto la sua avidità di lettore: un’operazione che si traduce in un fitto dialogo tra gli strumenti del reportage – seguendo un fil rouge che passa da Rea e Pascale, come già detto, per arrivare a Saviano – e la narrativa di genere, così che la mappatura sul campo e la dimensione d’inchiesta si nutrono di atmosfere e personaggi ispirati all’universo crime di James Ellroy o alle tinte noir di Jean-Claude Izzo. Il risultato finale, forse, è quello di aggiungere altre declinazioni ai dispositivi del racconto che riguardano il rapporto tra narrazioni ibride e territorio, nello strenuo tentativo di afferrare la città, il luogo culminante delle contraddizioni societarie. E tutto questo, è insieme un atto poetico e politico.
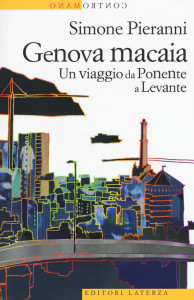 Simone Pieranni, Genova macaia. Un viaggio da Ponente a Levante, Laterza-Contromano, Roma-Bari 2017, 147pp. 14€
Simone Pieranni, Genova macaia. Un viaggio da Ponente a Levante, Laterza-Contromano, Roma-Bari 2017, 147pp. 14€