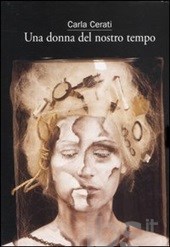[Giovedì 15 ottobre, alle 18.45, allo Spazio Tadini di via Jommelli 24, Milano, si terrà la presentazione del numero 65 di “Nuova Prosa”, curato da Giacomo Raccis e dedicato ai Maestri ritrovati. Si tratta della prima serata di un ciclo intitolato Letture al largo @SpazioTadini, organizzato dalla Balena Bianca. Proponiamo un estratto da uno dei contributi presenti nel volume che verrà presentato domani].
Sulla scena
Carla Cerati inizia la sua carriera come fotografa di scena. Nel 1960 fissa su pellicola Aspettando Godot di Tullio Pendoli, lavora per la compagnia del regista Franco Enriquez, fotografa il ballerino di flamenco Antonio Gades […]. E poi fotografa il Living Theatre, la rivoluzionaria creatura Off-Broadway, sorta nel 1947 a New York dall’incontro fra Judith Malina, attrice, regista, allieva di Piscator, e Julian Beck, pittore, attore e scenografo, che rappresentano molti dei loro spettacoli anche in Europa. Sono immagini sorprendenti, in equilibrio tra intensità emotiva e fredda lucidità, scatti che fissano i volti degli attori e le vibrazioni dei loro corpi: dapprima l’Antigone nel 1967 al Teatro Durini di Milano, poi le figurazioni allucinate del Frankenstein nel 1968 a Modena, e nello stesso anno le fotografie di Paradise Now, scattate nell’ambito del Festival del teatro di Avignone due mesi dopo il Maggio francese […].
Ma è l’Antigone ad affascinare in maniera particolare Carla Cerati. Lo spettacolo che lei immortala nel 1967 scaturisce dallo studio dell’album fotografico e delle note dell’Antigone sofoclea tradotta da Hölderlin, ma rivisitata in chiave politica da Bertolt Brecht nel 1948 (per il drammaturgo tedesco, Creonte è un’anticipazione di Hitler), che viene poi a sua volta innovata dal Living. […] Non solo nel 1974 Carla Cerati espone ottanta fotografie di scena dell’Antigone in una mostra alla galleria Primopiano di Torino, ma in seguito riprende le immagini del Living, le scruta con insistenza, le modifica, le stravolge. Realizza otto fotografie che lei denomina Elaborazioni sull’Antigone, un esperimento portato avanti in diverse fasi: «nel 1972 osservando le foto di gruppo del finale dell’Antigone (…) resto colpita dalla molteplicità delle espressioni dei volti e delle mani», scrive la fotografa. In seguito ne isola alcuni particolari ampliando la drammaticità del dettaglio; nel 1983 ingrandisce nuovamente le fotografie e sperimenta diversi viraggi, ottenendo «ingrandimenti sgranati che paiono sindoni di anime torturate», scrive Uliano Lucas (La ricerca e il racconto).
Lo sguardo di Antigone
Antigone, la giovane fanciulla che disobbedisce alle leggi del tiranno Creonte (qui ha le sembianze di Julian Beck) e decide di seppellire il fratello Polinice, è interpretata da Judith Malina. Nelle immagini di Carla Cerati il suo volto è intenso, le guance segnate da righe di lacrime scure, gli occhi neri, pesantemente truccati in contrasto con il pallore del volto, la mano vicina alla bocca aperta, come a proteggersi dal suo tragico destino. E poi lo sguardo: sconvolto ma allo stesso tempo lucido e tenace, che oppone la fragilità al dispotismo del potere, e incarna, scrive George Steiner, una femminilità esclusa, «soggetta per millenni agli oltraggi e alla condiscendenza del maschio, che ora è pronta a scagliarsi contro le convenzioni della morte che le guerre, il capitalismo e il “principio di realtà” dominati dal maschio incarnano»(Le Antigoni).
Ma chi è davvero Antigone? «Io credo che Antigone è dentro tutti noi quando rifiutiamo di fare ciò in cui non crediamo, quando diciamo no, anche quando la legge minaccia di punirci» afferma Judith Malina, in un’intervista pubblicata su Doppiozero a luglio del 2013, e prosegue: «siamo tutti Antigone: qualcuno vuole fare solo piccoli passi, altri grandi salti verso il cambiamento più radicale. Ma tutti contribuiscono a rifiutare il ruolo nelle forme della vita sociale». […] Antigone è un insieme di doppi: la persona e lo stato, ciò che è legge e ciò che è giusto, l’amore e la morte. Sono questi i dilemmi che ne caratterizzano il destino. Ma un ben moderno destino, scrive Rossanda, se è vero che Antigone è definita dal Coro «autónomos, come colei che da sola si dà la sua legge», al massimo della «coscienza di una solitudine a nessuno imputabile se non a sé» (Antigone ricorrente). «Ōmós è il suo carattere, dirà ancora di Antigone il Coro (…) letteralmente al di là dell’umano, un’ostinazione inflessibile», incrollabile sino all’estrema conseguenza. Per questo, anche prese la dovute distanze, conclude la Rossanda, «ci scopriamo come Antigone nelle sue ultime ore. Come lei non crediamo alla sacralità dei potenti (…), come lei siamo determinati ad affermare, in solitudine, l’io, anche se il suo io non ha molto a che fare col nostro. Ci uniscono il principio d’autonomia e di disobbedienza».
Così è lo sguardo di Carla Cerati: disobbediente e ostinato perché autonomo. Per lei, madre di due bambini, sposata e casalinga, fotografare e scrivere ha voluto dire “uscire dalla gabbia”, scoprire l’universo fuori dalla porta di casa, ma anche se stessa: i desideri, le aspirazioni, la possibilità di esprimersi. Il proprio lavoro ha rappresentato un mezzo per raccontare e raccontarsi, per vivere una sua creatività e scoprire il mondo intorno a sé, ricorda Uliano Lucas, con cui ha lavorato, realizzato reportage e mostre, organizzato dibattiti negli anni delle lotte dell’AIRF per la tutela del fotoreporter.
«Per me fotografare», racconta Carla Cerati, «ha significato la conquista della libertà e anche la possibilità di trovare risposte a domande semplici e fondamentali: chi sono e come vivono gli altri? Lavorano? E se sì, dove lavorano? Quali sono i mestieri, le professioni e i luoghi in cui le svolgono? Come trascorrono il tempo libero?» (Scritti). Un bisogno di indipendenza e “autonomia” che giunge direttamente alle sue immagini in cui essa arriva a creare uno spazio sospeso, un’istante ideale, dove riesce a far vivere i soggetti che fotografa in una dimensione di libertà illimitata, senza rinunciare al suo punto di vista, al bisogno di esistere e guardare in modo nuovo il mondo che la circonda. […]
Il mondo intero entra nel suo obiettivo, con l’ostinazione di chi non intende tralasciare alcun dettaglio: l’esperienza sconvolgente e indimenticabile del fotografare i malati dei manicomi con Gianni Berengo Gardin, poi confluita nel celebre volume Morire di classe (1969), l’«eccentricità e l’opulenza» delle classi protagoniste del boom economico, anticipazione della “Milano da bere”, raffigurati come maschere deformate in Mondo Cocktail (1974). […] Ed inoltre, il corpo femminile con le immagini di una scultorea (e quasi imbarazzante) bellezza nel libro intitolato Forma di donna (1978) e quelle a colori di Forma Movimento Colore. Nudo Danza, realizzate nel 1987-1988 con la collaborazione della danzatrice Valeria Magli.
Sin qui nella fotografia. Ma cosa accade nei romanzi? Se con la fotografia “uscire dalla gabbia” ha voluto dire espandere le possibilità della visione, nei romanzi, al contrario, l’occhio di Carla Cerati penetra nel mondo domestico. Sono la casa e la famiglia a costituire, direbbe Jurij Lotman, il «centro semiotico», della sua opera di scrittrice, uno spazio angusto di cui essa svela i meccanismi, facendo implodere, come un vecchio edificio, il sistema di “leggi” e l’ipocrisia dei codici che regolava il mondo borghese, in cui essa stessa, suo malgrado, si trovava a vivere.
In questa dimensione di profondo dissenso, in rottura con la condizione di isolamento e condizionamento in cui generalmente veniva relegata la donna all’interno dell’istituzione familiare, torna di nuovo a farsi viva l’Antigone, quella che il coro della tragedia sofoclea definiva «autónomos» ovvero «colei che da sola si dà la sua legge».
Una legge che per Carla Cerati si riconosce nel tentativo di mettere in crisi, con la sua scrittura, la contrapposizione tra il femminile identificato con la natura e il maschile confuso con il linguaggio, per restituire alla cultura e alla politica, come suggerisce Lea Melandri, «quel retroterra di esperienza, confinata nelle case e nel corpo delle donne», affinché insieme al corpo possa prendere posto «nella polis, la “persona”, vista nell’interezza delle sue molteplici identità e appartenenze, sociali, sessuali, linguistiche, culturali» (Corpo).
I romanzi
Ciò che colpisce nei romanzi di Carla Cerati è l’implacabile durezza. Anche nella scrittura sembra che lo sguardo «autonomo e disobbediente» di Antigone si insinui ovunque, seduca il testo, nel senso che lo conduca a sé: ne faccia propri i percorsi, le frasi, la lucida determinazione. Non vi è nessuna ipocrisia nel suo modo di raccontare una storia, nessun tentativo di nascondersi, di mascherare la materia narrata. Il linguaggio è crudo, spoglio, una lingua aderente al corpo del testo (e al corpo dell’autrice), ovvero la condizione della donna all’interno dell’universo familiare (le sue opere sono decisamente autobiografiche), descritta con un amalgama di passione, disperazione, forza, delicatezza, malinconia.
Carla Cerati esordisce nel 1973 con il romanzo Un amore fraterno, nel quale l’autrice rievoca l’infanzia e le avventure dell’adolescenza condivise con il fratello maggiore morto prematuramente, a cui era legata da sentimenti di affetto e complicità. Essa descrive un momento della vita, che corrisponde a un’idilliaca condizione – quella del buon selvaggio di Rousseau? – in cui contrappone la positività morale del “primitivo” alla corruzione della civiltà e all’ipocrisia dei rapporti fra gli adulti. […]
Una sudditanza psicologica e materiale – ontologica? – a cui essa contrappone (come nelle sue immagini) l’insopprimibile bisogno di comunicare, capire, illuminare, vera e propria ossessione panottica, che pone tanto la voce narrante, come la stessa narratrice al centro della sua prigione di vita e scrittura: «cerco di capire», «non trovo dentro di me», «pensavo…mi pareva», «andavo cercando dentro di me», sono gli interrogativi che si pone – e che per certi aspetti trascendono gli eventi narrati – per divenire il vero nucleo della sua ricerca e del suo essere nel mondo.
L’obiettivo allora si sposta: da un idilliaco e brevissimo momento di autonomia e libertà – l’amore fraterno – archetipo di un rapporto sottratto alle imposizioni delle gerarchie – Carla Cerati si inoltra in ciò che lei stessa definisce la peggior prigione in cui abbia vissuto: il matrimonio borghese e la vita fra le mura domestiche, confini di uno spazio che diviene una sorta di “micromondo” in cui, come in barca, ognuno ha un ruolo e compito preciso. E alla donna spetta quello di presidiare uno spazio compatto e indistruttibile, uno spazio di invisibilità e silenzio, che l’autrice decide di «aprire» direbbe Georges Didi-Huberman, di smascherare, proprio con lo stesso medium che le viene negato: la parola.
Da questa profonda necessità, la Cerati fa sgorgare un inarrestabile flusso narrativo, quasi mille pagine di interrogativi e invettive che si dispiegano in una trilogia di romanzi: Un matrimonio perfetto (1975), La condizione sentimentale (1977) e Il sogno della bambina. (Uno e l’altro) del 1983, in seguito ristampati nel 2005 in un unico cofanetto dal titolo: Una donna del nostro tempo. […]
Tutto è ormai privo sia di ragione che di sentimento. La protagonista, archetipo della casalinga disperata, versione anni Sessanta, non ha scampo: è imprigionata in un ruolo di moglie e di madre, senza alcuna via di fuga, nemmeno nelle illusorie scappatelle extraconiugali a cui tenta disperatamente di aggrapparsi. La parola le è negata, il suo sguardo non ha il potere di diventare punto di vista e visione del mondo. Non esiste alcun universo alternativo, mitico, favoloso, sognante o liberatorio. «Io fedele Penelope stavo a casa», «e Fabrizio altrove», dice la protagonista del romanzo. Eppure essa non si accontenta di “esistere”, vuole spezzare i lacci che la tengono prigioniera, liberare lo spazio claustrofobico della casa e dei suoi sentimenti. In una parola vuole l’amore: «di me ho capito una cosa: che sono innamorata dell’amore», ammette la protagonista. Ma non è anche questa un’ipocrisia? Non è anch’esso, l’amore, una parola intrisa di falsa retorica romantica (e borghese)? È per questo che alla protagonista non è riservata alcuna via d’uscita?
Se nell’istituzione del matrimonio, come nell’amore romantico, Carla Cerati non riesce a individuare il punto di equilibrio, ecco che la sua ostinata ricerca viene convogliata nel tentativo di raccontare una storia, nel trasformare «i suoi testi terribili» e disobbedienti, in «testi invitanti», direbbe Roland Barthes, con quel «poco di nevrosi necessaria alla seduzione dei loro lettori», che trovano la ragione di esistere nella “coazione a ripetere”, insita nell’ostinata azione di narrare.
Così, nello spazio tra la dichiarazione della prima pagina, e la disperata rivendicazione della pagina finale, si consuma la disgregazione della cultura borghese, resa ancora più lucida dal fatto che non esiste lieto fine, ma solo (per dirla con Antigone) la certezza della propria irriducibile soggettività […]. Nel solco di questa certezza, ovvero di un’identità ormai conquistata, Carla Cerati descrive un altro tipo di rapporto fra uomo e donna. Dopo la coazione a ripetere del matrimonio (e del tradimento), l’ambiente in cui si origina il dramma (il libro termina con il suicidio dell’amante), è quello dell’alta borghesia intellettuale in cui si consumano rapporti umani con una rapacità inaudita.
In questo romanzo la scrittrice sembra voglia proporre una possibile alternativa, che si rivela inconsistente: l’uomo perfetto, l’amante, che esaudisce tutti i desideri erotici, in una relazione adulterina, ma a differenza di un marito, non è altrettanto disponibile. Anche in questo caso il titolo è rivelatore: La condizione sentimentale. […]
Ora rimane un ultimo romanzo per chiudere la trilogia. Si intitola Il sogno della bambina (Uno e l’altro) e rappresenta il luogo di una possibile sintesi, una mediazione: qui la protagonista femminile, Nora, è moglie, madre e anche amante. Ogni archetipo da lei incarnato viene posto di fronte a dei dilemmi: il marito o l’amante? La fedeltà o la trasgressione? La libertà o la cura dei figli? C’è un cambiamento anche nella voce narrante. Se nei due romanzi precedenti, Carla Cerati si avvale della prima persona, in quanto sottende un rapporto di partecipazione emotiva dell’io narrante molto più diretto, in quest’ultimo a differenza dei libri precedenti, la scrittrice decide di regalare a ciascun personaggio «un proprio flusso di coscienza, o monologo interiore». A ognuno di essi viene restituita una voce e un punto di vista sulla vicenda.
Tuttavia ciò che assilla la narrazione, è un sogno. La protagonista vede una bambina. Le torna alla mente molto spesso: è sdraiata sul fianco sinistro, con le gambe ripiegate all’indietro e le braccia abbandonate verso il viso. Indossa un vestito di cotone bianco latte a fiorellini neri, i capelli chiari, leggermente mossi, erano tagliati sotto le orecchie. Gli occhi sono chiusi e sembra che dorma. Perché, si chiede la protagonista, «aveva subito pensato che fosse morta?». Qual è il senso di questa immagine? Si tratta forse di “un ritorno del rimosso”, di quell’infanzia dipinta come unico momento di autentica felicità, che aveva descritto nel suo primo romanzo? […] Lasciando morire la bambina, l’autrice lascia morire anche il passato e il futuro della protagonista. Per lei si apre un presente in cui il sogno di una libera e piena affermazione di sé, è inafferrabile come una luce nel buio. Tuttavia se nello spazio fittizio e romanzesco di Carla Cerati, non c’è alcun giardino delle delizie, rimane intatta l’ostinata consapevolezza di aver raccontato, con la sua scrittura, una possibile via d’uscita. È da questa lente che essa guarda con totale assenza di ipocrisia il mondo fuori, con lo sguardo di chi compiendo un rifiuto, riesce a colpire dritto il soggetto che descrive con la penna e fissa con l’obiettivo.