Fra il 1992 e il 2005 Bill Vollmann viaggia variamente fra Thailandia, Yemen, USA, Colombia, Messico, Giappone, Vietnam, Afghanistan, Russia, Cina Birmania, Ungheria, India, Iraq, Serbia, Australia, Congo, Kenya, Kazakistan e Filippine per incontrare e intervistare i poveri di quei Paesi. A loro, a tutti loro, Vollmann fa più o meno la stessa domanda: Perché sei povero?. Il resoconto di questa esperienza, e le risposte a questa impossibile domanda, si possono leggere in un libro uscito nel 2007, I poveri, e ora finalmente tradotto in italiano da Cristiana Mennella per minimum fax. E fin dall’incipit del primo capitolo ne intuiamo la stranezza e la particolarità: «La prima volta che incontrai Sunee ero a Klong Toey in cerca di una persona a cui poter chiedere perché esisteva la povertà».
Dire cos’è esattamente I poveri non è impresa facilissima perché è molto più di un diario di viaggio, è molto più di un’inchiesta e non è semplicemente un saggio. Come d’altronde molta non-fiction contemporanea ci ha ormai insegnato (e a ben vedere molti hanno imparato, se non da David Foster Wallace, proprio da Vollmann), I poveri confonde i piani: si tratta di un testo centrifugo che procede per salti e balzi, viola scientemente l’andamento cronologico del reportage, si muove senza soluzione di continuità su aree geografiche differenti, fa un uso smodato di documenti contemporaneamente contraddicendoli o problematizzandoli, oscilla fra l’intervista, l’aneddotica, la statistica, la memorialistica e il saggio. A fare da principio ordinatore c’è la costante riflessione non tanto (non solo, non semplicemente) sulla povertà, ma sull’esperienza di essere poveri – o sul tentativo di approssimarsi a quell’esperienza, di comprendere una realtà totalmente sconosciuta allo scrittore che la guarda, e altro non può fare, da fuori: «Io non desidero conoscere la povertà», scrive Vollmann nell’introduzione, «perché significherebbe vivere la paura e la disperazione. Perciò posso solo coglierla a sprazzi dall’esterno».
Di riflessioni sui problemi e sulle aporie della rappresentazione documentaria di un’alterità asimmetrica I poveri è pieno, quasi da far sospettare che il vero oggetto del libro sia questo: già nel colophon iniziale si legge «Ho fatto soldi sulle spalle dei poveri» e nella prefazione Vollmann intesse un serrato confronto con il capolavoro della stagione documentaria della letteratura americana degli anni Trenta, Sia ora lode agli uomini di fama(1941) di James Agee e Walker Evans, un reportage modernista sulla vita di tre famiglie di fittavoli dell’Alabama dopo la Grande Depressione (ne ho parlato più estesamente qui). Il confronto con questo caposaldo della tradizione del photo-essay book è funzionale a iniziare un costante dibattito sul problema etico dell’osservazione (del resoconto e della fruizione) da una posizione di privilegio – «Io so che sono ricco» si intitola uno dei capitoli finali dei Poveri.
Lo sforzo di Vollmann, da questo punto di vista, è quello di rimettere in causa l’asimmetria (ineliminabile) che caratterizzava il libro di Agee e Evans attraverso una serie di strategie formali (etico-estetiche) e di relazioni con i suoi intervistati, a partire dalla scelta di pagare i suoi intervistati (delineando così un rapporto che si vuole idealmente una transazione e non uno sfruttamento): «Esatto! Io le pagavo; ero ricco! Quindi potevo essere invadente quanto volevo? In Sia lode ora a uomini di fama, mentre i protagonisti del libro erano in chiesa, Evans e Agee ispezionarono ogni centimetro delle loro case. Solo tu, lettore, puoi decidere se la conoscenza acquisita leggendo questo lungo brano del libro giustifica i mezzi». È evidente che i tentativi di Vollmann non risolvono le aporie dell’asimmetria (nulla esclude, d’altronde, che una transazione sia uno sfruttamento), così come non lo risolvono le sue scelte formali, a partire dal modulo dell’intervista, inglobata problematicamente nel discorso dell’io autoriale, riportata attraverso dei discorsi diretti liberi non segnalati e quindi confusi e uniformati con il racconto e le riflessioni di Vollmann. È una scelta che nasce, in una qualche misura, anche da condizioni contingenti, ovvero l’impossibilità di riportare alla lettera molte di queste interviste in quanto arrivate a Vollmann, a sua volta, attraverso la mediazione di un interprete; ma si tratta anche di una scelta di poetica che segnala la difficoltà (se non l’impossibilità) di annullare la scissione fra osservatore e osservato. E testimonia anche dell’assunzione di un preciso punto di vista; inglobare formalmente le parole dell’altro nel proprio discorso significa anche assumere quei punti di vista, nel tentativo di evitare uno sguardo paternalista e sentimentalistico.
Tuttavia, Vollmann riesce a mettere a frutto queste problematiche considerandole appunto come tali e facendone un aspetto decisivo della sua trattazione che gli permette di tornare costantemente sulle proprie posizioni, di ridiscuterle e offrire un ritratto pluriprospettico e sfaccettato della povertà («questo libro abbonda di ipotesi e interpretazioni, che però sono il mio sincero tentativo di comprendere dei fenomeni»), riuscendo, contemporaneamente, a offrire dei ritratti convincenti e riusciti delle persone intervistate, colte nel vivo della propria esperienza. Si tratta, per Vollmann, di ragionare soprattutto su dei piani che siano in grado di tenere conto della percezione individuale del proprio stato, del rapporto fra povertà e normalità percepita e consapevolezza della propria condizione. Vollmann, non a caso, rifiuta la nozione marxista di falsa coscienza: se l’obiettivo è trattare la povertà come un fenomeno soggettivo (o quanto meno come un incontro fra condizioni economiche e condizioni emotive), un’esperienza, piuttosto che uno stato economico, la prospettiva marxista classica si rivela, ai suoi occhi, insufficiente e viene fin da subito problematizzata avvertendo del labile confine fra disvelamento e demistificazione della falsa coscienza e pratica colonialista e di controllo. Ma la questione non è liquidata con facilità: infatti viene spesso messa in luce la difficoltà di espressione e comprensione dei soggetti intervistati, sia attraverso commenti autoriali sia attraverso l’esposizione delle falle e delle contraddizioni dei racconti.
A complicare ancora di più la questione c’è la difficoltà a riportare a denominatori comuni le irriducibili diversità di esperienze di persone intervistate e le loro differenti percezioni del proprio stato: da un’ubriacona thailandese al pescatore di tonno dello Yemen, passando per un’anziana donna malata di epilessia e nata in Siberia, una mendicante indiana, una raccoglitrice cinese di immondizia. Il catalogo dei poveri intervistati da Vollmann è, così, estremamente plurale e complica la possibilità di elaborare una definizione accettabile di povertà: «In breve, le definizioni di povertà sono così svariate che si potrebbe dire: Lo sa Allah! Io non lo so», come effettivamente dichiara una donna, «Ma so che Sunee», continua Vollmann,
«è povera e che Wan è più povera. Lo so perché provo un dolore sordo ricordando la prima, e angoscia se ripenso alla seconda. Per me la povertà non è semplice privazione; una persona può possedere meno cose di me ed essere più ricca; la povertà è infelicità. Quindi sarà per forza un’esperienza anziché una condizione economica. Quindi continua a non essere misurabile. Se gli statistici ci assicurassero che una data percentuale di esseri umani sono infelici, dubiteremmo della loro precisione. Non avendo il dono della telepatia (o della perfetta empatia), associo i fattori economici a quelli emotivi, nella speranza di fare qualche confronto tra le persone, per quanto vago e approssimativo; riesco a concepire meglio la povertà come una serie di categorie percettive».
I poveri, dunque, se non può essere solamente un testo scientifico basato su fatti, dati e documenti, o una riflessione filosofica, non può nemmeno essere semplicemente una collezione di racconti orali di soggetti subalterni che riportano la propria esperienza e la propria concezione di povertà; la soluzione sarà nell’intersezione fra queste tre modalità: l’attenzione e la cura alle percezioni dei singoli sono così problematizzate di continuo, ma senza venire sminuite o apertamente contraddette. Si tratta piuttosto di una continua interrogazione che le mette in dubbio, ma senza annullarle. Un tentativo di apertura totale, insomma, che riesce a tratteggiare l’esperienza della povertà senza stereotipi e griglie interpretative prefabbricate (pur tuttavia non senza i suoi rischi: «La povertà non è mai politica». Mai?).
I poveri si chiude con una lunga sezione di 128 fotografie dell’autore (e particolarmente apprezzabile è la scelta di minimum fax di riprodurle su carta patinata) che allargano e amplificano la narrazione, costituendo un ulteriore punto di forza di questo libro. La narrazione fa spesso riferimento alle fotografie attraverso una struttura che potremmo definire ipertestuale: con l’utilizzo di parentesi quadre e grassetto il testo rimanda in maniera esplicita alle fotografie che visualizzano le scene di cui si sta parlando e in questo modo anche la descrizione può focalizzarsi soprattutto nel sottolineare solamente gli aspetti decisivi ed emotivamente più d’impatto. Le foto sono raggruppate in 21 sequenze titolate di carattere tematico: nella maggior parte dei casi sono appendici o estensioni dei capitoli, ma molte presentano persone di cui non si parla nel testo e la cui esperienza è ricostruita soltanto attraverso la giustapposizione degli scatti e l’interferenza con i titoli delle foto. Si tratta, insomma, di un montaggio atto a costruire ulteriori percorsi di lettura e altre narrazioni. Sono fotografie, quelle di Vollmann, che puntano tutto sull’accumulazione, sul disordine (che si tratti di scatti in posa o istantanee): i poveri ritratti sono asfissiati dal disordine e dalla confusione che li circonda.
E si potrebbe attribuire un doppio valore a questa confusione: da un lato è la dura realtà materiale con cui l’esperienza di vita di queste persone è costretta a scontrarsi, ma insieme è anche il motivo (non solo) visivo che dà forma un po’ a tutto il libro: la difficoltà di queste persone di comprendere o esprimere la propria condizione, la confusione dell’autore nel mettere ordine a una mole di dati ingovernabile, l’impossibilità di conoscere davvero la povertà da una posizione privilegiata, la natura centrifuga della narrazione e della trattazione.
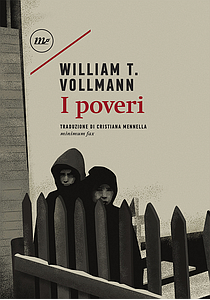
William T. Volmmann, I poveri, trad. C. Mennella, minimum fax, Roma 2020, 496 pp. 19,00€