In uno dei suoi ultimi romanzi, La sfinge dei ghiacci, Jules Verne decide di andare sulle tracce di Gordon Pym, il giovane personaggio dall’ambizione quasi diabolica che Edgar Allan Poe aveva lasciato in balia di un misterioso gigante bianco, nei pressi del polo Sud, in un finale che ha reso epico Le avventure di Arthur Gordon Pym. In quella scena, la sagoma gigantesca staglia il proprio biancore su uno scenario paradossalmente cinereo, una fitta nebbia scura che improvvisamente fa spazio a un vero e proprio “naufragio del bianco”, un dissolversi in un bianco che è meta regressiva – ritorno a un’origine ricca di tutte le potenzialità – e che da alcuni è stato interpretato metaforicamente come una sconfitta della scrittura (il nero), che soccombe di fronte al bianco ineludibile della pagina. Ed è forse questa sconfitta, o più probabilmente il dubbio che la storia di Gordon Pym non finisse in quel naufragio, che spinse Verne a continuarla, e così facendo a tradirla, immaginando il ritrovamento del cadavere del marinaio di Poe all’interno di una sfinge metallica e nera; e, soprattutto, demistificando il percorso visionario di Poe alla luce del razionalismo scientifico che guida tutte le sue opere[i].
Il bianco come colore che ribalta, purificandolo o cristallizzandolo, un immaginario tradizionalmente associato al nero è al centro anche del nuovo romanzo di Andrea Tarabbia,Il continente bianco. Questo è il nome che si dà un’organizzazione di stampo neonazista che, segretamente e con l’appoggio di qualche esponente del Palazzo, pianifica una specie di controrivoluzione armata, da condurre a colpi di raid intimidatori e falò purificatorî, guidata dal miraggio di poter realizzare una società che trova la propria armonia nel rispetto delle regole e delle gerarchie, ma soprattutto nel fatto che tutte le persone si somigliano, in una superfetazione del desiderio di annullamento dell’altro. Il bianco a cui questa organizzazione si ispira è quello in cui si annullano tutte le differenze, in cui gli apocrifi valgono quanto le scritture documentate, in cui la violenza, la sopraffazione, l’odio trovano una dimensione assoluta, in certo senso cristallina.
Il bianco torna così a essere il colore di un’ossessione. Quella dei membri del “Continente bianco”, convinti di vivere sotto l’assedio di una cultura fragile e tollerante, che respinge il dolore invece di accoglierlo e trasformarlo in strumento di potenza; convinti che la forza per vivere e lottare si possa trovare nell’odio e non nella sopportazione passiva. Ma è anche quella dello scrittore, Andrea Tarabbia, che con questo romanzo si mette in gioco in prima persona sperando che questo serva a fare chiarezza sul potere della scrittura romanzesca di compensare o sublimare quella che si vorrebbe essere una connaturata propensione dell’uomo al male.
All’origine di questa ossessione ce n’è però un’altra, quella per un libro. Come La sfinge dei ghiacci di Verne fa con il Gordon Pym, infatti, anche Il continente bianco riscrive un romanzo, L’odore del sangue di Goffredo Parise. Uscito postumo e pubblicato a partire da un unico dattiloscritto con alcune correzioni d’autore, questo romanzo riporta il flusso di discorso di un uomo di mezza età che vede progressivamente trasformarsi la propria moglie, irretita dalla frequentazione di un giovane borghese che si dà arie da picchiatore fascista (si parla di Ordine Nuovo). Questa trasformazione, che il narratore segue in parallelo alla propria storia sentimentale ed erotica, di uomo abituato a tradire eppure sempre emotivamente fedele alla propria consorte, conduce la donna alla morte, in un percorso di crescente e masochistica sottomissione ai desideri del giovane amato (che la invita prima a concedersi ai propri amici, poi a prostituirsi, infine a darsi totalmente alla sua violenza). La scrittura di Parise acquista in queste pagine una pesantezza, una densità ricorsiva che sono l’esatto contrario della levità dei Sillabari; uno stile che (al netto di alcune evidenti ripetizioni strutturali che sarebbero forse state emendate in fase di revisione del dattiloscritto) si attaglia perfettamente all’intorpidimento della facoltà del narratore, preso come da una «narcosi» nel momento in cui avverte Silvia, la moglie, in preda a quello che definisce «l’odore dell’origine della gioventù, della passione, della vita». È l’odore del sangue, che inevitabilmente richiama l’odore della morte tragica e fatale, che il narratore comincia a intravvedere nel destino della donna.
All’insegna dell’attrazione degli opposti, di un’attrazione per la vita che si ribalta in pulsione di morte, di una fedeltà al bene che nasconde, nel profondo, un desiderio di male e, ancora, di una bellezza che si manifesta a braccetto con l’orrore, si definisce anche Il continente bianco. Nell’Avvertenza Tarabbia rivela la sua ossessione per quel romanzo “imperfetto” eppure “definitivo” di Parise, il suo tentativo di penetrarne il segreto e il fallimento che ne è conseguito. Da lì una fuga e una ricerca che prende corpo nelle pagine del Continente bianco, esperimento narrativo insolito, tentativo di appaesamento di uno scrittore nell’immaginario di un altro e, al tempo stesso, tentativo di sovversione o di rivisitazione di quell’immaginario. D’altra parte è Tarabbia stesso ad affermarlo: «Non so raccontare una storia dal vero senza mescolarla con la letteratura e dunque con l’imaginario altrui». E questa volta lo fa in maniera decisamente più smaccata rispetto alle precedenti opere.
Nel Continente bianco, infatti, vediamo un personaggio di nome Andrea Tarabbia che si è trasferito a Roma e va in analisi dal dottor P., il Filippo dell’Odore del sangue. Frequentandone la casa, incontra anche la misteriosa Silvia, di cui scopre presto la liaison con un ragazzo taciturno e bellissimo, Marcello Croce, che si apposta sotto casa dell’analista e che un giorno, casualmente, gli salva la vita mentre stava attraversando la strada senza guardare. Basta uno sguardo per stabilire un contatto, un’attrazione magnetica che porta il protagonista ad avvicinarsi sempre di più a Marcello, che porta nel volto «una patina di levità», sotto la quale si agita, «un dolore forse. O una rabbia», qualcosa che sembra pronto a esplodere e che, alla fine, esploderà. Lui era il punto cieco del romanzo di Parise, l’oggetto del desiderio di Silvia e l’orizzonte di ogni incubo del narratore; e lui diventa il centro gravitazionale del Continente bianco, storia dell’approssimazione sempre più pericolosa di un uomo comune a un movimento neonazista, di cui Marcello Croce è il taciturno demiurgo.
Il personaggio Tarabbia decide infatti di avvicinarsi al Continente bianco, spinto da una curiosità che tradisce anche altro: ne conosce i membri, ne frequenta i ritrovi. Viene in qualche modo assoldato come narratore ufficiale, colui che, quando la grande azione sarà compiuta, potrà definirne il racconto ufficiale. Per fare questo deve naturalmente mimetizzarsi, far credere di essere un membro del gruppo e quindi, ad esempio, partecipare al pestaggio di un bengalese durante un’azione dimostrativa. La violenza che ha imparato a studiare negli altri per poi romanzarla diventa intollerabile quando deve essere praticata in prima persona. Comprendiamo a poco a poco che questa missione da cronista embedded all’interno di un gruppo neonazista non è altro che uno sprofondamento progressivo nel buco nero della coscienza del protagonista – e il ricorso all’autofinzione sembra avere prima di tutto una funzione esemplificativa («Mi chiamo Andrea Tarabbia, come tutti», potrebbe essere l’esergo). In questo buco nero ci sono le azioni non compiute, l’indifferenza nascosta dietro le ragioni della letteratura: s’intervallano alla narrazione principale momenti della relazione con una donna conosciuta tempo prima, picchiata dal marito e che il protagonista non aveva avuto il coraggio di “salvare”; un racconto che tradisce la volontà di attribuirsi una “malvagità” che ricorda molto la parentesi autobiografica inserita da Nicola Lagioia nella Città dei vivi. Ma nel buco nero c’è anche la segreta attrazione per il male esplicito, praticato, diretto, quello mosso dall’odio e dal disprezzo per la persona. Un disprezzo che può portare un uomo a vendere la donna che non ammette di amare a due zingari di un campo abusivo di cui intende, pochi giorni dopo, bruciare le baracche.
Come spesso nei romanzi di Andrea Tarabbia, la narrazione alterna momenti di azione a lunghe sequenze riflessive, che qui seguono due piste parallele, che simulano le “fasi” alterne della coscienza di chi narra. Da un lato gli incontri ai tavoli del Caffè Greco con il dottor P., che ha smesso ormai i panni dell’analista ma che, anche solo per conoscere la sorte della propria moglie, continua ad ascoltare i racconti delle scorribande del protagonista nel e con il Continente bianco. In queste conversazioni il testimone si mostra lucido, consapevole delle implicazioni della propria missione e anche all’erta rispetto ai rischi che comporta (e peraltro sempre impossibilitato a soddisfare le curiosità del dottore, anche perché – nel rispetto della lettera del romanzo di Parise – Andrea Tarabbia non assiste mai agli incontri tra Silvia e Marcello). Dall’altro ci sono invece i confronti con Marcello Croce, che spesso, e simbolicamente, avvengono nel seminterrato del Baby Jar, il locale che fa da base operativa dell’organizzazione. È in questi dialoghi che emerge il lato oscuro; l’avvicinamento del protagonista a Marcello e ai suoi perde le effigi della curiosità antropologica per mostrarsi nei termini di un’attrazione spontanea: «C’è qualcosa che hai fatto, o non hai fatto, e che ti ha messo in fuga. Non importa sapere che cosa sia: ciò che conta è che ti ha portato qui».
Sono dialoghi densi e spesso molto espliciti nel tradurre ciò che i passaggi “d’azione” già avevano fatto presagire. Il continente bianco è un romanzo estremamente compatto e coerente nel costruire i propri significati. E lo è anche in virtù di una fitta trama simbolica che – dai serpenti che il narratore vede guizzare ogni volta che avverte una minaccia, agli occhi dei personaggi in cui, in più occasioni, brilla una luce che anticipa le intenzioni luciferine – contribuisce a consolidare il messaggio. Perché Il continente bianco è un romanzo “a chiave”, come si sarebbe detto una volta; un romanzo che è stato scritto perché c’era qualcosa che doveva essere detto e raccontato: «questa cosa, che la letteratura possa essere un dovere, è la lezione che traggo da tutto questo, se mai è possibile ricavare una lezione e, perché no, una morale, come nelle favole». E per affermarlo Tarabbia non teme l’eccesso di didascalismo, un certo abuso di momenti epifanici e, in chiusa, uno sfondamento nel fantastico che ci riporta alle atmosfere allucinate di certi romanzi russi.
Questo, in qualche modo, è quello che Il continente bianco “ci dice”, portando all’estremo un percorso di esplorazione del male che Tarabbia aveva condotto finora ad altre latitudini, geografiche, storiche e anche psichiche. Come se la frequentazione del dolore e del male nelle vite degli altri non potesse trovare altro compimento che in un confronto diretto, a tu per tu, con il male che ognuno di noi si porta dentro e che deve cercare, quotidianamente, di silenziare.
Ma c’è anche qualcosa che Il continente bianco “fa”; qualcosa che riguarda meno il suo messaggio e più la sua struttura. Perché la mescolanza di storia, cronaca e immaginazione su cui Tarabbia aveva costruito i precedenti romanzi, trova ora un nuovo campo da gioco, quello di un io autoriale debitamente finzionalizzato. Il passaggio all’autofiction non deve quindi essere sottovalutato, perché implica, oltre che strategie narrative e retoriche completamente diverse, anche una rinuncia alla distanza che aveva in qualche modo “garantito” gli sprofondamenti messi in scena nel Demone a Beslan, nel Giardino delle mosche o in Madrigale senza suono. Che quella distanza fosse un bisogno dell’autore lo dimostra il fatto che, in realtà, anche in questo caso viene ripristinata, sebbene per via di letteratura – nella Nota dell’autore che chiude il libro veniamo a sapere che la narrazione è costellata di citazioni nascoste, come se a giustificare gli eccessi del romanzo ci fossero le ragioni della letteratura. Si tratta forse di un modo per eludere un’ultima volta un contatto che davvero avrebbe potuto essere bruciante. Un’ultima partita giocata a salve, prima di rivelare qualcosa di nero che nel Continente bianco risulta ancora eccessivamente sbiadito.
[i] Queste osservazioni sono tratte da un libretto illuminante dedicato alla presenza del bianco nell’immaginario occidentale: Bianco, di Alberto Castoldi (La Nuova Italia 1998).
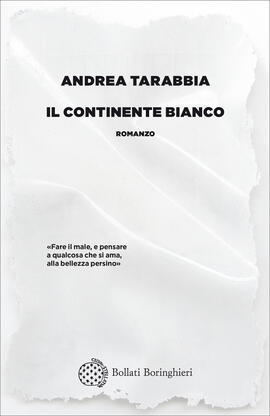
Andrea Tarabbia, Il continente bianco, Bollati Boringhieri, Torino 2022, 252 pp. 16,00€