«La mia traiettoria verso la microstoria – scrive Carlo Ginzburg nel primo dei tredici saggi raccolti nel suo ultimo libro, La lettera uccide (Adelphi) – è passata attraverso le ricerche di studiosi che affrontavano testi e immagini concentrandosi su elementi marginali, apparentemente insignificanti: Leo Spitzer, Erich Auerbach, Giovanni Morelli» (La latitudine, gli schiavi, la Bibbia).
Fin dall’ormai proverbiale Spie (1979), la pratica storiografica dell’autore de Il formaggio e i vermi (1976) e la conseguente riflessione di metodo sono infatti ancorate a quelli che un qualunque lettore di gialli riconoscerebbe facilmente come indizi, o particolari rivelatori: clic stilistici che, sotto la lente sospettosa del filologo-detective, finiscono per tradire un’incrinatura nella superficie opaca e compatta del testo; motivi-firma a prima vista “casuali”, come il mozzicone di sigaretta fortunosamente rinvenuto sulla scena del crimine, eppure decisivi nella risoluzione del caso (giusta la polisemia dell’italiano caso, al centro di un vero e proprio schizzo di «poetica della ricerca» in Conversare con Orion); il “lapsus”, ancora, che libera una perduta reminiscenza…
Il dialogo pluridecennale dell’autore con le scienze indiziarie della critica stilistica, della psicoanalisi freudiana (debitrice dell’attribuzionismo di Morelli) e dell’iconologia approda in questa raccolta a una summa piuttosto emblematica del “saggio breve” ginzburghiano, in cui – nel solco di Occhiacci di legno (1998) e Il filo e le tracce (2006) – le considerazioni metodologiche incorniciano sempre uno specifico case study storico: occasione per tornare su antichi temi di ricerca da angolazioni inedite e non di rado provocatorie, a problematizzare gerarchie e questioni reçues (si vedano, per limitarsi a un esempio, le insistenze sul rapporto ambivalente tra cristianesimo e giudaismo, fin dal titolo sibillino).
Le indagini raccolte ne La lettera uccide, in massima parte scritte e pubblicate negli ultimi dieci anni, riflettono (come da titolo, appunto) un interesse per la dimensione letterale dei testi; “letteralità” che Ginzburg puntualmente declina in vari modi, sempre attento però a illuminare la latente complessità dell’oggetto di studio: una “ermeneutica tra le righe” o lettura a contropelo, insomma, per la quale il saggio Rivelazioni involontarie, tra l’Apologia della storia di Bloch e le Tesi di filosofia della storia di Benjamin, si legge come una sorta di manifesto di metodo, dalle eloquenti implicazioni politiche.
“Implicazione” è del resto un termine ricorrente (di grana continiana) nel vocabolario di Ginzburg, maestro nel ricostruire percorsi genealogici sprofondati nella storia delle idee; nel rintracciare divergenze e convergenze, “arie di famiglia”, diramazioni impreviste di certe traiettorie culturali imboccate con spirito rabdomantico e chiaro gusto per la suspense erudita (come nel saggio di storia dell’esegesi biblica che dà il titolo al libro, e che vertiginosamente inanella nell’arco di poche pagine Agostino e Valla, Spitzer e Kafka).
Una costellazione di libri, nomi, «esperimenti mentali» che solcano in lungo e in largo la storia d’Occidente (dalla religione alla colonizzazione, fino alle ossessioni apocalittiche della postmodernità), sottoponendone alcune figure e momenti portanti a un’analisi “microscopica” tramite l’isolamento di un dettaglio anomalo – e nondimeno passibile di una generalizzazione in chiave metodologica: ciò che è, in breve, la microstoria à la Ginzburg.
L’imprinting stilistico degli esercizi di lettura ginzburghiani si rivela anche negli immancabili affondi dedicati a una semplice parola (o a un paragone: Plasmare il popolo), alla stratificazione di significati, citazioni e allusioni che, di norma, sfugge a una lettura frettolosa: a maggior ragione se al centro dell’indagine vi è un testo tradotto.
Emerge di continuo, in questa sorta di omaggio a puntate alla disciplina della filologia (o «lettura lenta», con Nietzsche), la predilezione tutta ginzburghiana e a prima vista sorprendente per il tema della distanza e le sue (di nuovo) implicazioni cognitive: laddove «ogni vera storia – sentenzia correggendo Croce con Bloch – è storia comparata» (Microstoria e storia del mondo), intesa a sottolineare le differenze, più che le analogie superficiali, tra le categorie dell’osservatore-storico e quelle degli attori; tra le domande del primo e le risposte dei secondi (Le nostre parole, e le loro). Ginzburg ci ricorda così che il passato, anche quello apparentemente più prossimo e “vivo”, è sempre una terra straniera, un altrove in cui si parla una lingua diversa dalla nostra: ignorare i filtri (culturali, linguistici, antropologici) che ci separano da esso significa inciampare nelle trappole dell’anacronismo grossolano, o – ancora peggio – nel mito contemporaneo della sedicente “empatia”.
Il microscopio per isolare frammenti di passato, il cannocchiale (rovesciato: emblema pirandelliano ricorrente nelle più recenti conversazioni) per mettere storicamente a fuoco il presente: prossimità analitica e distanza indotta, i due poli del dispositivo di straniamento che orienta la filologia indiziaria di Carlo Ginzburg.
A orientare chi legge in questi tredici studi, nutriti di un’erudizione spesso disorientante – come disorientanti possono essere alcune digressioni/deviazioni dal tracciato principale –, è come sempre la forte presenza della voce dell’autore: un elemento caratteristico, appunto, della storiografia ginzburghiana e della sua spiccata qualità narrativa (niente a che vedere, ovviamente, con forme di saggismo ibrido o con il narcisismo del “Sé” che in questi anni ha contagiato anche la produzione romanzesca). Raccontare le circostanze da cui una ricerca ha preso le mosse, le domande “centripete” e le fatalità “centrifughe” che l’hanno orientata; aprire scorci inquietanti sui fantasmi biografici che guidano certe imprese intellettuali (Verso La fine del mondo, saggio dedicato a Ernesto De Martino) significa in fondo rimarcare il carattere sempre artificioso e parziale dell’esperimento, e la presenza inevitabilmente perturbante dell’osservatore nella conduzione dello stesso.
Significa suggerire, anche, che la cosiddetta ricerca storica, con le sue ipotesi e i suoi continui disorientamenti, non è che la sezione di una assai più vasta e incerta esplorazione; la ricerca della traccia imperscrutabile del proprio destino come terreno aumentato della ricerca.
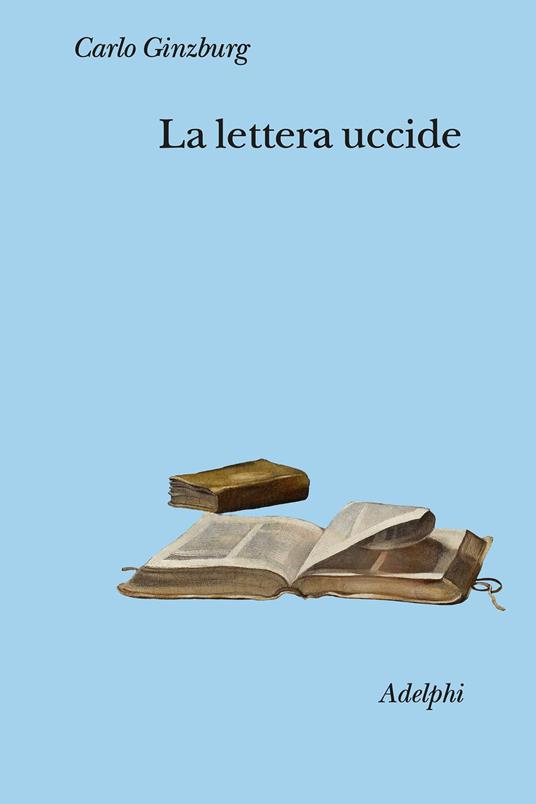
Carlo Ginzburg, La lettera uccide, Adelphi, Milano 2021.