Come sempre, con il passaggio a un anno nuovo, si stila una lista dei buoni propositi, auspici spesso destinati a rimanere irrealizzati, ma utili per capire cosa si vorrebbe fare, chi si vorrebbe essere. La lucida autocoscienza redazionale ci impone di non fare piani troppo audaci e impraticabili – visti i tempi che corrono – e ci suggerisce di metterci al servizio dei nostri lettori e delle loro buone intenzioni per il 2021 incipiente: ecco allora un elenco di romanzi italiani del Novecento che spesso mancano dalle librerie (e dai cataloghi editoriali), ma che meriterebbero di starci. Dieci libri che se non hanno ancora ottenuto il titolo di “classici”, senz’altro vi potrebbero ambire; dieci titoli da citare a sproposito nelle conversazioni mondane, per suscitare curiosità e ammirazione negli interlocutori sprovveduti. Dieci romanzi, in poche parole, da leggere nell’anno nuovo per rinforzare la conoscenza del secolo che fu, attraverso un punto di vista un po’ meno stereotipato.
Guido Piovene, Lettere di una novizia (1941) [Davide Valtolina]
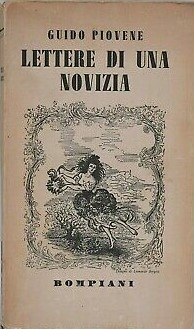
Un libro in cui la verità evapora nella foschia che avvolge, nei mesi freddi, il paesaggio veneto, sfondo della tormentata vicenda di Rita, costretta dalla madre a chiudersi in convento per compensare una tragedia avvenuta durante l’adolescenza. Lettere di una novizia è un romanzo epistolare in cui i meccanismi della coscienza sono esposti con un’eccezionale – e morbosa – capacità di penetrazione, rivelando l’influenza di una certa letteratura moralistica. Confessioni appassionate, colpevoli reticenze e fughe che si inceppano si inseriscono in questo quadro torbido e sporco, giustificato dalla premessa dell’autore che esplicita la divergenza tra la condizione dei moderni, «costretti all’acume», e la «diplomazia» che regola l’anima. Un libro che in qualche modo rappresenta l’erosione della coscienza.
Anna Banti, Artemisia (1947) [Giacomo Raccis]
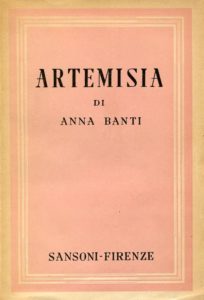
A voler puntare sull’attualità più a buon mercato, si potrebbe dire “la metaletteratura prima del postmoderno” oppure “l’autofiction prima dell’autofiction”. In realtà si tratta semplicemente di uno degli esperimenti narrativi più audaci del Novecento italiano. La leggenda vuole che Anna Banti avesse scritto un romanzo biografico sulla pittrice caravaggesca Artemisia Gentileschi nei primi anni Quaranta: il testo era concluso quando i bombardamenti alleati del 1944 su Firenze – dove abitava insieme al marito Roberto Longhi – colpirono anche la sua casa, facendo sparire il manoscritto insieme a tutti gli altri beni. Da qui un bivio: riprovare a scrivere parola per parola il romanzo perduto oppure scegliere un’altra strada, che sulle macerie di quel testo – e della città bombardata – conducesse a un’opera nuova?
Nasce così Artemisia, una finzione biografica (molti dettagli della vita della pittrice sono omessi, alcuni contraffatti) che è anche un gioco di specchi in cui il personaggio storico dialoga con quello nato dall’immaginazione stravolta dell’autrice, la quale, a sua volta, cerca nella pittrice il riflesso delle proprie inquietudini: un’ambizione artistica nata sotto l’egida di un grande maestro (il padre Orazio Gentileschi e il marito Roberto Longhi) che finisce tuttavia per condizionarne la libertà espressiva e, in definitiva, l’emancipazione in quanto artista. Attraverso una scrittura sinuosa, che scala i livelli narrativi in un flusso magmatico ma sempre puntuale, Anna Banti racconta la vita della pittrice più famosa del Seicento, capace di imporsi sui pregiudizi e sulle violenze dell’epoca (a 18 anni venne violentata dal maestro di bottega Agostino Tassi e poi costretta a un’umiliante testimonianza pubblica di fronte al giudice), senza che questo però trasformi la sua vicenda in una parabola esemplare di emancipazione. Un romanzo che rielabora con spregiudicatezza la lezione del modernismo europeo (su tutti la Woolf di Orlando) per dare forma a una storia che non ha bisogno né della verità né dell’integralità per far riverberare il suo significato fino ai giorni nostri.
Carla Vasio, L’orizzonte (1966) [Marcello Sessa]

Carla Vasio è una scrittrice che affronta la sua lunga esistenza (è nata a Venezia nel 1932 e da più di mezzo secolo vive a Roma) come un continuo corpo a corpo con l’avanguardia e le sue istanze; le naviga come se fossero un mare: riaffiorando sempre e senza mai esserne travolta.
L’orizzonte (1966) è uno dei primi e dei più felici esiti di questo confronto, che si svolge sul piano eminentemente testuale; è tra ciò che di più prezioso rimane oggi della scrittura sperimentale in prosa della neoavanguardia italiana nella sua fase massima: il decennio 1960-1970.
Seppure informato dagli scheletri di trama e struttura, è naturalmente inutile rinchiuderlo nelle griglie del romanzo; si tratta piuttosto di una “scrittura esatta”, come amava dire l’autrice. Ovvero di un’esperienza del testo e del linguaggio che è la stessa che vive la protagonista del libro: invitata a una festa, immediatamente percorre altri piani di conoscenza («Io mi metto bene seduta in mezzo al mio cerchio») innescati dall’elementare atto di nominazione delle cose, che addirittura investe il sé («Mi sarei potuta soltanto nominare»). Di qui l’esigenza di scrivere: in ragione dell’infinita dicibilità del dato percettivo.
Sulla scia di grandi indagatrici della percezione attraverso la parola come Virginia Woolf (i poemi spaziotemporali in To the Lighthouse e in The Waves) e Nathalie Sarraute (i “tropismi” come forme in cui annotare le diverse voci che agiscono in ciascuno), e proprio come loro, Vasio coi suoi libri la percezione contribuisce ad ampliarla. Scrivere un romanzo vuol dire guardare sempre l’orizzonte, con un gesto che non è più romantico o postromantico: semmai fenomenologico.
Lino Aldani, Quando le radici (1977) [Marco Malvestio]
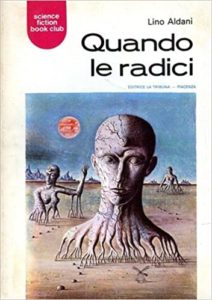
Il nome di Lino Aldani potrà non dire molto ai più, ma è un nome familiare a chi ha dimestichezza con la fantascienza italiana, di cui è stato uno degli esponenti più letti, tradotti, e soprattutto di maggiore talento e ispirazione. Quando le radici è un romanzo distopico e utopico insieme: la distopia è quella urbana e tecnocratica in cui è piombata l’Italia del prossimo futuro, i cui abitanti vivono ammassati in gigantesche metropoli, lavorano per un insondabile apparato burocratico, e si nutrono di prodotti industriali; l’utopia è quella a cui ritorna il protagonista, Arno, che fugge da questa realtà in un piccolo paesino rurale della pianura padana, abitato solo da qualche vecchio irriducibile. Siamo nel 1977: il periodo in cui inizia la piena maturità della fantascienza italiana dopo un quindicennio di gavetta e imitazioni, ma anche quello in cui appare evidente lo sconquasso ambientale e culturale prodotto dal boom economico dei decenni precedenti – urbanizzazione selvaggia, crescita del terziario, meccanizzazione dell’agricoltura. È certo sintomatico del nostro Paese e della sua irriducibile anti-modernità che uno dei più bei libri di fantascienza italiana sia questa, in fondo, fiaba allegorica e a tratti ingenua; ma pochi libri, di genere e non, ne condividono la precisione delle previsioni e la sincerità di intenti.
Fruttero & Lucentini, A che punto è la notte (1979) [Giacomo Micheletti]
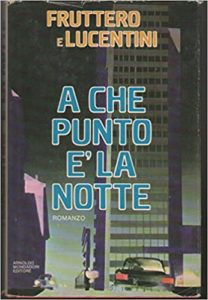
Dopo il miracolo in punta di penna della Donna della domenica (1972), che aveva trasformato i salotti di una Torino vecchiotta e parecchio snob nel set di un cinguettante romanzo giallo, la ditta F. & L. (al secolo Carlo Fruttero e Franco Lucentini) torna al poliziesco con quella che resta una delle imprese più ambiziose della sua prolifica attività: A che punto è la notte (1979).
La seconda (e ultima) indagine del commissario Santamaria si snoda tra gli oscuri dedali del Quadrilatero sabaudo e i terrains vagues della periferia, negli anfratti di una metropoli rischiarata da candele e insegne al neon, dove l’alba di un mattino d’inverno è annunciata dallo sferragliare livido di un tram in una via del centro ancora addormentato.
Un puzzle di 600 pagine che finirà per “incastrare” le più alte sfere cittadine, dall’editoria alla Curia, dall’industria alla criminalità organizzata, in un montaggio di descrizioni memorabili e dialoghi oscillanti tra suspense e comicità pura; una selva di personaggi degna di una smaliziatissima Comédie humaine da basso impero; atmosfere suburbane di un lirismo scabro e desolato; una robusta componente di esoterismo che non si fa mai ammicco per il lettore “erudito” (Il nome della rosa, con il quale F. & L. condividono non pochi modelli, uscirà meno di un anno dopo), ma diventa ingrediente principale dell’indagine poliziesca, come tale calato nell’intreccio e offerto gradualmente al lettore “detective”.
Una proposta di alto intrattenimento letterario che raccoglierà, al pari del romanzo d’esordio e di quelli successivi, magre attenzioni da parte del milieu critico-accademico. Al tempo stesso, un best seller amato da migliaia di lettori e dai colleghi più sensibili (da Calvino a Primo Levi), intriso di un’inquietudine crepuscolare così tipica di quell’ultimo scorcio di modernità in cui ancora, tra incubi escatologici e complottismi, continuiamo a brancolare: Custos, quid de nocte?
Milo De Angelis, La corsa dei mantelli (1979) [Giulia Sarli]
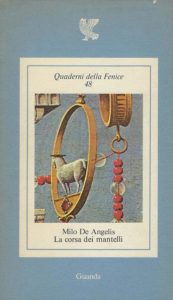
Unica prova narrativa di Milo de Angelis, edita da Guanda nel 1979 e ripubblicata da Marcos y Marcos nel 2011, La corsa dei mantelli è una fiaba fantastica composta di frammenti in cui trama, geografia e sviluppo dei personaggi non seguono una costruzione lineare: poche scene si ripetono in modo ossessivo, a imitazione dei cerchi che si formano nell’acqua quando un oggetto pesante viene gettato in un lago.
Milo de Angelis fa proprio l’insegnamento di Nietszche espresso nella parte quarta di Così parlò Zarathustra, Dell’uomo superiore: «Questa corona di colui che ride, questa corona intrecciata di rose: a voi, fratelli, getto questa corona! Io ho santificato il riso; uomini superiori, imparatemi – a ridere». Il riso è l’accettazione della vita e del dolore, passaggio obbligato per avere un ruolo nella formazione del proprio destino. I personaggi di La corsa dei mantelli incarnano questo principio e costituiscono il pozzo di archetipi dell’opera poetica successiva di Milo de Angelis: una banda di ragazzi vive la propria adolescenza tra sfide feroci e mortali, senza lasciare mai spazio al pianto e alla paura, nella certezza che ogni gesto incarna la tragedia di cui l’uomo è per natura portatore.
Opera giovanile, caotica e affamata, La corsa dei mantelli dà vita a una delle più belle rappresentazioni del femminile che conosca il secondo Novecento italiano e che trova eco in poesie successive come Donatella e Ti benderai?: il personaggio di Daina. Daina è una figlia di Artemide con le scarpe da ginnastica, bella, selvaggia. Ha un’identità mutevole perché vive di apparizioni, non resta mai prigioniera dell’immanenza. Eppure può ferire e anche uccidere. Frequenta le palestre, le bande dei ragazzi, vive per la lotta. Pretende una fede assoluta, perché è questo che le grida dentro l’adolescenza.
Testo fondamentale per comprendere l’opera di De Angelis, La corsa dei mantelli ribolle di tutta la potenza della letteratura e della gioia feroce con cui dobbiamo sempre, ciecamente, sfidarla.
Lalla Romano, Una giovinezza inventata (1979) [Marzia Beltrami]

A vent’anni esatti dalla morte di Lalla Romano, il suo romanzo più conosciuto è probabilmente Le parole tra noi leggere – vuoi per il titolo montaliano, vuoi, più cinicamente, perché incentrandosi sul rapporto tra madre e figlio è stato inconsciamente giudicato il più adatto a rappresentare l’opera di una scrittrice donna. Senza nulla togliere alla rara commistione di stile duro e profonda intelligenza umana de Le parole, nell’autoritratto a distanza offerto in Una giovinezza inventata si trova invece l’artista da giovane, la cui fame di vita, i giudizi implacabili e una certa appassionata arroganza ricordano la Simone de Beauvoir di Memorie di una ragazza perbene. Il racconto della formazione intellettuale, artistica e sentimentale di Romano si snoda nella Torino dei primi anni Venti, tra reminiscenze di Belle Époque, l’imporsi del regime fascista («il fascismo era un adolescente dalle mani fredde») e la ricerca turbata della propria necessità. Ma a differenza delle Memorie dell’autrice francese, la rappresentazione di Romano si dice apertamente inventata, nel senso che se da una parte riproduce il filtro squisitamente egocentrico della prospettiva giovanile, dall’altra a modellarla è, a posteriori, lo stile maturo della scrittrice, da lei stessa definito «concreto per le sensazioni, reticente sui fatti, segreto ma non ipocrita nei sentimenti».
Alice Ceresa, Bambine (1990) [Michele Farina]

«Occorre disegnare, per incominciare, una piccola città»: questo l’incipit dell’ultimo libro della scrittrice svizzera Alice Ceresa. Voltata la faccia del foglio, Ceresa dà inizio con piglio analitico a un’operazione di smembramento della famiglia patriarcale condotta dal punto di vista di due sorelle, accompagnate dalla voce narrante dalla culla fin sulle soglie dell’adolescenza. La prosa di questo libro riesce nell’ardua impresa di fornire un’immagine schematica della famiglia tradizionale, immortalata in pagine solcate da una rara incisività grafica, nelle quali si incontrano efficacia rappresentativa e sintesi saggistica. In questo senso sono un piccolo miracolo di condensazione drammatica le descrizioni che Ceresa fa dei disegni che le due bambine dedicano ai genitori, a indicare quali grovigli possano annidarsi in un’innocua superficie lavorata dai pastelli. Bambine è il testamento di un’artista e di una donna poco incline ai compromessi, di una femminista che, se interrogata sul suo modello letterario decisivo, rispondeva, dopo molti pensamenti: Paul Klee.
Nanni Balestrini, I furiosi (1994) [Massimiliano Cappello]

Milano, 1993. Alla Libreria Calusca di Primo Moroni, Nanni Balestrini incontra e intervista alcune delle presenze ultras milaniste che popolano il Centro Sociale Occupato e Autogestito Cox 18. L’anno seguente, esce per Bompiani l’esito di quelle sessioni. I furiosi è la riprova della maestria al magnetofono di Balestrini, già ampiamente dimostrata anni addietro in romanzi come Gli invisibili, dedicato alle vicende dei prigionieri politici del ’77. Novissimo nel 1961, membro del Gruppo 63, militante di Potere operaio prima e di Autonomia Operaia poi, esule in Francia nel ’79 sotto i colpi del Processo 7 aprile: anche per Nanni Balestrini parrebbe ripetersi quell’identità tendenziale, originaria o doverosa, di arte e vita che fu tra i miti fondanti del Surrealismo. Non fosse proprio l’esperienza della militanza politica a mutare radicalmente di segno una ricerca letteraria che fino al ’66 – tra Tape Mark I e Tristano – aveva abbracciato in versi e in prosa la mimesi del caos, sotto l’egida di una prassi combinatoria tanto ludica quanto rigida. Dal romanzo come «entità linguistica che non ha che occasionali e casuali rapporti con il linguaggio parlato», a partire da Vogliamo tutto Balestrini comincia invece a far parlare un pezzo di mondo piuttosto che rappresentarlo. La sua ricerca di una voce sempre più orale e corale – come testimonia l’assenza di punteggiatura e l’oltraggio compiuto su grammatica e sintassi – sarà influente sulla lingua della narrativa italiana più di quanto non si dica. Così, anche nei Furiosi la sua voce monodica in prosa si espande alla polifonia: questo grande racconto orale collettivo, degno di un poema epico, viene in effetti montato in canti composti di paragrafi-lasse, macro-ottave contemporanee dal sapore ariostesco. Perché lì, tra le Brigate Rossonere, c’è la vita: nelle trasferte e negli scontri, nelle molotov e nei lacrimogeni, nell’emarginazione e nei legami. «Nella gioia e nella rabbia», diceva una canzone.
Gesualdo Bufalino, Tommaso e il fotografo cieco (1996) [Ambrogio Arienti]

Stando alla bandella editoriale redatta dall’autore stesso, Tommaso e il fotografo cieco è «un non-romanzo travestito da iper romanzo» scritto «fra un’anestesia e l’altra, fra un by-pass e l’altro, per allegria». Racconta le vicende di Tommaso, giornalista che vive recluso in un seminterrato, chiamato a farsi detective e risolvere il mistero dell’omicidio dell’amico Bartolomeo, di professione fotografo cieco. Qui più che in altre opere Bufalino, «maestro di vischi e di paretai», vanifica e quasi prende in giro la linea narrativa “principale” moltiplicando e falsificando le storie, facendo esplodere la trama in uno studiatissimo e scompigliato patatràc finale. Tra le vertiginose svolte di un mediato, parodiato impianto postmoderno brilla la posa di uno scrittore che sognava di «esordire da postumo» ma si è trovato a farlo in età di pensione quasi per caso, per onorare una scommessa, sempre sospesa tra il massimo impegno e una sciancata ricerca del divertimento, perché no del gioco fine a se stesso – d’altronde il protagonista del romanzo, dietro cui si cela il sorriso divertito del suo burattinaio, vicino all’ultima pagina si lascia sfuggire: «il mio scopo, scrivendo, era un altro: vincere l’angoscia con le euforie dello stile. […] Peggio per gli altri, i grandi scrittori. Loro scrivendo s’ammalano».