A partire dall’uscita di Gomorra nel 2007, la narrazione su Napoli ha intrapreso una nuova fase che oggi appare ben consolidata nel mainstream di prodotti culturali. La tendenza ad assimilare i gangster della camorra a idoli in bilico tra gloria e dannazione ha portato spesso a focalizzare molti di questi racconti sulla gioventù napoletana, ragazzi di vita in odor pasoliniano, puri esempi di vitalismo la cui mancanza di controllo però li conduce a barattare la propria innocenza con l’adesione ai tentacoli della mafia, onnipresenti – celati che siano o meno. La strada di giovani generazioni irrimediabilmente perdute in un ciclo perenne di errori e scelte sbagliate ha fatto gola (curiosamente parafrasando in altra chiave la “generazione perduta” della Stein) a scrittori e sceneggiatori, a partire dallo stesso Saviano per arrivare, tra i tanti, al recensissimo film Ultras di Francesco Lettieri.
Questo processo finisce però col riprodurre un pattern quasi identico che impoverisce le narrazioni: ragazzini che crescono in strada con sogni di gloria ammirando i boss; alle spalle famiglie disastrate e incapaci di crescerli o proteggerli; l’inevitabile sete di potere, ricchezza/riscatto e autonomia che li seduce traghettandoli nel regno della malavita.
A tentare di smorzare questa spettacolarizzazione e di variare tale immaginario che rischia un pericoloso appiattimento, interviene però Alessio Forgione, napoletano trapiantato a Londra ma devoto alla sua città, al secondo libro, Giovanissimi (NN, 2020) in dozzina allo Strega. Il breve romanzo infatti, se da un lato gioca con la composizione di repertorio ormai canonizzata di cui abbiamo fatto menzione, dall’altro se ne separa profondamente.
Giovanissimi racconta in prima persona la vicenda del quattordicenne Marco Pane, alias Marocco, calciatore fuoriclasse, cresciuto nella periferia di Soccavo durante gli anni ’90. Come da copione, alle spalle di Marocco c’è un abbandono da parte della madre, allontanatasi durante la sua infanzia, e un padre proletario spesso assente per lavoro che, nonostante la sua scarsa capacità di empatizzare col figlio, cerca più o meno goffamente di essere comprensivo e di impartirgli un’etica improntata all’onestà e alla coerenza; c’è poi il calcio come unica salvezza e obiettivo; la scuola come istituzione inutile e incapace trattenere i ragazzi; Lunno, l’amico più grande che proporrà a Marocco di iniziare a spacciare il fumo per riuscire a comprarsi in due un motorino – negatogli dal padre – e c’è Napoli con le sue tragedie da strada.
Eppure a partire dalla strutturazione – il libro è diviso in cinque sezioni una per ogni fase del lutto – appare chiaro che Forgione voglia discutere un’altra tematica rispetto alla “gioventù vitalista e dannata”. Al centro della narrazione infatti si staglia in tutta la sua complessità l’animo di Marocco, alle prese con il passaggio da un’età ancora legata a una sensibilità puerile, all’adolescenza e alle sue contraddizioni. L’elaborazione del lutto come impalcatura del testo altro non è infatti che l’accettazione della perdita irreversibile della madre. Lungo tutta la storia Marocco è ossessionato da visioni invasive e allucinate, incubi dolorosi su di lei che rispecchiano il trauma dell’abbandono, ma anche la devozione frustrata nei suoi confronti, caratteristicamente infantile («I miei piedi erano neri e il sole, in cielo, era una palla rossa e avrei voluto chiederle se mi amava, perché mi sentii certo dei miei sentimenti e che mai avrei amato nessuno più di lei, ma non lo feci»).
Il romanzo segue dunque l’educazione sentimentale di Marocco diviso tra la sua selvatichezza bellicosa e ribelle, e una sensibilità genuina e curiosa, configurandosi come un vero e proprio romanzo di formazione. Forgione dunque mette tutto sullo stesso piano, mescolando gli aspetti del repertorio “napoletano” ad altri più classici. Così, ad esempio, lo spaccio scolastico diventa un’attività come tante che non conduce ad alcuno scivolamento nella malavita e la questione del potere e dei soldi si trova rimisurata all’interno di un perimetro personale e inoffensivo:
«Io non avevo problemi. Mi sentivo normale: i soldi li mettevo tutti nel cassetto della scrivania e i miei stavano in una scatola delle scarpe e non erano pochi e stavano sempre lì, perché non sapevo come spenderli. Soprattutto, perché non potevo spenderli davvero. Avrei voluto un motorino, ma non erano abbastanza. […] I soldi non erano il vero problema. Il problema era mio padre. Per questa ragione, le uniche cose per cui potevo spenderli erano fumetti e riviste e li compravo e, per quanto pagassi, comunque i soldi continuavano a stare nel cassetto.»
Tutte le attività o gli accadimenti vengono sempre assorbiti e stemperati all’interno della storia, ricondotti all’interno del perimetro dell’Io che li osserva e valuta in maniera completamente orizzontale. Così, lo spaccio diventa un meccanismo scontato, come perfetta normalità è trovare ogni tanto un morto dietro l’angolo mentre si va ad un appuntamento con una ragazza o che una partita di pallone si trasformi in una rissa dove volano coltellate.
Ecco dunque la normalizzazione apportata da Forgione nel testo. Da un lato gli elementi tipici dell’immaginario non mancano, ma fanno da sponda per insinuarsi nella complessità psicologica ed emotiva di un adolescente, senza mai essere sensazionalizzati, affiancandosi all’ansia del fallimento tipicamente adolescenziale, alle dinamiche da branco in conflitto con singolarità e intimità, ai primi pruriti della sessualità.
Sarà l’incontro con Serena infatti che catalizzerà in positivo le energie di Marocco, aprendogli la strada alla percezione della complessità sentimento e del reale. È in questa chiave che l’idea di trauma radicata nelle pagine assume una nuova veste: la crescita è infatti un percorso costruito proprio attorno all’idea di abbandono di sé e della propria condizione esistenziale, affiancato da una rinnovata percezione della realtà che vede i fenomeni non più come univocamente dati, ma ne inizia a cogliere la natura contraddittoria come elemento fondante. Bene e male, felicità e dolore sono i lati di una stessa medaglia e conoscere il mondo significa fare esperienza di entrambi.
A quest’ambiguità corrisponde il frangente del desiderio che inizia a sviluppare esigenze e bisogni contrastanti, premendo contro divieti e autorità per potersi realizzare. Così progressivamente, la scuola, il padre e le regole iniziano a fare spazio ad una dimensione alternativa (in cui rientra minimamente anche l’illecito) divisa tra lo stupore stordito per il tripudio del mondo e la necessità di assumere un’identità definita in conformità col proprio sentire:
«Lunno, mio amico e anche la persona a cui avevo scelto di non assomigliare. Partivamo e avremmo litigato? E se non avessimo più voluto saperne l’uno dell’altro, una volta tornati? Sì, mi dissi, che c’andavo per Serena, però mi dispiaceva che lui non riuscisse mai a godersi nulla e che rovinasse sempre, almeno un po’, l’umore degli altri. Pensai fosse un peccato, essere così, e i palazzi diventarono un po’ più alti, bianchi, pieni di tende, e provai pena per Lunno. Perché mi sembrò che passasse il tempo sforzandosi d’apparire sempre forte e duro. Non mi piaceva questa cosa ed io non volevo essere così. C’avevo provato e avevo capito che non ero così e che invece volevo solo amare ed essere felice e volevo che tutti se ne accorgessero. Volevo fare del mio sorriso un simbolo, uno sfregio permanente che mi rovinava la faccia»
A tale percezione rinnovata si affianca però anche una nuova consapevolezza inquieta, una sorta di predestinazione alla disgrazia che fin dall’inizio scorre accanto ad ogni pretesa di felicità; un miasma generato da Napoli stessa che non cessa di disperdere i propri figli. Assieme alla conoscenza del mondo, subentra per Marocco anche la cognizione del contesto, un sentore di pericolo e minaccia che prende una forma sempre maggiore («Uno non ci pensa mai al fatto che le cose stanno per accadere, fino a che non le intravede. Non ci si pensa mai che esiste anche quello ch’è invisibile agli occhi, fermo da qualche parte, in attesa proprio di te»). Così, se il protagonista non si smarrisce su sentieri rovinosi, lo stesso non accadrà per molti dei suoi coetanei. La squadra di calcio dei Giovanissimi (da cui il titolo) andrà disgregandosi e Marocco stesso dovrà imparare che crescere significa anche fare i conti con l’oscurità imprevedibile della vita, che miete le vittime più inaspettate.
Attraverso una scrittura che raramente scade nel sentimentalismo, costruita su una secchezza ruvida della frase calcata sull’irrequietezza scattante del pensiero di Marocco e uno stile asciutto ed essenziale che si gonfia dove necessario a sottolineare le burrasche sentimentali del protagonista («Era così viva, così incontrollabile, piena d’energia, così mi appariva. Una bomba riempita di chiodi e pezzi di vetro che scoppia e chissà dove arriva tutto quello che c’è all’interno»), Giovanissimi racconta l’adolescenza a Napoli da una prospettiva inedita, che affonda nell’humus fecondissimo di un’emotività policroma e ben rappresentata, ricordando in maniera non scontata come i momenti che definiamo “formativi” passino tutti attraverso la decostruzione e la perdita, e che in questa incongruenza sta la fatica di vivere.
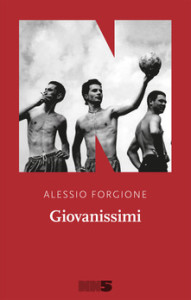 Alessio Forgione, Giovanissimi,
Alessio Forgione, Giovanissimi,
NN editore 2020,
16€, 224 pp.