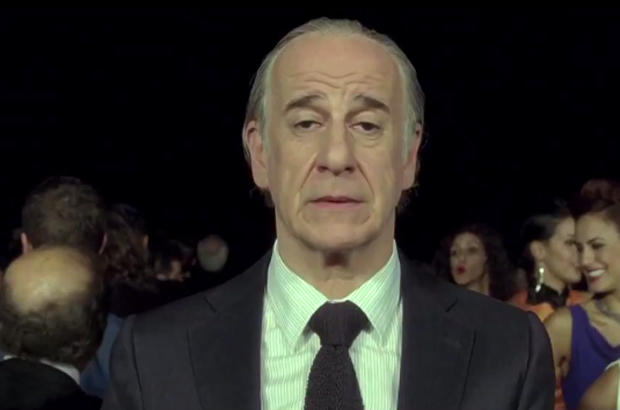di Serena De Blasio
L’alba si alza su Roma e ne svela la bellezza segreta. La luce radente illumina le statue, i giardini, le chiese, svelando una città irrealmente quieta, in cui gli spazi ripresi e il tempo della contemplazione sembrano dilatarsi nella magia del mattino. In sottofondo un canto gregoriano, prima lontano, poi sempre più presente, intonato da più voci concertate.
Cala la notte sulla capitale e l’incanto dei panorami della Città Eterna lascia spazio alle luci stroboscopiche, pulsanti al ritmo del remix dei vecchi successi di Raffaella Carrà. Il sipario si apre sugli sfavillanti party notturni capitolini, appuntamento “must” per la Roma bene, che conta uomini facoltosi, ex showgirl in declino, aspiranti starlet, artisti radical-chic ed esponenti di spicco dell’intellighenzia romana.
Si apre così La grande bellezza, su una delle tante feste romane a base di drink, lustrini e promiscuità. Il festeggiato, Jep Gambardella, celebra sessantacinque vissuti sulla cresta dell’onda, circondato da una folla di adulatori, ammiratrici giovani e disponibili, colleghi e amici più o meno intimi. Jep è un giornalista tuttologo, critico teatrale e opinionista di costume, ricco, anzi straricco, noto per essere “il re dei mondani” in grado di decretare il successo o il fallimento delle feste capitoline. Alla frivolezza del viveur fa da contraltare una sensibilità profonda e ingombrante, che come uno stigma condanna Jep alla malinconia del “diverso” («Quando ero giovane chiedevano a noi ragazzi quale era la cosa più bella del mondo. Tutti i miei amici dicevano “la fessa”, mentre io dicevo l’odore delle case dei vecchi») destinandolo alla professione di scrittore. La produzione letteraria di Gambardella si limita a un unico acclamato romanzo, l’opera giovanile intitolata L’apparato umano, insignito con il premio Bancarella. Dopo l’esordio letterario lo slancio creativo si è affievolito fino a spegnersi, smorzato dall’indolenza del divertissement e dalla mollezza della vita agiata. La voglia di scrivere sembra ancora crepitare tiepidamente sotto l’apparente abulia, ma Jep è troppo cinico e pigro per mettersi all’opera. O forse troppo ambizioso: l’irrealizzata e irrealizzabile opera seconda mira a sfiorare, anzi ad essere, Grande Bellezza, perfetta e definitiva come il Niente flaubertiano. Ma l’abisso che si apre tra la grandiosità dell’idea e la modestia (per non dire miseria) intellettuale e umana del piccolo mondo alto-borghese romano rende impossibile perfino iniziare l’opera.
Da un attico affacciato sul Colosseo Jep osserva Roma e la sua bellezza eterna. Ma quando volge lo sguardo all’interno, alla sontuosa terrazza fiorita arredata come il più elegante dei salotti, scorge il vacuo agitarsi dei suoi titolatissimi e disperatissimi ospiti occasionali. La solenne magnificenza della capitale mostra il proprio rovescio sudicio e cafone, abitato da alti prelati, nobili decaduti, arrampicatori sociali, e naturalmente dagli esponenti dell’enclave culturale di cui Jep fa parte.
Su questo sfondo aureo e corrotto, immortale e amorale si intrecciano i fili narrativi che tessono l’ordito di una trama sfuggente, che sembra non riuscire a svolgersi, né tantomeno a compiersi. Il film propone un’impietosa panoramica su una schiera di soggetti eccentrici, bizzarri, infelici, che spazia dall’aspirante drammaturgo deluso alla performer autolesionista con i peli pubici tinti di rosso, dalla direttrice del giornale nana al prete mondano appassionato di cucina, dalla Santa alla spogliarellista agée colpita da un male incurabile. Ciascun personaggio narra una storia di fallimenti e delusioni personali, e allo stesso tempo compone, come la tessera di un mosaico, il quadro dal sapore amaramente familiare della nostra storia presente.
La grande bellezza, non vuole però essere l’affresco di un’umanità allo sfascio, né critica sociale, e nemmeno un omaggio esplicito al cinema di Fellini.
L’ipercitazionismo amato/odiato del registra Paolo Sorrentino punta altrove, alla ricerca di un senso del bello che vada al di là della rappresentazione cinematografica.
Il preziosismo estetico del film, che si esprime nelle inquadrature perfettamente studiate e in una fotografia ricercata e mai banale, risulta grandioso ma a tratti ridondante. Alto fino a dare le vertigini un po’ come l’idea di Grande Bellezza rincorsa da Jep.
L’esibizione della magnificenza consunta di Roma spinge a cercare il Bello da un’altra parte: non nei panorami mozzafiato della capitale, non nelle feste pacchiane dei locali alla moda, non nella luce soffusa dei tramonti, né nel lusso sfrontato delle ville dei ricchi.
Viene da chiedersi quale spazio occupi la Bellezza ne La grande bellezza.
La citazione tratta da Viaggio al termine della notte di Céline su cui si apre il film dà un’indicazione precisa e inequivocabile: prima dell’immagine giunge la parola, che esercita il suo silenzioso potere di influenzare la visione del film (salvo poi essere fagocitata dal potere di seduzione delle immagini). La carrellata di scenari mirabolanti offerta agli occhi dello spettatore colpisce i sensi, li scuote con violenza fino a spossarli sotto l’effetto estenuante dello sfolgorio delle immagini. Ma ciò che abbaglia fallisce miseramente la ricerca di un senso, e si perde nella contemplazione vacua e fine a se stessa di un Bello consunto, sterile. Sepolta sotto il barocchismo visionario della regia di Sorrentino respira timidamente la parola letteraria, unica strada possibile verso un ritorno alla Bellezza. Lo testimoniano l’abbondanza di citazioni colte, disseminate qua e là nella pellicola (Céline, Dostoevskij, Proust, e Flaubert, per ricordare alcuni degli autori menzionati), così come la scelta di fare di un intellettuale (nel senso più generale del termine) il protagonista di un film sulla bellezza che mostra incessantemente bruttezza.
Solo quando la parola si sottrae alla chiacchiera frivola che copre indistintamente il Brutto e il Bello, riesce a riappropriarsi del suo significato. Quando l’esercizio letterario si sgancia da pratiche di scrittura mercenarie ed autoreferenziali (gli articoli di Jep, o i “romanzetti pseudo-impegnati” di Stefania) ritrova una purezza che sfiora la Grande Bellezza.
Nel finale del film, Jep Gambardella sembra trovare le parole adatte per cominciare l’opera che da anni rincorre senza successo. L’ispirazione arriva dall’abbaglio di un ricordo lontano, interrotta da uno scherzo della memoria. Proprio le parole della letteratura sembrano restituire un senso a una realtà che corre imbizzarrita, divorando ogni cosa. È un senso minuto, istantaneo che abbandona la vertigine del “grande” per rifugiarsi nel bagliore dell’epifania quotidiana. Piccola, impercettibile, ma autenticamente bella.
Questa è la bellezza de La grande bellezza.