«Essenziale è comprare molti libri che non si leggono subito. Poi, a distanza di un anno, o di due anni, o di cinque, dieci, venti, trenta, quaranta, potrà venire il momento in cui si penserà di aver bisogno esattamente di quel libro – e magari lo si troverà in uno scaffale poco frequentato della propria biblioteca» (Calasso, Come ordinare una biblioteca). Trascrivendo questa citazione pensavo che una delle sensazioni di vacanza più pervasiva, coincise con i mesi in cui un’amica partita per la Patagonia mi affidò casa. Era una mansardina con un balcone, un acero, un gatto saltuario e un’intera biblioteca che non mi somigliava, che non avevo, né avrei, scelto così.
La redazione della balena vi accompagna, e vi invita, per scaffali poco frequentati. Sceglie per voi titoli che non vi assomigliano (o forse sì), da inseguire in bookcrossing defilati, librerie fidate o biblioteche più o meno in prestito.
Ana Hatherly, 77 Tisane (1994) [Serena Cacchioli]
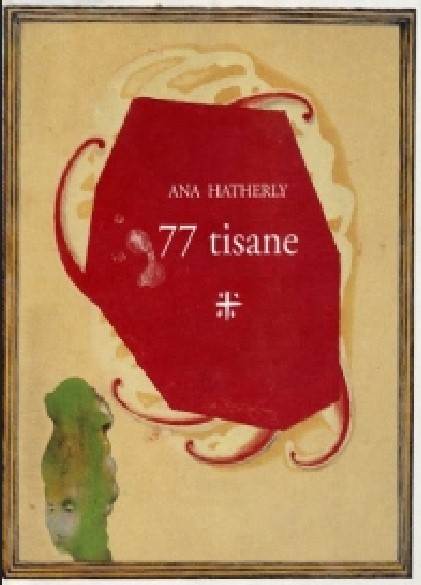
Le Tisane sono l’opera della vita di Ana Hatherly. Sono brevi frammenti in prosa scritti nel corso di più di trent’anni. In Portogallo ne sono uscite quattro edizioni, ogni volta con qualche testo in più: 39 Tisanas nel ’69, 63 Tisanas nel ’70, 351 Tisanas nel ’97 e 463 Tisanas nel 2006. In Italia è uscito soltanto, nel 1994, un volume dal titolo 77 Tisane, pubblicato da Colpo di Fulmine Edizioni, un gioiello raro curato dal genio dell’artista plastico José Barrias che ha selezionato i frammenti-tisane hatherliani riarticolandoli in una narrazione che accompagna il lettore in un percorso surreale e intrigante. Secondo le parole della stessa autrice le Tisane sono «poesia in prosa; anti-favole, narrazioni aforistiche ed epigrammatiche; creazione e ricreazione di miti; metalinguaggio e metaletteratura, trasgressione parodica, opera aperta…». La prefazione dell’edizione italiana è firmata da Giorgio Manganelli, ma su questo non sveleremo altro.
Filippo Betto, Certi giorni sono migliori di altri giorni (1996) [Giulia Sarli]

«Chi racconta tutto agli altri non ha dignità, perché non ha pudore». È una frase contenuta in Un incontro, uno dei sette racconti che compongono Certi giorni sono migliori di altri giorni (Marcos y Marcos, 1996), esordio narrativo di Filippo Betto, dal 2017 disponibile in versione digitale per la collana Collirio di Terra Ferma Edizioni. C’è un senso di vergogna e di inquietudine che si muovono convulsi in tutto il libro. O forse sarebbe meglio dire di ribrezzo. Ogni racconto ha per protagonista un personaggio solitario che entra in contatto con qualcosa che gli fa orrore perché sente che è troppo vicino a sé: che sia la malattia di aids, l’agonia di un ratto in trappola che non riesce a morire, la deformità di un bambino nascosto dalla madre nella propria camera da letto, o il proprio amore. Nella presentazione della riedizione digitale del libro ormai introvabile nella versione cartacea, Renzo di Renzo, ex direttore della rivista Colors per cui Betto lavorava, cita la canzone L’animale di Battiato, che ben descrive la continua lotta con sé stessi di questi personaggi in un gioco di specchi che contagia anche la vita dell’autore, morto a soli 43 anni. Perché allora esporsi, rinunciare alla dignità? Nel primo racconto, che dà il titolo al libro, anche se non è detto in modo esplicito si intuisce da diversi segnali che il protagonista e narratore è l’amico Pier Vittorio Tondelli nei suoi ultimi giorni di vita, a cui Betto ha effettivamente assistito. In prima persona, il malato descrive nei dettagli il dolore, le medicine, lo sfascio del corpo. Perché? «È che io sono fatto così», gli fa dire Betto, «sono un infelice, la sofferenza mi terrorizza, ma voglio fino in fondo ri-spet-to. Rispetto per questa mia dignità guasta, rispetto per la mia sorte meschina, sfortunata, rispetto per la mia solitudine e la mia infelicità infinita» (pp. 14-15). Forse a volte è necessario non avere pudore, modellare il dolore e nasconderlo in un racconto. Per dargli diritto di esistenza, concedergli rispetto. E liberarsi (liberarci) dal suo male.
Giuliano Mesa, Poesie 1973-2008 (2010) [Massimiliano Cappello]
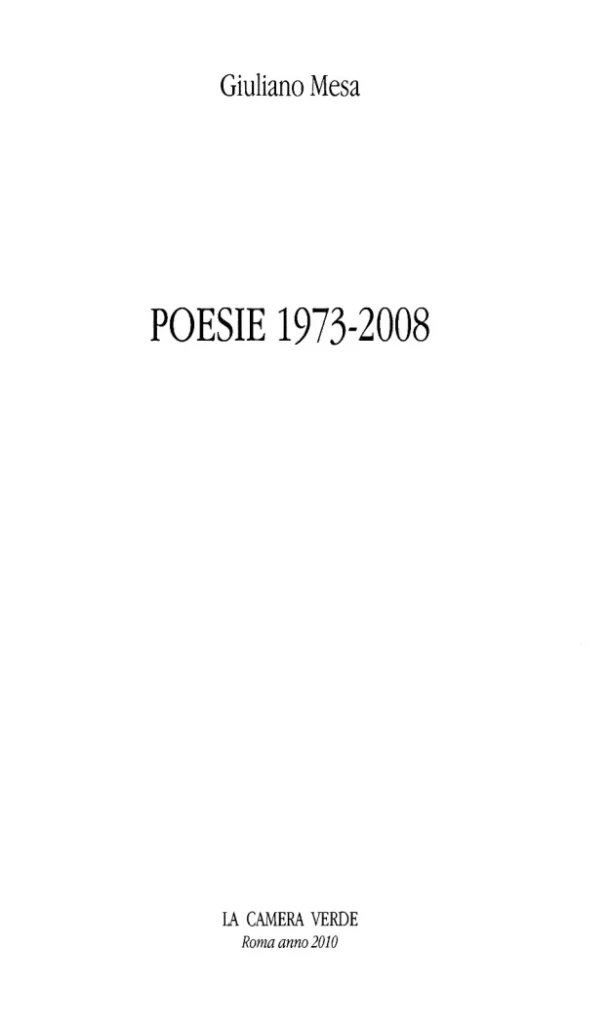
Tra le più assordanti assenze in libreria, per dirne solo dell’aspetto più mercificato e materiale, c’è Giuliano Mesa. Scrivo questa dopo aver recuperato, grazie a Marco Giovenale, il suo Poesie 1973-2008 (La Camera Verde 2010), apparso vivente l’autore, e che ad oggi rappresenta l’unico e difficilmente reperibile, ma completo accesso all’opera. Se ne può comunque leggere, grazie a Biagio Cepollaro il primo libro qui (Inventario,Geiger 1978); qualcosa si recupera spulciando altrove online, o di seconda mano. Le biblioteche aiutano. Un sito dedicato ne conserva il materiale critico e una bio-bibliografia.
I materiali prelevati, campionati, inventariati da Giuliano Mesa sono dei più vari, e fanno deflagrare modi, lessici, sintassi, sguardi in altri tempi contrapposti da una specie di cortina. Parafrasando: il «canto» di alta elegia di una supposta “tradizione” novecentesca vs il «metodo» delle avanguardie e delle ricerche. il suo «dire irriducibile» di fronte alle rovine non è un’oltranza da proseguire all’infinito, ma nemmeno una pacificazione nella forma. Perché invaghirsi del disastro è, così come negarlo, un’altra forma dello stesso falso metaforico che interdice a tutte e a tutti una presenza meno fantasmatica nella vita quotidiana.
I testi di Giuliano Mesa rendono visibile non tanto la negazione della vita o del suo senso, ma la vita e il senso che, negati, premono per riaffiorare. Quale sia il senso del linguaggio laddove il “mondo” è divenuto analizzabile, commisurabile, archiviabile, dove l’enigma naturale si è dissolto: di fronte a questa impasse, solo detriti, spesso amaramente ironici, ma intenzionati: «in bilico», cioè, «fra collasso e liberazione».
considera che questo non è più questo
che fuori non è rimasto nulla
fuori più nulla
la strada l’asfalto la polvere
dentro la culla vecchia vuota
immagina che questo non può tornare
nemmeno come un’immagine
dentro più nulla
le ciglia la palpebra l’occhio
fuori la luce calda vuota
considera che questo non è più questo
dentro più nulla
breve lunga breve, breve lunga breve
lunga breve breve, breve breve breve(3., da Improvviso e dopo, 1997)
János Pilinszky, Poesie (1983) [Noemi Nagy]
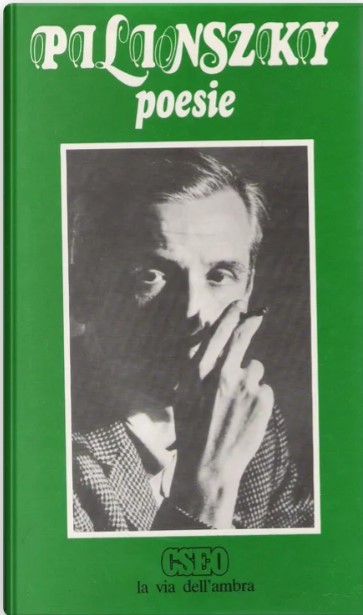
Risale al 1983 l’unica edizione italiana delle Poesie di uno dei maggiori poeti ungheresi del secondo Novecento. «Benché János Pilinszky sia in realtà poeta di chiara misura europea, la sua opera è tuttora ignota in Italia. Nel dialogo tra le culture dell’unica Europa un’assenza così clamorosa non resterebbe a lungo senza colpa e senza danno»: in apertura della nota al volume pubblicato dal Centro Studi Europa Orientale, che si estende, nella traduzione di Antonio Molteni, lungo l’intero arco della produzione dell’autore, a partire dall’esordio, con Trapezio ed asse d’equilibrio (Trapéz és korlát, 1946), fino all’ultima raccolta, Cratere (Kráter, 1975).
Una produzione relativamente esigua («non è male se qualcuno scrive molto, e neppure se qualcuno scrive poco. Il guaio è se qualcuno scrive troppo o troppo poco»), ma la cui portata si misura soprattutto nella verticalità della tensione trascendentale: la poesia di Pilinszky (1921-1981) – fortemente segnata dai terrori della guerra e dei lager, influenzata dalla mistica cattolica e dal contatto con l’opera di un’autrice come Simone Weil – accoglie nella sua tragica assurdità la condizione di solitudine e di alienazione dell’uomo moderno, rivolgendosi tuttavia sempre, in virtù di una salda fede nel potere catartico della parola, all’esperienza religiosa del ritorno a casa e della redenzione.
Külön kerül az egeké, s örökre
a világvégi esett földeké,
s megint külön a kutyaólak csöndje.
A levegőbenmenekvő madárhad.
És látni fogjuk a kelő napot,
mint tébolyult pupilla néma és
mint figyelő vadállat, oly nyugodt.(da Apokrif)
E saranno separati il silenzio dei cieli e per sempre
il silenzio delle terre alla fine del mondo,
e ancora separato il silenzio dei canili.
E ci sarà nell’aria uno stormo d’uccelli in fuga.
E si vedrà sorgere il sole,
come una pupilla pazza, così muto e
come bestia all’erta, così tranquillo.(da Apocrifo, trad. di A. Molteni)
Grazia Cherchi, Scompartimento per lettori taciturni (1997 e 2017) [Michele Farina]

Periodicamente, gli “addetti ai lavori” (addetti? lavori?!) del microcosmo letterario italiano si trovano a dover smaltire le eccedenze di autocoscienza intellettuale aggiornando il cahier de doléances sulla crisi della critica e dell’editoria. Si tratta ormai di un cospicuo faldone, direbbe Grazia Cherchi, in cui “le prime cento pagine ripetono la prima e le seconde cento la seconda”. Cherchi ci ha consegnato attraverso le sue rubriche affidate a quotidiani e riviste alcuni dei dispacci più affidabili e divertenti sul diluvio che ha investito l’industria culturale negli anni Ottanta, compilati con prosa svelta e ficcante. Dopo un anno, il 2022, che ha visto pubblicare diversi consuntivi firmati dai maggiori decani (maschi) del mondo editoriale, è un piacere tornare alle scorciatoie critiche di Cherchi, ai suoi pareri e alle sue rassegne editoriali, alla sua intelligenza curiosa e, perché no, anche alle sue misurate sprezzature. Tutti avremmo molto da imparare da Cherchi su come scrivere (e non scrivere) recensioni e stroncature. E forse, soprattutto, su come essere lettori un po’ più liberi e spregiudicati. Oltre che un libro didattico, Scompartimento per lettori taciturni è un buon esempio di polemismo culturale, che, da un lato, fa percepire quanta acqua sia passata sotto i ponti immobili del mondo letterario italiano e, dall’altro, invita a non farsi troppo ingolosire dalle tentazioni della facile deprecatio temporum, più spesso sintomo di pigrizia che di personalità.
Giulia Niccolai, Il grande angolo (1966 e 2014) [Beatrice Seligardi]

Unico romanzo nella sua produzione letteraria, Il grande angolo è forse tra le opere meno note di Giulia Niccolai: pubblicato per la prima volta nel 1966 all’interno della collana sperimentale “Le Comete”, curata da Nanni Balestrini per Feltrinelli, è stato riedito nel 2014 per i tipi di Oedipus in una versione rivista dall’autrice (e con note di lettura della stessa Niccolai e di Milli Graffi). L’eco degli anni Sessanta, e in particolar modo del nouveau roman e dell’école du regard, è palpabile, e pure si tratta di un’opera decisamente attuale, che ci accompagna lungo una riflessione sui dispositivi di visione così pervasivi nella nostra contemporaneità.
Attraverso il punto di vista di Ita, fotografa (come lo fu Niccolai) impegnata in due campagne rispettivamente in Egitto e a New York, lo sguardo sembra potersi trasformare in un obiettivo fotografico, trasparente e oggettivo nel documentare la realtà circostante. Ma ovviamente le cose non stanno così: i gesti fotografici, che occupano numerose sequenze del testo, e la voce narrante, apparentemente esterna, lasciano intravedere lacerazioni profonde, come quelle che emergono durante la permanenza della protagonista in una clinica psichiatrica. Il corpo di lei diventa allora superficie anamorfica che si rinfrange su specchi e finestre, in un gioco di sovraimpressioni con le immagini della pubblicità e dei rotocalchi – in simbiosi perfetta con la copertina della prima edizione, che recava il frammento di una tempera di Giosetta Fioroni, Doppia maschera, dipinta dall’artista nello stesso anno. E anche il “grande angolo”, il teleobiettivo che Ita e il compagno Domínguez cercano di costruire per penetrare l’impenetrabile, si arresta di fronte alla profondità e alla densità dell’aria: a rimanere impresso sulla pellicola c’è solo il ricordo di un’immagine.
Donald Spoto, Il lato oscuro del genio. La vita di Alfred Hitchcock (2006) [Elisa Teneggi]
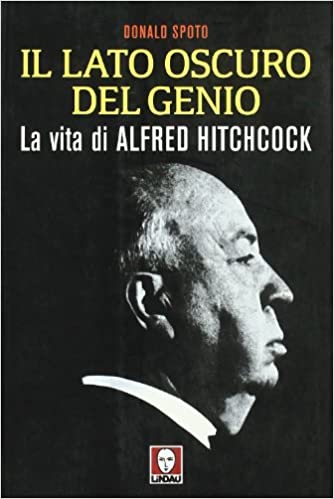
Alfred Hitchcock era un po’ un cialtrone. Famosamente incline alle boutade di pessimo gusto, come smanacciarsi il ventre per contorcerlo in forme parlanti e applicare il suo smaccato senso del (sado)masochismo a scherzi ai danni di amici e collaboratori. Sublimatore, così dicono, dei suoi impulsi sessuali segreti nella celluloide delle sue pellicole. Hitchcock, però, fu anche precursore. Girò Vertigo (1958), saldamente nella top 10 dei migliori film della storia; interpretò il gusto contemporaneo sviluppato dalle masse per narrazioni agili, tarate su attention span di dieci secondi, descrivendo il cinema come “la vita con le parti noiose tagliate”; fondò un’azienda di pubbliche relazioni per prendersi esclusivamente cura della sua immagine. Che all’esterno appariva buddheggiante, arcigna, da freak. E che mutò Alfred, il bambino timido e insicuro nato da una famiglia umile di Londra Est, in uno dei maestri assoluti della settima arte. Prevedibilmente, Hitchcock è stato raccontato da più parti, la sua opera dissezionata, i suoi reali o supposti kink sessuali, feticizzati. Rimangono leggendarie, e terrificanti, le angherie a cui sottopose la star de Gli uccelli (1963) Tippi Hedren, che si vide costretta a girare la scena dell’attacco finale in camera da letto da parte di uno stormo inferocito con volatili in becco e piume al posto dei meccanici preventivati. Una voce, però, rimane sopita: quella di Donald Spoto (scomparso lo scorso 11 febbraio), biografo di molti personaggi dello spettacolo e, tra gli altri, di Hitchcock, con un testo non autorizzato pubblicato nel 1983: The Dark Side of Genius: Life of Alfred Hitchcock (portato in Italia da Lindau nel 2006 con il titolo Il lato oscuro del genio. La vita di Alfred Hitchcock, e oggi introvabile in traduzione). Meno accomodante del Truffaut intervistatore de Il cinema secondo Hitchcock (Il Saggiatore), al limite della scorrettezza interpretativa per il procedere psicanalitico attraverso le ossessioni del regista, quello di Spoto è, tuttavia, in primis un lavoro di ricerca. Minuziosa, enciclopedica, per mappare ricordi aneddoti impressioni di chi, a fianco di Hitchcock, visse e lavorò. E, nel suo procedere metodico, cucina un ritratto appetitoso, scandalistico, forse, ma parte dell’ampio mosaico che ci conferma ossessionati dall’unificazione dei poteri tra pubblico e privato nella figura dell’artista. Perché, di questa idea di “genio”, abbiamo sempre un po’ paura. E allora che gusto, quando troviamo terreno a sostenere i nostri timori, e rassicurarci, e reinquadrarcelo nelle basse sfere dell’umano. Funge molto meglio la lettura di Spoto che gli equivoci giochetti di pancia del maestro.
Sergio Atzeni, I sogni della città bianca (2005) [Stella Poli]

Scompare in mare, vicino all’isola di San Pietro, nel 1995, Sergio Atzeni. Aveva lasciato la Sardegna, sua terra natale, nell’86, che è anche l’anno del suo primo romanzo, l’Apologo del giudice bandito. I ventisette racconti in edizione critica per i tipi del Maestrale, li aveva lasciati in una cartelletta di cartone, consegnata alla sorella. Qualcuno è il canovaccio di scritture successive, ma restano un serbatoio distante, ispirazione primigenia. La città bianca è Cagliari, bianca di soli implacabili, dove Atzeni cresce, studia Filosofia, inizia l’attività di giornalista e la militanza politica. Ci sono tre citazioni, in esergo, di Lawrence, Vittorini e Cambosu, che a Cagliari arrivano, da lontano, mentre questi brevi, difformi e visionari racconti vorrebbero fare un’operazione di segno inverso: “Devo dire la verità: raccontare Cagliari è stato uno dei motivi che mi ha spinto a cercare di scrivere racconti. Avevo notato che nei giornali, in televisione, quando si prendevano descrizioni di Cagliari […] si finiva sempre per citare autori non sardi, come se non ci fosse una descrizione di Cagliari o del Campidano nella nostra letteratura”. Riprendersi Cagliari, dunque, riraccontarla con focalizzazione interna e scorciata, con uno sguardo onirico, un po’ alla Borges un po’ alla Bulgakov, uno stile asciutto, veloce, a tratti dolcissimo (“La nudità di Santina è uno di quei sogni che mi sono portato dietro per anni, come pietra di paragone per misurare la realtà”).