I primi mesi del 2021 hanno visto l’uscita di due saggi italiani che, a diverso titolo, discutono di cambiamento climatico. Si tratta di La letteratura ci salverà dall’estinzione, di Carla Benedetti (Einaudi) e L’altro mondo. La vita in un pianeta che cambia, di Fabio Deotto (Bompiani). Interventi che si inscrivono in un dibattito sempre più fecondo e caldo, disegnandone le coordinate di riferimento e al tempo stesso vagliandone lo spettro di efficacia. Le coordinate sono quelle, assiali, di tempo e spazio. Un ponte tra passato remoto e futuro è quel che sostiene l’esposizione di Benedetti, intenta a dimostrare la validità dello strumento letterario per indicare una possibile via di uscita dalla catastrofe ambientale. La delineazione di una geografia multiforme ma attraversata da un medesimo senso di declino è invece al centro del libro di Deotto. Quanto all’efficacia, parametro intrinsecamente soggettivo, in questi due interventi paralleli del 10 e 12 novembre (che coincidono con gli ultimi giorni della COP26 di Glasgow) proverò a motivare come mai i due saggi si collocano, a mio parere, su piani ineguali.
L’altro mondo. La vita in un pianeta che cambia, Fabio Deotto
È a un cambio di direzione che si deve l’efficacia de L’altro mondo: un cambio coraggioso e, si immagina, umanamente non facile, ma di cui l’autore e i lettori possono cogliere oggi i frutti più maturi. Fabio Deotto tratteggia anche nel libro il suo passaggio da dentro a fuori l’accademia, dalla scienza alla letteratura, dalla laurea in Biotecnologie alla scrittura. Ma, ciò che più conta, delle sue diverse esperienze riesce a trattenere un denominatore comune fatto di feconda prensilità intellettuale. Tanto preciso nella ricerca dei dati quanto originale nella creazione di una narrativa intorno ad essi, Deotto dimostra col proprio stesso lavoro la necessità di trascendere ogni presunta scissione tra cultura scientifica e umanistica, di permettere a queste ultime di fertilizzarsi a vicenda e di includere, nel percorso, una necessaria dose di pensiero critico indipendente.
La copertina del libro rivela nella sua essenzialità lo stato di confusione prospettica che caratterizza il dibattito ecologico attuale, entro il quale questo saggio mantiene dritta la barra di un’esposizione chiara e convincente. Nell’immagine una donna distinta, di quella distinzione conformista in cui si riconosce il modo di attraversare il dopoguerra della piccola borghesia occidentale, guarda decisa di fronte a sé, trascinando una bambina che invece, poco convinta, si volta indietro. Sembra come richiamata da qualcosa che la spaventa o che non vuole lasciare, questa figura più piccola ma già cooptata dallo spirito dei tempi, col suo abitino immacolato e la fascia tra i capelli in ordine. Eppure anche lei, pur incerta tra il procedere e l’osservare quel che lascia dietro sé, in realtà volge le spalle alla foresta in fiamme che riempie la copertina dei suoi rossi e arancioni sbiaditi, di un fumo che fagocita i neri segni di abeti in procinto di ardere. Prendendo in mano il libro, questa ossimorica giustapposizione di caos e calma ostinata lascia indecisi: l’“altro mondo” a cui il titolo si riferisce è quello in fiamme o è forse l’«inferno dei viventi», per dirla con Calvino, da cui le due figure umane sembrano emergere e verso cui, a un tempo, sembrano tendere?
Il primo capitolo del libro si intitola ‘Cartoline sbiadite’, a dimostrare come il collage in copertina, quasi di vecchie immagini di riviste tenute per anni in un cassetto a perdere colore, ricerchi proprio un effetto di spaesamento temporale. Un effetto di straniamento non lontano da quello che, secondo Šklovskij, sarebbe alla base della scrittura tutta, come strumento di interruzione dell’automatismo della percezione. Nelle pagine di Deotto si interrompe l’automatica percezione del mondo come sistema tutto sommato in equilibrio, multiforme sì, ma capace di resistere all’entropia universale. E si capisce che questa entropia è cresciuta troppo oltre la misura sotto la spinta dell’azione umana, al punto da avere avuto la meglio su molti mondi già scomparsi, in via d’estinzione oppure notevolmente alterati. Non a caso, l’autore si sofferma più volte sulla “solastalgia”, il senso di disorientamento causato dall’ansia climatica per cui risulta difficile trarre conforto (solace) dal luogo in cui si è cresciuti, provandone una nostalgia apparentemente immotivata, dal momento che questo luogo sembra simile a quello che era. Ma quello che era in realtà non è più, e questa «nostalgia di casa quando sei ancora a casa» – per dirla con Glenn Albrecht, che ha coniato il termine – raggiunge la realtà dei fatti molto più a fondo di quanto permetta l’osservazione della pura superficie.
Si sarà forse già percepito che l’argomentazione di L’altro mondo si sviluppa sovrapponendo due mappe interconnesse: una mappa materiale, fisica, geografica, e una cognitiva, psichica, neuronale. Deotto alterna con maestria le tappe di un viaggio intorno al mondo, e al tempo stesso al centro della terra, con l’analisi di quello che è il centro di ciascuno di noi, ossia quel garbuglio di cuore e cervello che spinge a pensare, capire, agire in modi spesso inadatti alla realtà del cambiamento climatico, o che questo stesso cambiamento ambientale sta intaccando alle fondamenta. Le cartoline disegnate in questi tragitti multipli sono mentali tanto quanto connesse alla realtà di paesi diversi, che l’autore ha visitato in prima persona per cercare di vedere con i propri occhi, e restituire con le proprie parole, la vita in un pianeta che cambia. E in questo primo freddo autunnale che segue un’estate di viaggi ineguali quanto mai prima, in cui il Covid ha fermato alcuni più di altri, collezionare cartoline come queste, che aprano gli occhi su una realtà in transito più di quanto si immagini, non può che fare bene.
Lo stesso Deotto affronta con lucidità la connessione inscindibile di crisi sanitaria e crisi climatica che sta caratterizzando i tempi recenti. Descritto con efficacia (straniante, verrebbe da ripetere) l’arrivo del virus sars-cov-2 in Italia, così come è stato percepito e rappresentato dai media negli ultimi giorni del febbraio 2020, ossia con uno schizofrenico passaggio dalla minimizzazione al panico, l’autore ne sviluppa un ragionamento sul cosiddetto bias di normalità. Questo bias, in base al quale la media delle persone tende a sottovalutare le conseguenze di un evento catastrofico perché abituata a non immaginare che la propria condizione possa cambiare drasticamente, è uno dei numerosi meccanismi cognitivi, discussi nel libro, che sarebbero alla base dell’incapacità umana di reagire al cambiamento climatico con forze e tempismo proporzionati al rischio.
Tra le altre dissonanze cognitive che rendono più facile adattarsi al cambiamento che reagire nella misura necessaria c’è l’amnesia ambientale generazionale. Secondo questa che in inglese è conosciuta come shifting baseline syndrome, «ogni generazione aggiorna la propria idea di normalità in base al mondo che si ritrova a osservare» sin dall’infanzia (130), col risultato di considerare “normali” ambienti e (dis)equilibri che in realtà erano del tutto diversi anche solo qualche generazione addietro. Una sindrome particolarmente pericolosa poiché, essendo attiva in modo trasversale tra scienziati e politici, li inibisce subliminalmente dal proporre cambiamenti davvero radicali in fatto di ambiente. C’è poi la tendenza a essere temporalmente pessimisti e spazialmente ottimisti, «cioè a credere che le cose peggioreranno in futuro, ma anche che la situazione sia nettamente più sicura nel posto in cui ci troviamo» (128), col risultato di procedere miopi secondo linee di “sviluppo” i cui danni si pensa ricadano intanto su altri e altrove. E c’è la difficoltà di accettare il concetto di “fine”, la cui problematicità ho cercato di delineare mercoledì insieme ai miei personali dubbi sulla necessità di pretendere la salvezza dall’estinzione.
Quel che costituisce un vero punto di forza di questa analisi delle azioni e reazioni connesse all’ansia climatica è, a mio parere, l’inclusione di nomenclature e ontologie non occidentali. Non solo Deotto sottolinea come la gran parte degli studi scientifici, tra cui quelli legati all’eco-ansia, venga condotta su una tipologia di persone ristretta e quindi tutt’altro che rappresentativa della complessità umana globale (si parla in gergo di weird, ossia Western Educated Industrialised Rich and Democratic [people]), ma egli stesso arricchisce il proprio (e il nostro) bagaglio di nozioni prendendo in prestito da alcune culture indigene termini che descrivono meglio di altri gli effetti psicologici del cambiamento climatico. Gli indiani hopi, ad esempio, parlano di koyaanisqatsi per descrivere la perdita di equilibrio di una specifica condizione di vita, mantre gli inuit dell’Artico «hanno riadattato in chiave ambientale il termine uggianaqtuq, un tempo usato per indicare un conoscente che si comportava in maniera strana» (158).
Del resto, se la biodiversità si rifugia nelle zone marginali, intersiziali, in quello che Gilles Clément ha definito “Terzo paesaggio” (e che Laura Pugno, in chiusura di In territorio selvaggio, ha suggestivamente proposto come corrispettivo della poesia nel mercato editoriale contemporaneo), è proprio da un decentramento di prospettiva che può derivare l’apertura a saperi ecologici tanto nuovi quanto ancestrali. Per uscire dallo stantio provincialismo eurocentrico e cartesiano, che si prendano dunque in considerazione anche i margini etnici e culturali, come fa Deotto ampliando con intelligenza quelle che Harari definisce “reti intersoggettive di significato”. Se il mondo che credevamo lanciato in un ideale progresso verso il meglio e verso il più si sta sfaldando in un sempre peggio e sempre meno, che si moltiplichino gli sguardi su queste sfaldature, non sia mai ci si imbatta in modi diversi di guardare ai frantumi, non sia mai si scopra che un vaso rotto potrebbe essere riparato con l’oro, come nell’antica e paziente arte del kintsugi giapponese. A questa pluralità di sguardi Deotto non si sottrae, ma anzi si sottopone con vorace curiosità, modellando intorno ad essa la propria trattazione.
Del resto l’elemento più caratteristico del libro è proprio l’andare e venire tra Oriente e Occidente, tra prossimità e lontananza. Si parte da un rovesciamento dell’immagine da sogno (o da cartolina) delle Maldive, «un paese con la data di scadenza» e forse uno tra i primi a poter essere completamente inghiottito dall’oceano. Se ne descrivono i fenomeni di subsidenza e di sbiancamento dei coralli in progressiva accelerazione, così come le falde prosciugate, le spiagge mutilate e le isole-spazzatura traspiranti diossina. Sembra di ascoltarne macabre le campane a morto nel primo capitolo e soprattutto, in una Ringkomposizion tanto raggelante quanto efficace, se ne sentono risuonare i rintocchi nell’ultimo capitolo, il più familiare e forse per questo più triste: quello su Venezia, la «città-souvenir» che rischia anch’essa di sprofondare e portare con sé secoli d’arte e di storia. Dal 1987 a oggi, nota Deotto, Venezia si è abbassata di 30 cm, di cui 12 causati dallo sprofondamento delle sue isole (la stessa subsidenza che sta corrodendo le Maldive) e 18 dall’innalzamento dei mari. E mentre il mose rappresenta a pieno l’inadeguatezza e l’immobilismo di agende politiche focalizzate sull’oggi, oltre che l’incapacità di affrontare un fenomeno complesso con una visione parimenti complessa e diversificata, Deotto discute possibili approcci sperimentali alla tutela di questa città, che forse si inizierà a salvare solo quando se ne sarà compresa la mobilità, quando si capirà che ciò che è considerato intoccabile è in realtà anch’esso frutto di lunghi e complicati adattamenti.
L’autore si sposta anche negli Stati Uniti, la culla di quel sogno occidentale di crescita infinita e infinito accumulo di ricchezze a cui non vengono sottratte critiche necessarie e ragionate. Visita Miami Beach, con i ripascimenti costanti e la puzza di sargassi che dalle cartoline non sono percepibili, così come ne sono esclusi i processi di segregazione e gentrificazione climatica qualche chilometro di qua dal mare. Racconta la storia dell’assurda guerra dichiarata dai coloni francesi al Mississippi con una hybris che, contando inizialmente sulla manodopera schiavizzata afroamericana, non si è placata nel tempo. Questa ha infatti portato a costanti tentativi di irreggimentazione di un fiume il cui bacino idrico costituisce un terzo del territorio degli Stati Uniti – e che per ciò stesso non ammette alcuna struttura rigida di controllo; ha innescato la fondazione di una città, New Orleans, che si trova 4,6 metri sotto il livello del mare, e che continua a sprofondare; ha posto le basi per catastrofi come l’uragano Katrina, che in fondo di naturale hanno ben poco. L’autore si sposta poi in Texas, dove si confronta con un climate denier, ma dove ha anche modo di parlare di movimenti come 30×30, che «propone di rendere inviolabile il 30% di terre e oceani entro il 2030» (139), o come Nature Needs Half, che punta al 50% entro lo stesso anno.
Un ulteriore pregio del libro è infatti la capacità di produrre una critica non nichilista, bensì capace di aprire a prospettive alternative, oltre che di fare apprezzare, nel tragitto, la bellezza di un mondo a cui si sente di essere legati nel profondo e come di dovere qualcosa: un rispetto diverso, una diversa attitudine meno gerarchica e vorace di quella oggi dominante. Tra le aperture su un futuro più equilibrato ci sono le riflessioni sui diversi modelli di città verdi che stanno occupando da tempo architetti e urbanisti di tutto il mondo, con proposte che vanno dalla “città-giardino” di Howard all’“architettura organica” di Wright, dall’“arcologia” di Soleri all’“agopuntura urbana” di Hernández e Casanova. In un capitolo che torna in Italia, tra Franciacorta e delta del Po, si discute di vertical farming, di coltivazione idroponica e agricoltura rigenerativa, pur dopo aver attraversato terre fortemente intaccate dall’innalzamento delle temperature, dall’imprevedibilità del corso delle stagioni e delle precipitazioni, e da fenomeni chimici in tilt.
Si vorrebbe dire, se la formula gramsciana non fosse abusata, che il saggio di Deotto coniuga con maestria pessimismo dell’intelligenza e ottimismo della volontà. L’autore non illude con facili soluzioni, né deprime con strade senza uscita. Percorre il libro un senso di concretezza intransigente, di lucido riconoscimento del diverso grado di responsabilità dei singoli e, soprattutto, degli interessi finanziari di settori come quello del petrolio, del carbone o del cemento. Vi si avverte costante un informato approccio intersezionale al discorso ambientale, che raccoglie nel suo procedere riflessioni sul razzismo endemico dell’occidente, sui fenomeni migratori e sulla necessità di un pensiero complesso. Soprattutto, si legge tutto questo con la curiosità e il coinvolgimento che suscitano le migliori narrazioni. Perché il saggio è anche narrazione, storia, storie, bellezza e orrore, fascino e repulsione.
Se mai un salvataggio fosse possibile o auspicabile per la specie umana, che lo si cerchi dunque al di fuori di ogni ormai sorpassata dicotomia. Che si apra il dibattito ecologico a una costante e prolifica dialettica tra letteratura e scienza, prosa e poesia, accademia e discorso pubblico, Oriente e Occidente, umano e non-umano. Per tornare alle categorie di Benedetti, che la parola annunciatrice si faccia contaminare da quella suscitatrice e viceversa, che i dati si trasformino in storie e le storie in nuove e radicali visioni dell’oggi e del domani. Verso altri mondi e altri pianeti in questo stesso pianeta, verso altri modi di guardare alla realtà che ci facciano salvare dall’estinzione, sì, ma di pensiero critico.
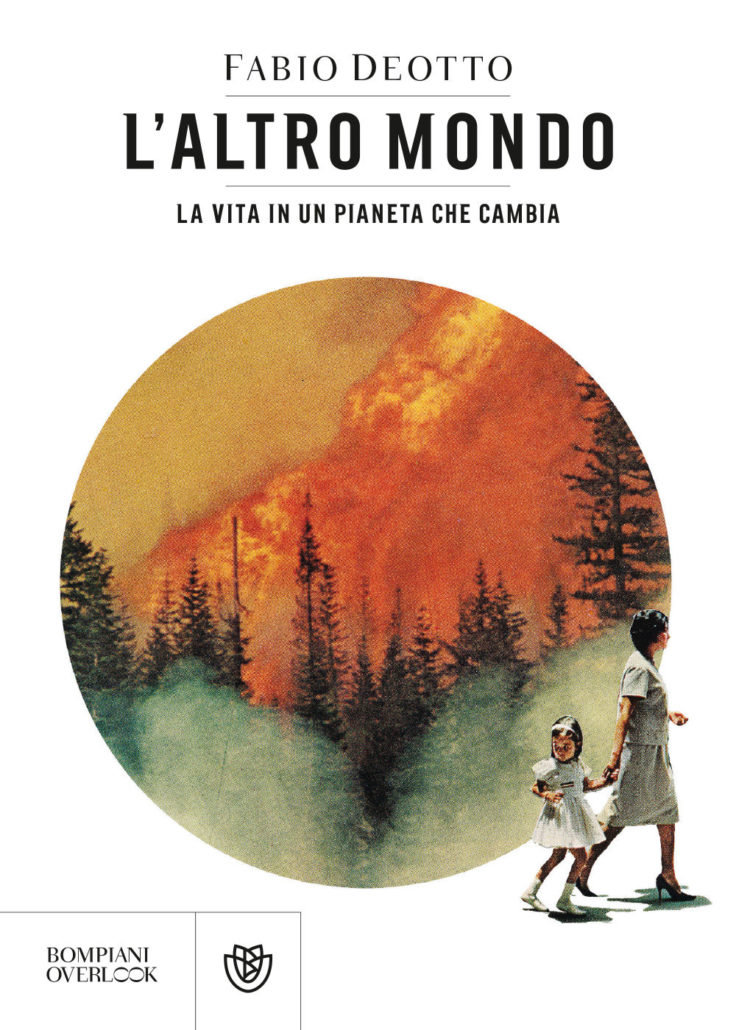
Fabio Deotto, L’altro mondo. La vita in un pianeta che cambia, Bompiani, Milano 2021, 336 pp. 19,00€