Fuochi di guerra e nervi scoperti in quattro poeti italiani contemporanei.
δρᾶμα ποιήσας Ἄρεως μεστόν
Aristofane, Rane
0. Introduzione [1]. La lunga assenza di una condivisa cartografia critica della poesia italiana dopo la metà degli anni Settanta – vale a dire dal Pubblico della poesia di Berardinelli e Cordelli [2] – implica, fra le altre cose, una relativa rarità d’interventi che coniughino l’approfondimento sistematico di alcuni autori con uno sguardo più panoramico, capace d’inquadrare le esperienze individuali in tendenze di lungo periodo. In particolare l’attività critica sulla produzione poetica più recente tende spesso a essere militantemente dedicata a una specifica scuola o linea, oppure a risolversi in operazioni di mappatura a largo raggio [3] che per loro natura non implicano uno studio ravvicinato dei singoli autori censiti e – forse anche per questo – lasciano spesso in ombra i criteri che hanno presieduto alla loro inclusione. Vi sono, certo, alcune felici eccezioni a questa tendenza, spesso guidate dal principio cronologico della ‘generazione’ largamente intesa; [4] si tratta d’altronde di un criterio che per sua natura non consente di seguire appieno lo svolgimento di temi e/o poetiche affini tra autori apparententi a generazioni diverse (ma contigue, e dunque almeno potenzialmente comunicanti). Ciò risulta invece più agevole quando il critico adotta un approccio tematico: a patto, però, che il suo esercizio non si risolva in un mero contenutismo, ma sfrutti il pretesto dell’argomento unificante per evadere dalle gabbie di una ripartizione cronologica o di scuola.
Dieci anni fa, ad esempio, un esteso contributo di Andrea Cortellessa [5] indagava il tema della “guerra virtuale” e “guerra reale” in un vasto ventaglio di autori che attraversava tutte le stagioni del secondo Novecento italiano, da Zanzotto e Fortini ai poeti del gruppo K.B., da Magrelli a un libro-chiave delle inquietudini di fine secolo come le notevoli Notti di pace occidentale di Antonella Anedda (1999). Prendendo l’abbrivio da alcuni versi zanzottiani della Beltà (1968) dedicati alla guerra, allora divampante, del Vietnam, il saggio rintracciava nell’opera di Zanzotto e dei molti altri autori studiati il problema della «guerra come inganno, simulazione, miraggio […], efferato concentrato di realtà della più traumatica […] ormai trasformata in risibile spettacolo mediatico, fantasmagoria di simulacri» (p. 109). Quasi tutti i poeti chiamati in causa trattavano infatti, con varietà di toni ed espedienti stilistici, di conflitti a loro contemporanei (dal Vietnam, appunto, alle Falklands, dall’Iraq ai Balcani). Un secondo filone indagato dal saggio era invece quello delle cicatrici lasciate tanto nel paesaggio italiano quanto nelle storie famigliari da guerre ormai distanti (i due grandi conflitti mondiali), vissute dalla generazione dei padri o dei nonni, e dunque non attingibili per gli autori se non attraverso la mediazione della memoria (preoccupazione, questa, come noto già centrale nello stesso Zanzotto). Tema evidentemente affine al primo, in quanto sempre di esperienza indiretta e mediata si tratta.
Lo studio di Cortellessa si arrestava alla data-spartiacque dell’11 settembre 2001, sia perché a quell’altezza cronologica non risultava ancora un apprezzabile impatto degli avvenimenti sulla poesia italiana, sia perché la natura stessa delle guerre nel terzo millennio sembrava porre interrogativi epistemologici nuovi. Lo spettacolare abbattimento in diretta TV delle Twin Towers rappresentava infatti il culmine della sostituzione della “riproduzione” all’evento, o al contrario «un ritorno a piene forze del reale in un mondo divenuto virtuale»? Il critico ipotizzava, in conclusione, che un simile dilemma fosse malposto: la vera novità consisterebbe nella nascita di una guerra mediale in cui sono le immagini stesse ad assumere «il valore e la funzione, a tutti gli effetti, di armi da guerra». Chiunque può constatare come gli avvenimenti degli ultimi dieci anni – fra video di decapitazioni ISIS ad altissima risoluzione con scialo di virtuosismi registici, foto di bambini siriani senza vita su una spiaggia turca che diventano meme virali, e crisi diplomatiche sfiorate per qualche tweet imprudente – abbiano inverato oltre ogni dire la (non difficile) profezia. Secondo Cortellessa, per adeguarsi alla mutata situazione la poesia avrebbe dovuto «acquisire nuovi paradigmi […] oppure tacere». Vale dunque la pena riprendere l’indagine a un decennio di distanza, per verificare quanto e come gli autori più recenti abbiano affrontato la sfida che si poneva loro innanzi; ma anche per verificare se effettivamente il problema della rappresentazione mediatica del conflitto sia stato superato dalla trasformazione in arma dei media stessi, o se piuttosto ne risulti acuito.
Il presente contributo vorrebbe tentare di assolvere, almeno in parte, a questo compito, tramite un paragone fra autori contemporanei rappresentativi di poetiche assai differenti ma accomunati da temi molto simili a quelli studiati nel saggio di Cortellessa: la guerra, una guerra tipicamente lontana nel tempo e/o nello spazio, e il suo impatto sulla coscienza e la memoria di chi non si ritrova a viverla in prima persona, bensì mediata da ricordi storici, o famigliari, o dai mezzi di comunicazione. Tutti i poeti da me studiati hanno trattato a modo loro queste tematiche in parti importanti della loro opera, e quasi tutti, pur appartenendo a generazioni diverse, lo hanno fatto dopo la soglia epocale dell’11 settembre – fa eccezione il solo Valentino Zeichen, del quale prenderò in considerazione alcuni versi apparsi nei primi anni ‘90 che non erano, comunque, trattati da Cortellessa. Rispetto a quest’ultimo, dunque, ho scelto di restringere lo sguardo su un numero decisamente minore di autori, nella speranza che la loro eterogeneità anagrafica e stilistica renda comunque il campione sufficientemente rappresentativo, e che in compenso mi sia consentito di soffermarmi ancor più analiticamente sulle soluzioni linguistiche di ciascuno. La mia tesi è infatti che tutti i poeti in questione abbiano cercato di affrontare il difficile tema bellico in modi innovativi e non retorici – per quanto, va da sé, con diversi tassi di successo. Solo mediante un’indagine testuale approfondita si può sperare di cogliere lo specifico della strategia di ciascun autore senza affidarsi a etichette di comodo quali “lirica” o “avanguardia”.
Il saggio è in qualche modo bipartito, sebbene non rigidamente: a una prima parte (sezioni 1-2) dedicata a un significativo esponente della linea avanguardistica, seguono alcune sezioni (3-7) in cui si effettua uno studio comparato di tre poeti certamente non inseribili in tale linea e perciò superficialmente più simili nel loro approccio. Infine, nell’ottava e ultima sezione si cercherà di trarre qualche conclusione di merito e di metodo dalle indagini svolte.

1. Ipotetica frizione con la guerra: Fabio Teti e la rimozione del conflitto. Molto istruttivi per la collocazione critica di un poeta sono i titoli scelti per le sue raccolte. Fabio Teti, uno dei più attivi e importanti esponenti della poesia “di ricerca” italiana, ha battezzato la sua recente silloge spazio di destot (Viareggio, dia·foria/Cinquemarzo, 2015), con un termine tecnico anatomico che indica propriamente una parte del polso, ma che l’autore impiega in riferimento allo spazio fra ulna e radio, quello in cui secondo alcune ricostruzioni contemporanee (suffragate anche dalla sindone di Torino) si facevano passare i chiodi della crocifissione. Il tecnicismo attinto al linguaggio scientifico, l’interferenza polisemica tra la sfera medico-corporale e il richiamo (per quanto indiretto e oscuro) alla figura cristica, sono tutte marche riconoscibili della scrittura di area avanguardistica. Ma ancor più programmatico, almeno per quel che riguarda la poetica specifica di Teti, è il titolo di una raccolta rimasta finora inedita, per quanto diversi componimenti siano circolati nel web durante gli ultimi anni: nel malintendere (2007-2012). Teti, infatti, si è già segnalato agli occhi della critica come araldo dell’incomunicabilità, del nesso irrimediabilmente spezzato fra la parola e il suo referente; secondo la formula d’Andrea Inglese, la sua è «poesia come discorso inceppato», [6] mentre per Giulio Marzaioli «la scrittura di Fabio Teti conta nel proprio genoma cromosomi votati alla frattura». [7] Il mal(e)intendere è leggibile, però, anche come ‘intendere il male’: questa scrittura mostra infatti una sensibilità acutissima, quasi morbosa, per l’ingiustizia e il dolore.
Un primo saggio a stampa della maniera di Teti è stato, al di là delle pubblicazioni in rivista o su volumi antologici, l’ormai quasi irreperibile b t w b h. frasi per la redistribuzione del sensibile (Roma, La Camera Verde, 2013), presentato come estratto (anzi «trailer meno che asintotico, ripartizione fra le molte – non le infinite – possibili», giusta la Nota dell’autore) dalla silloge maior. Qui il poeta si presentava già al culmine stilistico del suo virtuosismo autodemolitorio; e certo la sua scrittura è un congegno così ostico e complesso che darà molto da lavorare a ogni critico che vorrà smontarlo. Non è possibile in questa sede esaurire le questioni che la sua opera solleva. Il mio percorso di lettura batterà solo alcune delle strade possibili: in questo caso, un sotterraneo sentiero di guerra.
Bisogna intanto osservare che il dibattito critico più interessante sulla poesia di Teti va cercato, oltre che in saggi o prefazioni, nei commenti ai suoi testi pubblicati su internet, e in particolare nelle repliche dell’autore stesso, sempre articolate e generose nell’offrire quegli spunti interpretativi, quei chiarimenti dei presupposti teorici che tornano particolarmente utili nel caso di una scrittura in sé così criptica. Così, alcuni anni fa su «Nazione Indiana» Massimo Bonifazio leggeva in una selezione di testi da nel malintendere «la violenza della storia, e insieme del quotidiano: calata in versi che la sottraggono all’abitudine e alla banalità dei telegiornali e del linguaggio comune, facendola passare direttamente per i “quaranta / e più chilometri di nervi”». Questa osservazione piaceva all’autore stesso, che la faceva propria rivendicando per sé «un approccio nervoso al discorso (al mondo) che devo supporre alla base di questa scrittura e che più spesso è stato invece addebitato – magari per l’assenza di eloquenza ed esibizione – ad aridità e intellettualismo». [8] Mi pare utile partire proprio da questo scambio per tentare un approccio alla poesia di Teti che non s’infranga subito sullo scoglio dell’incomprensione.
Come lo stesso Teti suggerisce nella Nota di p. 29, il titolo b t w b h si rifà a due serie di collages dell’artista americana Martha Rosler, entrambe battezzate House Beautiful: Bringing the war home. Se ne deduce che il suo b t w b h varrà quindi, con lieve alterazione, bringing the war back home. Le opere della Rosler affrontavano proprio l’artificiosa separazione fra la realtà cruenta della guerra in Vietnam e la quiete dei salotti americani; il montaggio mirava a superare polemicamente questa scollatura, riconnettendo «two sides of human experience, the war in Vietnam, and the living rooms in Amerika, which have been falsely separated». [9] La seconda serie, a decenni di distanza, era dedicata invece ai conflitti d’Iraq e d’Afghanistan – gli stessi che, per ragioni anagrafiche, non possono non abitare l’immaginario di Teti, e in particolare di questo libro, in cui la rimozione dell’esperienza bellica delocalizzata è tema centrale. Anche nei testi che meno insistono su questo punto possiamo infatti leggere del massacro, dei seviziati, del lager, o di quella foiba che l’autore ritrova anagrammaticamente nel proprio nome. Altrove, però, in alcuni dei testi più convincenti – forse, anche, perché comparativamente più decifrabili – della raccolta, questo filone serpeggiante occupa decisamente il centro della scena. Vale la pena riportare la poesia di p. 22:
essendo poi lo stesso non sapere che sostanzia
i materiali e scarsi nessi della frase fase dove l’anno
non è quello e lui spalanca scatola in cui tiene
plastica ocra dei soldati, trovata vuota, trovate anzi
alcune parti di neviera lacune acacie poi la zucca
cava marcia coi barbieri
che in latino gli stenagliano
via i denti –
il solo fosforo vicino è alle lancette,
quando si sveglia. continua la torsione della faglia.
continua questa guerra
d’ipotetica frizione con la guerra
Il numero in esponente al v. 11 rimanda, come in diverse altre poesie del libro, a una nota a piè di pagina dove altri versi espandono e chiosano il dettato. E se cruciale è la seconda strofa del testo per così dire principale, ancor più illuminanti riescono queste parole della nota: lui poi a che pro chiede se senza / lavoro un link gli scorta / il morto nella casa. Ecco dunque denunciato il fatale sfasamento tra fatti di cronaca (concreti, e sanguinosi, più che mai) e illusoria percezione della realtà, alimentata da media che occultano e mistificano quanto più sembrano porgere un contatto immediato e vivido con gli accadimenti del mondo. Patologo della parola, il poeta non esita a sfruttare anche le ambiguità lessicali per sottolineare questa generalizzata rimozione del dato doloroso dalle nostre case. Si noti, poi, che il v. 8 allude abbastanza vistosamente al Montale della Ballata scritta in una clinica (Hai messo sul comodino / il bulldog di legno, la sveglia / col fosforo sulle lancette / che spande un tenue lucore / sul tuo dormiveglia); [10] fra le marche tipiche della scrittura di ricerca c’è anche questo modo straniante e sinistramente parodico di alludere alla tradizione letteraria. [11] In questa memoria montaliana, certo non involontaria, è la polemica inserzione dell’aggettivo solo che incrina l’immagine originaria per lasciar entrare lo spiffero gelido della denuncia di Teti. Per ritrovare un fosforo meno innocuo di quello che illumina al buio le lancette dell’orologio, basta infatti sfogliare fino a p. 25, dove gli ultimi versi descrivono una sadica tortura che s’immagina facilmente (anche se non necessariamente) in una delle zone di guerra asimmetrica di questo secolo:
lì sarebbero le lampade
infilate, le chimiche, nell’ano,
le spaccate sulla pelle:
il fosforo che
brucia
A differenza che nel libro precedente, il quale – come si è visto – reca la guerra nel proprio stesso titolo, in spazio di destot il campo semantico del conflitto esterno (sociale, politico, militare) con le sue implicazioni affiora qua e là, ma non spicca quanto altri. In un suo appassionato e approfondito intervento, [12] Daniele Poletti individua come centrali alcuni altri campi: la nascita, il corpo, la frattura, la patologia e la morte; intersecati a loro volta con tre «sottoinsiemi […] di carattere enciclopedico, didattico-scientifico»: l’erbario, il bestiario, il lapidario. Il corpo di cui si mette in scena la passione e il disfacimento, come osserva ancora Poletti, è duplice: al tempo stesso corpo fisico dell’autore e corpo della scrittura (secondo una retorica fin troppo comune nelle odierne scritture avanguardistiche e non solo). Tuttavia, passando al setaccio le pagine si possono ritrovare diversi accenni alla sfera della violenza di stampo bellico, concentrati soprattutto nell’ultima sezione:
-
volete mangiare un silenzioso odiare i carri armati (p. 38)
-
volendo sparare […] nausea tracheale, bolo, filo spinato e infine acqua […] ha acceso la luna nella lunula mirino (p. 39)
-
per la gestione dei files dell’iraq nuvoloso (p. 46)
-
aria raid, centinaia che sono stati perseguitati (p. 47)
-
la rilevazione della fissione nucleare (ibidem)
-
unirsi alla sua propria munizione (ibidem)
-
un marine ingaggiato per uccidere beckett (p. 48)
Non è solo questione di lessico; in un certo senso, la pagina tutta di Teti è un campo di battaglia. Per rendere questo senso di strazio del mondo e del rapporto fra mondo e soggetto, il poeta mette in atto un efferato «strazio della lingua […], finemente intarsiata di cluster microtonali, finte ripetizioni […], implosioni lessicali e lampi improvvisi» [13] tramite il «ricorso a strumenti di rottura della frase […] dalle sottrazioni agli anagrammi, dai rimandi fonetici a quelli ritmici e persino l’uso della punteggiatura [che] sembra opera di un disegnatore di puzzle» [14]. Spiccano infatti, anzitutto, diversi espedienti tipografici: parentesi, puntini di sospensione, spazi bianchi – che nel verso se in acufèni . dovendo dirlo come lasciano un punto fermo isolato nel mezzo, come una maceria superstite; e persino un a capo a metà parola, iconicamente, in inte‑/rrotte, [15] dove la divisione viene fatta cadere nel punto sbagliato sia per la fonologia che per la morfologia, e risulta quindi tanto più stridente quanto più innaturale. Di fatto, nella sua scrittura Teti dispiega a larghe mani l’intero campionario delle strategie grafiche di sospensione e interruzione del discorso poetico recentemente studiate e catalogate, fra gli altri, da Elisa Tonani. [16] Se ciò è più immediatamente osservabile soprattutto nelle anemiche pagine di b t w b h, e se in spazio di destot predomina una prosa apparentemente più compatta, anche qui il testo di p. 24 – l’unico in versi, quasi fosse una summa e un temporaneo congedo dalla vecchia maniera – rappresenta una vera mise en abîme di tali tecniche; nello spazio di soli 11 versi vengono adoperati:
-
parentesi (tonde e quadre) a isolare parole o sintagmi all’interno del verso, oppure singoli versi all’interno del componimento;
-
spazi bianchi a distanziare le parole;
-
ipo‑ e iper-puntuazione;
-
due punti “sospesi sul vuoto” a fine componimento;
-
addirittura una correzione sopralineare.
e cosa sarà fatto (e come) di quanto
e quanto da principio è stato inflitto (contratto)
potrebbero le volte (non è dato)
sapere cosa ha avuto passo tra ulna e radio
[ quella uscita, di trifoglio, nella benna:
nella zolla che è rimasta nella benna ]
le volte (che reggono)
si reggono a raggiera su quel centro (tagliato)
diversione
come fosse la distruzione il solo ciclo
lembo strappato dal mentito dei limbi
e vera infanzia del possibile:

Un’altra tecnica ricorrente è la paronomasia, che a partire da una qualsiasi parola del dettato le accosta altri termini più o meno omofoni in una sorta di serie ecolalica (la distolta – la distorta – la distale; questo è guasto, il questo proprio; la somma che assonna; espiantati, non espiati; la cava cavia; e nel testo appena citato, lembo : limbi, ch’è al contempo anche figura etimologica). Simili insistiti bisticci tra parole foneticamente vicine non sono affatto rari nelle scritture d’avanguardia, e sono molto tipici, ad esempio, dello stile di Daniele Bellomi, come la critica ha già avuto modo di rilevare. [17] C’è però, con Bellomi, una differenza capitale: mentre nel poeta monzese la funzione dell’annominazione sembra quella di proporre un traino, un continuo gioco al rilancio, un alzare la posta fonica, in Teti l’impressione è più quella della balbuzie, del glitch, del minare il linguaggio distraendolo in uno specchio deformante fono-morfologico, come se ogni parola appena pronunciata fosse subito assillata dallo spettro del proprio doppio. Un critico estremamente attento al dato linguistico-formale, Davide Castiglione, [18] ha perciò contrapposto l’«estremo balbettio» di Teti alla «fluidità copiosa» di Bellomi, ravvisando in essi due estremi polari della scrittura “di ricerca”: da un lato, «l’interruzione quasi analitica, millimetrica, del discorso»; dall’altro, «l’indifferenziazione – il continuum dove tutto è sullo stesso piano».
Sintatticamente, poi, Teti è maestro tanto della frase monca, spezzata dopo un elemento congiuntivo lasciato ostentatamente in sospeso (o la testa senza corpo di; dei fatti fare, dei fatti fuori, taciuti dalla:; lo il, confonde: il che, di angoscia ancora), quanto dell’anacoluto sistematico che sterza il discorso dal suo corso previsto; e anche d’altre soluzioni, tipiche delle recenti scritture sperimentali (come gli avverbi in posizione attributiva: dei comunque necrofagi) o più personali, come la preferenza per l’aggettivo sostantivato che segue il nome a mo’ d’apposizione, quasi fosse un ripensamento o una precisazione, che si cumula spesso ad altri attributi (finire in un’amara schiuma; in una / ributtante; le lampade / infilate, le chimiche).
In spazio di destot molto parrebbe essere cambiato, a livello stilistico. In questo libro il discorso appare sì nervoso, spezzato, frammentato (soprattutto nella prima sezione, intitolata non a caso disfazione, e che appare redatta in un allucinato fantasma della lingua italiana), ma al tempo stesso più compatto, meno sbriciolato sulla pagina. Con l’eccezione dei versi di p. 24, [19] il testo si distende in ampi paragrafi di prosa, che al mero colpo d’occhio possono dar l’impressione d’una maggior fluidità del discorso. L’impressione è però illusoria: anche così, ciascun blocco di testo si rivela alla lettura un opprimente, disorientante labirinto dove a ogni passo ci s’imbatte in un muro che sbarra la strada alla comprensione. Anche laddove la sintassi più o meno regge sul piano strettamente grammaticale, sarebbe impresa vana cercar di seguire il filo logico del dettato; più spesso, comunque, interventi anche minimi (una parola omessa, un’interpunzione fuorviante) si occupano di sabotare la leggibilità. Né, a risarcimento del caos semantico, questa scrittura perviene a una musicalità sia pure dura e metallica, come accade col ritmo extraterrestre e inflessibile che sostiene i testi di un Bellomi.
Anche l’intervento bruto della tecnologia, d’altronde, viene sfruttato per iniettare nelle maglie del testo una dose di aleatorietà. Per spazio di destot, è l’autore stesso a descrivere [20] la genesi del testo che possiamo leggere: una raccolta di poesie scritte negli anni 2004/2005, dapprima distrutta e data in pasto a un software di cut-up, poi – con un ripensamento della strategia originaria – al traduttore di Google, passandolo per varie lingue prima di ritornare all’italiano (e prima, s’intende, dei successivi interventi dell’autore, non così balestriniano da affidare tutto il processo scrittorio alla macchina).
Insomma: costringendo il lettore a inciampare in ogni parola come in un sasso, disseminando temi e ragionamenti in disiecta membra che occorre riassemblare con procedimenti tra cabalistici e enigmistici, irritando in ogni modo i nostri nervi, il poeta vorrebbe costringerci a mettere a fuoco quel che normalmente sfugge alla vista; o ad ammettere, almeno, il problema d’una facoltà visiva costituzionalmente sfocata. Se Rimbaud lavorava a rendersi veggente, Teti lavora a rendersi strabico, sperando di disassare, col suo, anche lo sguardo del lettore.
2. La testa dentro il sacco: per una critica alle poetiche del caos. A lode della poesia di Teti, va detto dunque che egli riesce bene come pochi altri a rendere il senso d’impasse epocale d’una generazione «per cui» come osserva il poeta e critico quasi coetaneo Davide Nota [21] «il meccanismo storico non ha previsto alcun presente» mentre un mondo non più leggibile le si sgretola attorno. Se il proposito di Teti è fornire un’impressione pressoché tattile di questo stato di cose (di cui è parte anche il tema che qui interessa, cioè la rimozione dei conflitti che rodono il limes imperiale), e al contempo una sua severa denuncia, tale proposito non può che riscuotere piena simpatia.
L’obiezione, stilistica e ideologica al contempo, che si può fare a Teti è quella che si può rivolgere a tutto quel settore delle scritture contemporanee che si sforzano di raggiungere una calcolata afasia e/o asemanticità come rappresentazione, esplorazione, critica o denuncia di un’epocale crisi dell’efficacia comunicativa del linguaggio. Viene in mente un aneddoto di Filippo Scòzzari, un re della causticità che al minimalismo comunicativo ha sempre preferito un sulfureo ma chirurgico massimalismo. In previsione d’un viaggio in America di fatto mai realizzato, il fumettista – così racconta in quel capolavoro misconosciuto della memorialistica che è Prima pagare poi ricordare – passa in Comune per il rinnovo del passaporto:
Chiesi quando sarebbe stato pronto il documento. Circa un mese, risposero. Come un mese, feci sorpreso, ho sempre saputo una settimana. Certo, signore, mi fu risposto, ma siccome si teme un attacco delle BR abbiamo spento i terminali. Facciamo tutto a mano. Per paura di un attentato, l’attentato se l’erano fatto da soli. [22]
Ecco, la sensazione è proprio che, per paura del proprio stesso svuotamento o svilimento, il linguaggio di questi autori l’attentato se lo sia fatto da solo. Con risultati che possono essere comunque entusiasmanti per il filologo, il quale non vede l’ora di poterne raccogliere ed esaminare le frattaglie, ma rischiano di sortire effetti opposti a quelli desiderati presso altri settori del pubblico, già magro, della poesia.
Comunque, e pur con tutte le riserve del caso, una scrittura come quella di Teti risulta estremamente suggestiva come mimesi, come mappatura da dentro d’un certo disagio diffuso, e come documento potenzialmente storico di questo disagio. [23] I limiti di questa maniera, abbastanza visibili, non sono ragion sufficiente per disinteressarsene. Tuttavia, al di là del piano stilistico fin qui indagato, esiste un altro aspetto rischioso. Si tratta d’una tecnica impiegata dall’autore per riecheggiare argomenti d’attualità, scomodi e politicamente “caldi” senza dare a vedere di farlo.
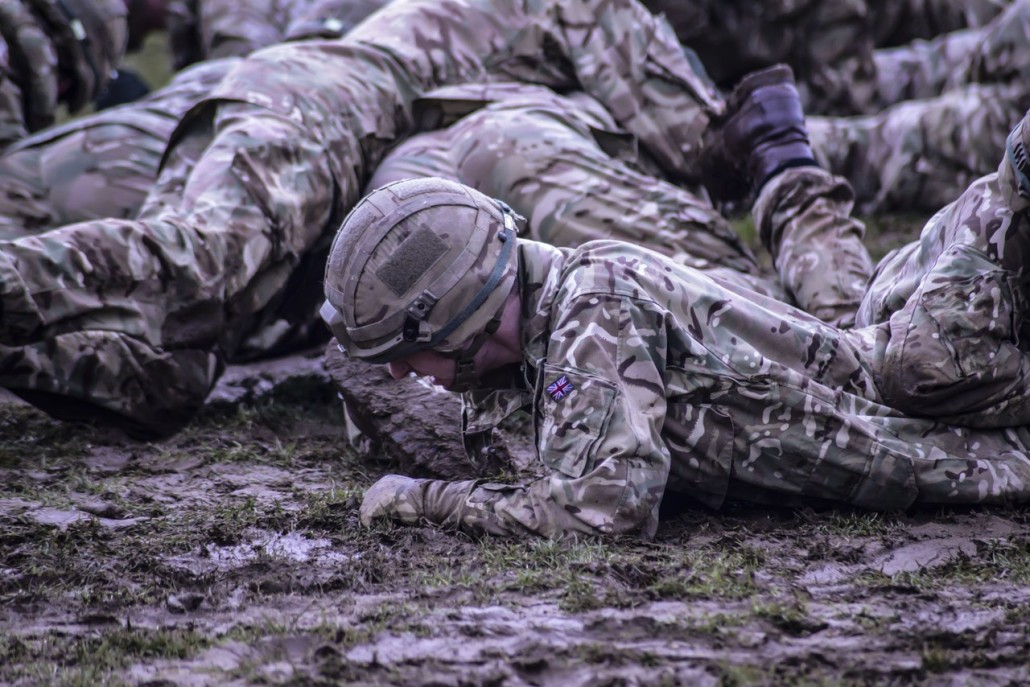
Si veda ad esempio come Teti gioca sull’asemantico dantesco, scrivendo citofono / sentito con il nervo, e sottovoce chi da dentro / «amècche, bengasi, zabí almi», dove la città libica si mescola alle babeliche parole di Nembrotte. Certo, c’è qui il poeta sperimentale che prende il la dalle parole del gigante, già misteriose e cariche di violenta minaccia (quasi un archetipo nobile della sua maniera enigmistica), per contaminarle con un sinistro, dissonante riferimento alla cronaca politico-militare più recente. È questa una tecnica abbastanza frequente in Teti: basti citare, sempre da b t w b h, i versi il router per falluja, / uranio e tolti gli occhi, la testa dentro il sacco; o ancora, da spazio di destot, i già menzionati files dell’iraq. Qualcosa di simile si può ritrovare in altri poeti di quest’area, come Simona Menicocci, che ad esempio scrive – di nuovo giocando su una facile memoria dantesca sarcasticamente incrociata alla cronaca – a null’amianto amar non perdona, in un testo peraltro tutto impostato sulla ricerca di simili equivoci. [24]
Questa tecnica consiste insomma nel lasciar cadere di soppiatto nel mezzo del testo – un testo già per definizione poco coeso, come accade normalmente in questa maniera stilistica – un nome, una parola-chiave che allude a qualche tragico fatto di cronaca (la guerra in Libia o in Iraq, i morti dell’Eternit). Il rischio è appunto che questo appaia un modo capzioso e facile per indicizzare gravi e complessi temi d’attualità con una sorta di tag inserito in una teoria asindetica di termini (che, perciò, potrebbe ad altrettanto buon diritto inglobare qualunque parola prelevata a caso dal dizionario) [25] e/o motivato dall’occasione tutta esteriore e fredduristica d’una paronomasia (amianto : amato). Sarebbe, in tal caso, un modo non meno retorico di trattare quei temi che affrontarli con ingenua enfasi oratoria – come se queste allusioni destrutturate dessero ipso facto valore di denunzia civile alla poesia che le ospita, salvando la capra della scrittura asemica e i cavoli dell’impegno.
La risposta sta però nell’intervento di Massimo Bonifazio ricordato più sopra: cioè nel rapporto fra i nervi, intellettualmente e stilisticamente parlando a fior di pelle, e il telegiornale, inteso come pervasiva, inevitabile presenza di una cronaca (sovente “nera” anche quando l’argomento è politico, economico, sociologico) che domanda una reazione possibilmente né di escapismo, né di accettazione, né di vuota indignazione. Per un poeta come Teti, troppo accorto per cadere in una di queste tre reazioni tutte ampiamente insoddisfacenti, un tentativo di soluzione formale è allora riprodurre nei propri versi la maniera surrettizia con cui tale cronaca agisce nelle nostre vite: chiacchiericcio televisivo, brusio origliato, sottofondo, [26] che varca solo a tratti la soglia dell’attenzione cosciente, s’infiltra nei pensieri e nel discorso senza essere veramente cercato e però senza che sia possibile eluderlo. In ogni caso raramente si giunge a una riflessione lucida e consapevole, quasi mai (finché è cronaca almeno geograficamente lontana da noi) a un impatto diretto con il problema, che costringa a prendere una posizione chiara e a trovare una plausibile quadratura fra violenza della storia (ignorata o mistificata, perché in apparenza lontana) e violenza del quotidiano (inavvertita, oscura, banalizzata). Teti ha la lucidità per diagnosticare questa mancanza di lucidità, e cerca quindi di metterla in atto nella sua pagina. Il problema che resta è proprio quello di una scrittura che, scommettendo forse troppo sui propri pur notevoli mezzi, vorrebbe essere al contempo mimesi di una drammatica impotenza e sua viscerale denuncia; ricerca dell’impegno e rinuncia all’assertività; drastico sovvertimento delle convenzioni linguistiche e pretesa di coinvolgere il lettore a un livello non ludico. Insomma: samizdat e rebus.