Giuseppe Genna cade; la sua caduta continua ad accadere. L’inabissamento, la precipitazione verticale. Il «Bosco che Sale» di History (Mondadori, 2017) è l’altrove della lastra fotografica, il negativo della Medusa, la patente di tenebra del padre di Medium (2007), la pietrificazione dell’oscurità artesiana del fondamentale Dies Irae (2006, 2014). Una caduta che continua da trentasei anni. Una tenebra in immersione: l’uomo che cade. Il fulminante incipit del thriller alchimistico Grande madre rossa (2004) racconta di una picchiata metafisica, un punto di vista che precipita sulla Terra, un’anima che schianta mentre s’incarna. Il punto d’impatto è sempre lo stesso, ossessivamente, da decenni ormai. È la speleologia artesiana, è il corpo di Alfredino Rampi, l’eterno bambino che da Dies Irae a Etere divino (2015) continua a tormentare Genna e la sua scrittura: nascita di una Nazione a fondamento di un’immagine, anzi, di un video, carta costituente debordiana.
Tutto accade nella mente, anzi, nella «testa»: sempre decollata, un teatro-che-cancella, dove dimora un «me stesso». Anche in History si cade. Una bambina estrapolata dalla cronaca nera italiana cade in loop nei video che una macchina artificiale trasmette a un pool di scienziati e umanisti riuniti in un Tecnopolo umano a Segrate.
Cosa racconta History? Nella Milano del 2018 uno scrittore «plurilicenziato, affannato» trova il suo ultimo lavoro: dovrà scrivere documenti per la mente artificiale creata nel Tecnopolo (nel libro questo arcipelago di scienza dimora nella sede della storica casa editrice). La mente artificiale è incuriosita da una bambina: History. Figlia di un tycoon, unica superstite di una gestazione gemellare che ha visto morire nei primissimi mesi di sviluppo il feto della sorellina Hillary, History è cresciuta nelle stesse acque dove giaceva, morta, la gemella. History, bimba dall’aspetto incongruo, selvaggio, danneggiata da una forma di «autismo assoluto».
È fra lei e la macchina che lo scrittore dovrà interfacciarsi. Lo scrittore è l’ultima interfaccia (anzi: l’ultima interfaccia è il romanzo stesso): sui suoi incontri con History e sulle reazioni della mente artificiale scienziati, filosofi, psicologi, ingegneri si radunano come un’assemblea di precari mortali davanti al tempio sacro della macchina.
Ma perché proprio uno scrittore?
L’antropologia digitale elude la lettura verbale […] Effettua continue richieste su prospettive analogiche. La descrizione è privilegiata. Non la narrazione. Ha sviluppato un atteggiamento per cui la descrizione contiene la narrazione, non viceversa. In molti tecnopoli sono stati arruolati narratori, sceneggiatori, soggettisti, romanzieri.
Descrizione di descrizioni.
History è un acceleratore di immagini: nei colloqui con lo scrittore che «non lavora, osserva» la ragazzina descrive tetri e lovecraftiani intrichi paesaggistici. «Le sue immagini pendono come arnie all’inferno, lei le vede tutte». In questi pannelli desolanti compare una «Trista Figura», che poco alla volta inizierà a ghermire vittime-bambini. Siamo tutti inconsapevoli adoranti del «bambino muto [che] non parla nessuna parola e è aureo in un buio assoluto»: tropo tanto di Alfredino quanto dell’infante spaziale che galleggia nella placenta del cosmo in 2001: Odissea nello spazio, «epica contemporanea» della quale History vuol essere una sorta di traduzione libresca.
Non più indicativo presente, ma presente accelerato, con un ritmo solenne e anfetaminico al tempo stesso.
Tutto il romanzo è scritto con una parola che appartiene al passato: «Privo di meta, attraverso storie che non si coagulano, qui non c’è plasma, soltanto occasione». E ancora: «Io così sono nella mia contemporaneità: sono fatto e parlo non ad arte, ma a telegramma».
Sono molti i globuli narrativi di questa opera fondata sul modello mitico del capolavoro kubrickiano, delle Upanishad e dei Salmi. Parlare di History non è facile anzitutto per via della sua struttura, del suo fraseggio. Se la vicenda riconosce molti debiti all’ultimo De Lillo, quello di Zero K, il racconto è di una alterità assoluta. Da molto tempo le sequenze narrative di Genna hanno cessato, diciamo grossolanamente dalle Teste (2009) in poi, attraverso Fine impero (2013), La vita umana sul pianeta Terra (2014) – ma già da Hitler (2008) –, di essere concatenate da raccordi di montaggio. Adesso i suoi pannelli, nei quali permangono idee di un divenire, obliterano tuttavia ogni divenire effettivo. La logica del racconto ha ceduto il posto alla logica dell’evento. Questa eventualità quantistica – non a caso si parla anche del «tempo di Planck» – raduna gli eventi in pacchetti discreti di energia narrativa, per poi diffonderli in onde probabilistiche che attraversano le pagine. Meccanica quantistica che fu già pratica scrittoria di T. S. Eliot: il suo «metodo barbarico», costruito intorno all’elisione dei passaggi, di modo da creare un effetto frammentario, fu utilizzato anche da Burroughs nel Pasto nudo (a questo proposito si legga Io sono Burroughs di Barry Miles, uscita per Il Saggiatore nel 2016). E la lingua di ogni frase riflette se stessa, la propria incapacità di raccontare quel “presente accelerato”.
Ma in realtà la domanda che dovremmo porci è: di cosa sta parlando davvero Genna? Certo, a un primo livello sta parlando di questioni centrali da un punto di vista sociologico o super-sociologico. Le macchine ci sostituiranno? Siamo già ologrammi di ologrammi? La farmacopea nanotecnologica, l’ibridazione tra biologia e inorganico sono imminenti? E come raccontare l’accelerazione dei tempi, la scomparsa del lavoro, del denaro, della sessualità, il Tecnopolo, l’abolizione dei bambini, i padri, in un tempo nel quale il libro è un oggetto desueto («Era, un libro fino a poco tempo fa, uno strano canale di flussi di verità conquistata di se stessi nel mondo, un’indicazione mobile, un orizzonte mobile, un accecamento»)? Come raccontare la «singolarità», «l’annullamento della morte biologica», il fatto che «migreremo su altri supporti con la nostra coscienza»?
L’autore draga i fondali dell’infosfera, per raccogliere schegge figurative: lascia interferire nella finzione del romanzo la figura cherubina del futurologo Raymond Kurweil, profeta a capo dei Google Labs. Inoltre utilizza nel ruolo della Trista Figura, lo Slender man, totem del terrore rivelato fra le pieghe iperbarocche di Internet, in sintonia con certe fluorescenze di santi folli dei teatri, per i quali sovente il palcoscenico è stato il corridoio psichiatrico, come Antonin Artaud. Si legge nel suo Teatro e la peste (all’interno del Teatro e il suo doppio, Einaudi, 2000):
La terrorizzante apparizione del male, che nei misteri di Eleusi avveniva nella sua forma pura, ed era realmente rivelata, corrisponde al momento nero di certe tragedie antiche che ogni vero teatro deve ritrovare.
Anche il teatro di Artaud è un degno produttore di Personaggi Vuoti come gli altri descritti da Genna nel documento circolato on-line, in formato word, dal titolo Il personaggio vuoto, di fatto poi confluito nel libro Io sono (2015). Una disamina intorno alle estreme articolazioni dell’umano, proprio laddove l’umano si «deterritorializza» (Deleuze e Guattari a proposito di Kafka) e dal vuoto appare senso. Dice Genna, a proposito di Giuseppina la cantante ovvero il popolo dei topi di Kafka, «il canto di Giuseppina sta tra l’essere qualcosa e il non essere qualcosa […] il canto il Giuseppina, che è un potenziale indeterminato, è. Giuseppina dà raffigurazione a una potenza che è e che può diventare qualcosa. Ma che non diventa qualcosa».
E in un’intervista a Luca Romano, a proposito di Io sono e del rapporto fra tragedia, Nietzsche e Dionisio, Genna dice: «Dioniso è una potenza che fa parlare: non è vero che parla. Parla con finzione: la parola è finzione. Ciò che è tragico nel nostro tempo non è detto che sia tragedia. È necessario stare in ciò che non parla, nel nostro tempo. Quest’opera molto difficoltosa, che in immagine possiamo accostare al processo di denudamento in vista della nudità […] è lontano dall’epoché husserliana? Dal grande silenzio di meister Eckhart? Dall’esito parabolare kafkiano?» (in «Logoi.ph», I, 2, 2015).
Ciò che «non parla» è propriamente lo spazio che lo scrittore ricerca e indaga da sempre, comune a tutte le sue Macchine Vuote e alla tragedia.
Si legga ancora nel PV: «Il Personaggio Vuoto è il momento in cui lo scrittore accumula la potenza d’essere, mettendola in una forma esogena rispetto alla tradizione delle forme – una forma che esclude le interpretazioni tese a conchiudere, poiché il vuoto non è conchiudibile».
Dall’altra parte la tragedia, in quanto ritualità, ha bisogno di una finzione per attuarsi: la tragedia del linguaggio è il linguaggio stesso, che fronteggia la sua incapacità a narrare il vuoto, cioè quel momento atemporale nel quale si fa esperienza di sé. «Chiunque ha a che fare con la fine delle parole», dice l’ologramma di Raymond Kurzweil.
Ecco che il rito dei piccoli «robot senzienti», altri piccoli fantocci artaudiani, a foggia di sostituti-bambini, è uno sparagmòs, un delitto tragico e rituale che prevede l’uccisione di un animale, di un capro, di una vittima sacrificale. È questo lo spargimento di sangue richiesto dalla «singolarità».
Invito alla scomparsa: ecco l’abisso nel quale la caduta di Genna – dall’occhio incorporeo di GMR a quello di vetro nel quale trapassa il Novecento, l’occhio dell’avo ad apertura di History – è giunta.
La mente artificiale è una Macchina Vuota, accelera il momento nel quale «quando viene il tempo del racconto, è finito ogni racconto, che si racconta da se stesso, accadendo». Il tempo che verrà, un tempo dove siamo destinati a scomparire, sarà un tempo intensamente metafisico. A questo alludono le tavole d’istruzione nella sezione finale del libro, quel «Beyound Jupiter and the Infinite», (citazione dell’ultima parte di 2001, ma anche dell’Inland Empire di Lynch, nel sottotitolo «Estinzione degli imperi e della mente») dove Genna si trasforma in un Bardo per allestire il nostro oltremondo.
Ancora Genna nell’intervista a Luca Romano: «La stessa letteratura non è una pratica metafisica: può sortire esiti metafisici, […] quando essa veicola intuizione, che è silenzio, accadimento del vuoto (o dei ‘compossibili’ o della ‘totipotenza’ o della infinita generatività […]) […] Il vuoto dell’intuizione o del silenzio del pensiero è la sostanza stessa del pensiero e accade».
Del resto il racconto del vuoto è sempre stato al centro del lavoro di Giuseppe Genna. Vuoto è il Breivik della Vita umana sul pianeta Terra e supremamente vuoto è Hitler, vuoto è Guido Lopez del ciclo thriller. Questa è la letteratura dello scrittore milanese: una lenta ricognizione spaziale intorno a un prodigio nero, una scomparsa. Nella Milano del 2018, nel mondo del 2017 tutti noi siamo sull’orlo di quel momento di stasi assoluta, nel quale
la mente che è uno stormo di pensieri legati a un “me stesso” […] si arresta, si dorme per un istante rimanendo svegli, si sta, in un accenno zuccherino di beatitudine e santità, una mistica istantanea, ecco che quell’arresto della mente già è trascorso, si torna a respirare, ritorna il mondo, con la sua folata e lo sfrangiamento.
Se in Grande madre rossa la caduta calcificava un “me stesso”, con History e il suo oscuro finale, scritto su «lastre di oro mentale», finalmente lo libera, in quel silenzio dove «non siamo più niente».
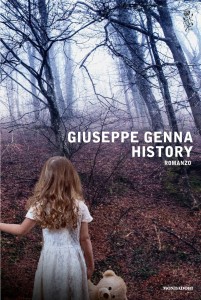 Giuseppe Genna, History, Mondadori, Milano 2017, 557 pp. 24€
Giuseppe Genna, History, Mondadori, Milano 2017, 557 pp. 24€